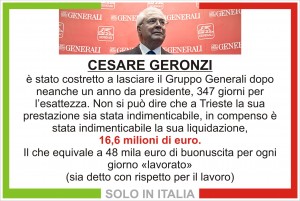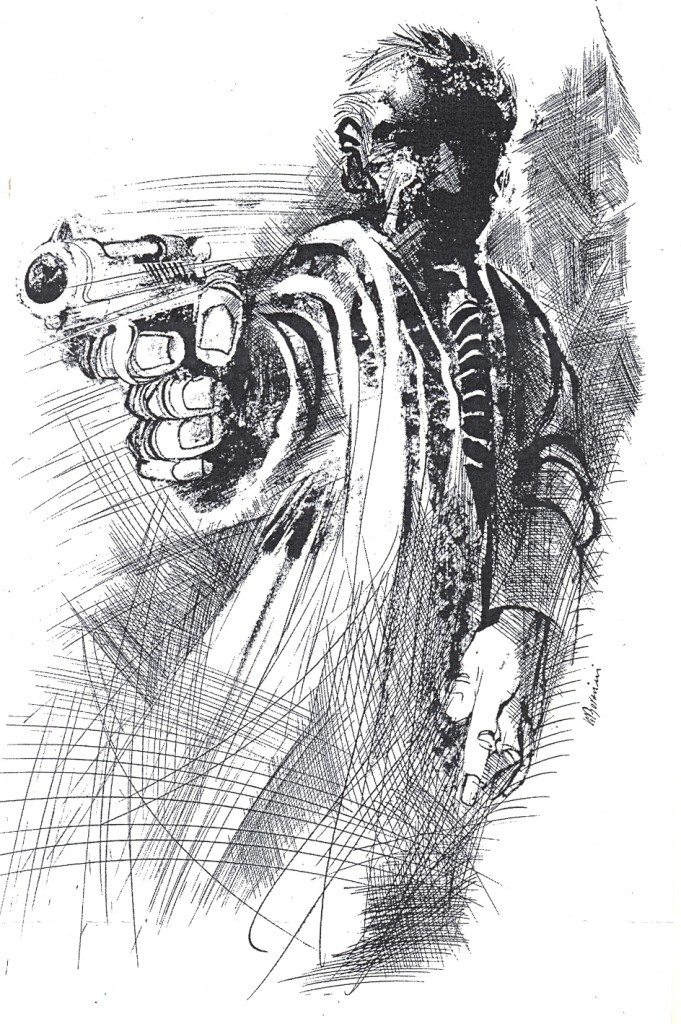C’è un nuovo canale in chiaro nel digitale terrestre che si chiama GIALLO ed è quello che lascia intendere, ovvero una sequela di bei telefilm gialli, taluni d’annata altri più recenti.
Troviamo infatti Ellery Queen interpretato da Jim Hutton, nonché Practice, gli avvocati d’assalto guidati da Dylan McDermott, una fortunata serie durata bene dieci stagioni.
Il palinsesto ci offre poi Squadra Emergenza, poliziotti e vigili del fuoco alle prese con i guai quotidiani, il recente Justice, nel nome della legge, uno studio di avvocati alle prese col delitto in una Los Angeles crepuscolare, e con delle tematiche, una per esempio dopo l’uragano, che tutto distrugge ma che fa anche emergere cadaveri morti per ammazzamento.
Questo mai troppo poco lodato canale Giallo ci propone altre serie cult che ci hanno conquistato negli anni, come il mitico Matlock, l’avvocato gigione e un po’ burlesque interpretato da Andy Griffith,  l’indimenticabile interprete di “Un volto tra la folla”.
l’indimenticabile interprete di “Un volto tra la folla”.
Alfred Hitchock presenta storie già proposte in bianco e nero ma rigirate a colori (e non ricolorate), poi Giudice Amy, con Amy Brenneman, la poliziotta dei primi episodi di N.Y.P.D,  quelli con David Caruso e Tyne Daly, anche lei poliziotta partner di Clint Eastwood nel “Cielo di piombo per l’ispettore Callaghan”.
quelli con David Caruso e Tyne Daly, anche lei poliziotta partner di Clint Eastwood nel “Cielo di piombo per l’ispettore Callaghan”.
Essendo ancora agli inizi il canale deve ancora ben svilupparsi, ma la partenza
è stata più che buona e i propositi sono molto interessanti. Da seguire con attenzione
Sezione del blog in costruzione.
Ripassate tra qualche giorno!

Eccovi i dieci fumetti più venduti in marzo 2012 negli States:
1. Avengers vs X-Men 1 (Marvel)

2. Avengers vs X-Men 0 (Marvel)
3. Justice League 5 (DC)
4. Batman 7 (DC)
5. Avengers Assemble 1 (Marvel)
6. Action Comics 7 (DC)
7. Green Lantern 7 (DC)
8. Detective Comics 7 (DC))
9. Batman the Dark Knight 7 (DC)
10. Superman 7 (DC)
Fonte Diamond – maggio 2012

finalmente il giallo completo
 Vi propongo, finalmente in ordine cronologico, nota dopo nota, un giallo di Luciano Secchi che mi ha entusiasmato. È il suo primo romanzo che Oreste del Buono ha fortemente voluto per la Milano Libri. Ormai è esauritissimo (la prima edizione è del 1975) e mi spiace non condividerlo con i miei amici del te delle cinque. Ecco come l’editore ha presentato il libro con le note in quarta di copertina:
Vi propongo, finalmente in ordine cronologico, nota dopo nota, un giallo di Luciano Secchi che mi ha entusiasmato. È il suo primo romanzo che Oreste del Buono ha fortemente voluto per la Milano Libri. Ormai è esauritissimo (la prima edizione è del 1975) e mi spiace non condividerlo con i miei amici del te delle cinque. Ecco come l’editore ha presentato il libro con le note in quarta di copertina:
«NOVE BATTUTE PER UNA PIÈCE nasce e si sviluppa come un romanzo d’amore, amore tradito, deluso, eluso, e la successione di delitti che ne costituisce la tessitura serve, si direbbe, solo a reintegrare quell’amore frustrato. Luciano Secchi, studioso di storia ed autore di oltre cinquecento sceneggiature per fumetti, ha rifiutato programmaticamente le regole che di solito si ricollegano alla letteratura “gialla” eppure è difficile immaginare un romanzo giallo più di questo costituito secondo uno schema intellettuale, logico fino all’assurdo, lucido sino al delirio».
Naturalmente per arrivare alla fine dovrete aspettare almeno nove battute, meglio così, la soluzione della pièce sarà più emozionante!
NOVE BATTUTE PER UNA PIÈCE
romanzo di Luciano Secchi
La prima nota
La porta del camerino venne spalancata di colpo. Sulla soglia apparve un giovane dai lunghi capelli albini col viso arrossato.
– Presto Marco, tocca a te!
– Arrivo, arrivo!
Incollato allo specchio, un uomo sulla quarantina stava aggiustandosi il trucco delle ciglia. Ebbe un motto di stizza e pronunciò qualcosa a bocca serrata. Afferrò deciso un bastoncino bianco spruzzato di rosa pallido per passarselo sulle labbra.
Dopo essersele serrate per un attimo, osservò la donna che sedeva nell’angolo della stanza sopra uno sgabello di fortuna.
– Vado bene? – domandò ansioso.
– Meravigliosamente! – rispose l’interrogata senza entusiasmo.
Il teatro di posa era affollato dai soliti addetti ai lavori. Le luci erano piazzate su un palchetto dove troneggiavano un letto, un comodino e alcune sedie disposte secondo una precisa scenografia. Il ciacchista era pronto a entrare in azione mentre il regista, un uomo corpulento con un megafono stretto nella mano, si dimenava su una sedia, girando sempre il collo in direzione del camerino degli artisti.
– Ma allora questo divo, arriva? Siamo già in ritardo di un quarto d’ora! – ringhiò mentre, scartata una gomma da masticare, se l’infilava in bocca con un gesto meccanico.
Marco salì sul set camminando a brevi passi, il corpo bene eretto e lo sguardo fisso in avanti.
– Arriva Eleonora Duse – disse qualcuno sghignazzando alle spalle del regista che ridacchiava pure lui.
– Ah, bravo Marco, e la giacca? Dov’è la giacca? – tuonò il direttore vedendolo restare impalato come uno stiliforo con indosso solo una camicetta rosa a fiorellini azzurri.
– Oh sì, la giacca – sospirò come svegliandosi improvvisamente da un lungo sonno. – Trovarobe, la mia giacca! – squittì schioccando le dita.
L’incaricato l’aiutò a indossare il capo con fare di scherno che non intaccava la ieratica figura dell’attore. Marco diede due colpi al bavero come per allontanare della polvere, poi si schiarì la voce.
– Sono pronto!
– Vedo che sei pronto, alla buon’ora! Adesso cerchiamoci di non perdere ulteriore tempo. Avanti, adagiati sul letto. E sbrigati! – Il regista si controllava a fatica.
– Che cosa sciocca indossare una giacca per poi sdraiarsi sul letto. A me pareva più logico stare in camicia – flautò con una vocina leggera e studiatamente modulata.
– Ah, Marco, non incominciare a rompere. Sulla sceneggiatura c’è scritto così, e così si fa. Poi magari te la vedi tu con l’editore.
Il regista sbuffò come un mantice. Fu come un segnale. Nessuno fiatò più. I suoi occhi rotearono rapidamente intorno per dare un leggero cenno al ciacchista che prontamente eseguì il suo lavoro.
– Amami teneramente, diciottesima – urlò battendo con violenza la barra.
– Azione! – tuonò il regista.
L’operatore alla macchina scattava diverse inquadrature con sincronismo, mentre la voce del direttore della ripresa guidava l’attore.
– Allora Marco, sei a letto, mettiti le dita sugli occhi. Non stai dormendo, ma pensando, ecco, così. Bene, adesso ti metti sul letto con l’espressione di chi è tormentato da un atroce dubbio: mi ama ancora o non mi ama più?
Il silenzio scese ancora per alcuni secondi, infranto solo dai vari clic della macchina fotografica per venire infine frantumato da un boato.
– Nooooo!
Il regista balzò sul palchetto con agilità insospettabile per la sua mole e si fermò a pochi centimetri da Marco.
– Ma quella è l’espressione di una pena d’amore? Occhi sfavillanti, ti sei messo troppo collirio e un’espressione da ebete da fare paura.
– Al mio pubblico piaccio così! – rispose seccato chiudendo la bocca ad o tondo.
– Ma sentilo il Rodolfo Valentino. Il suo pubblico! Operaie e donne di servizio che comunque non si lasceranno sempre prendere per i fondelli da un imbecille come te! – urlò esasperato l’uomo.
– Imbecille, mi ha detto imbecille! – proruppe adontato Marco alzandosi di scatto. – Io non posso più lavorare con quest’energumeno. – E si allontanò a passettini brevi, ancheggiando lievemente, tenendo tutta eretta la persona.
– Marco, ma che fai? Vieni qui! – Da dietro le lampade sbucò dalla testa quasi calva col viso incorniciato da una spessa montatura, che gli si fece appresso cingendogli le spalle.
– Ma dai che siamo in ritardo. Dobbiamo finire per stasera. C’è il fotolista che fa gli straordinari per approntare le pellicole. Dovevamo uscire giovedì in edicola, e oggi è martedì, se ce la facciamo per sabato è un miracolo.
– No, no, no e poi no! – disse per risposta l’adulato mentre batteva ritmicamente il piede destro sul pavimento in sincronia con ogni negazione.
– Quello è un bifolco e non capisce niente! Non voglio più lavorare con lui, e mi tolga le mani di dosso per piacere!
Mentre Marco si dirigeva, mento puntato in aria, verso il suo camerino, uno degli elettricisti scosse la testa.
– Vanessa ha fatto la sua scena madre.
L’uomo con gli occhiali lo fulminò con lo sguardo girandosi nervosamente e si avvicinò a lunghi passi verso il regista.
– Mazzini, ma che fa? Possibile che deva sempre pungolarlo? Non può pensare a lavorare e basta?
– Ma dottore, che gli ho detto? Che la sua espressione non andava bene col testo. Qui c’è scritto “espressione accorata” e si legga un po’ le paroline che ci vanno dentro: “No, non posso vivere in quest’ansia, devo, devo sapere se m’ama ancora”. E quello mentre guarda nella macchina sbatte gli occhietti ammiccando. Mi dica un po’ lei come devo comportarmi.
L’uomo deglutì un attimo, poi prese a braccetto il suo sottoposto.
– Mazzini, vediamo di essere più elastici., Marco è un divo, ha un pubblico. È montato, sì lo so, è uno stronzo, ma vende. E noi accontentiamolo! Non formalizziamoci, lasciamo perdere, vediamo di finire questo benedetto fotoromanzo per stasera e amen.
– E va beh, dottore, come vuole lei, – il regista non era troppo convinto – ma mi dica u po’, anche se chi lo legge è uno sottosviluppato mentale, come può abbinare l’espressione ammiccante a quella con le parole “No, non posso viv…?”
– Mazzini! – lo interruppe il produttore con malgarbo – andiamoci piano col definire sottosviluppato il nostro pubblico. La nostra diffusione capillare ci permette di arrivare a diversi stadi di lettori. È pur vero che comprende operaie e domestiche, ma annovera anche seri professionisti.
– Sì, lasciamo perdere, ma poi a me non frega proprio niente. Sono affari del dottore. Io sono pagato per fare il regista di queste stronzate e lo faccio. Devo pur mangiare. Ma sopportare le bizze di quella donnetta eh no, dottore, non me lo può chiedere.
L’editore strinse i pugni. Il viso gli si avvampò d’un rosso purpureo. Stava per esplodere. Ma poi i suoi pensieri corsero la fotografo che aspettava le pellicole, ai montaggi del testo, alla stampa e ritornò normale.
– Va beh, lei stia qui, io vado a rabbonirlo. Vediamo di chiudere questa faccenda, poi domani ci diciamo quattro paroline in tutta calma.
– Come vuole lei dottore, anche otto. – E gli fece un segno con la mano alquanto significativo.
Marco stava facendosi spalmare il viso di cerone, aiutato da una inserviente quando, visto il suo datore di lavoro entrare nel camerino, si strappò un ciglio fisso.
– Ha sentito come mi ha trattato? È un essere volgare che deve essere allontanato. La gente compera le sue pubblicazioni per Marco Vinci e non per Lucio Mazzini!
– Stai calmo Marco, gli ho detto il fatto suo, ora però dobbiamo riprendere, dai che non manca neanche molto, in un’oretta finiamo e andiamo tutti a cena.
– Sì, io riprendo, – rispose stizzito l’attore – ma senza quella specie di regista. Via, via, via! Deve cacciarlo.
– Ma dove ne prendo un altro adesso? Guarda, ti assicuro che appena finito “Amami teneramente” lo licenzio. Sii ragionevole Marco, non ti ho sempre soddisfatto, non ho sempre mantenuto ogni promessa?
L’interrogato lo guardò dall’alto in basso, con espressione indecisa, poi abbassò il capo.
– E va bene, dottor Guidi, ma questa è l’ultima volta. Il cielo mi punisca se non sarà così. E a sentito cos’ha detto del mio pubblico? Lei non gli ha detto niente? – la voce gli tremava e gli uscivano dei suoni striduli.
– Eccome! Se ti dico che a lavoro finito lo licenzio, cosa vuoi di più?
– Va bene, adesso devo rifarmi il trucco. Guardi qui, sono tutta nervosa, il sudore mi ha rovinato il trucco. Dai Giuseppina che cosa aspetti? Muoviti. Datti da fare, su!
Il lavoro riprese senza ulteriori interruzioni. Il regista dava le indicazioni e Marco le seguiva come a lui pareva meglio, senza avvedersi degli scuotimenti di testa del suo suggeritore di recitazione. Verso mezzanotte il dottor Guidi corse via con i rullini da sviluppare e la piccola troupe si disperse in varie direzioni.
Ad attendere Marco c’era il giovane dai lunghi capelli bianchi che alla luce fioca dei lampioni prendevano delle sfumature grigiastre di varia intensità. Aprì la porta dell’utilitaria invitandolo a salire.
– Sei stato splendido Marco, come sempre, irresistibile! – L’attore gli strinse a lungo la mano, accarezzandogliela.
– Quel maleducato. Ora si accorgerà. Alla fame, deve finire. Alla fame. Ma andiamocene a mangiare un boccone!
Sì Vanessa, – e gli sorrise languido.
Per fortuna che c’era Gilda, altrimenti quel bruto del Mazzini mi avrebbe proprio rovinato la serata. Sono proprio contenta. Domani sera sarà licenziato e mi piacerebbe vedere la sua faccia dopo il colloquio che avrà col dottor Guidi.
Sto per infilare la chiave nella toppa del portone d’ingresso del palazzo dove abito, quando vedo un’ombra staccarsi dal marciapiede opposto e venire verso di me. Giuro che ho provato una certa paura, ma è stato solo un attimo. «Finalmente», dice lo sconosciuto che tiene il bavero del cappotto alzato lasciando intravedere solo gli occhi. «Fa freddo e non ho le chiavi»
Lo lascio entrare per primo. Lo guardo. È bellino, anche se un po’ troppo magro per i miei gusti. È gentile, apre l’ascensore e mi fa cenno d’entrare.
«Prego, dopo di lei».
«Grazie, a che piano?».
«Al suo» mi risponde con voce bassa e seducente. Io provo un sussulto al cuore. Mentre saliamo ai piani superiori gli abbasso il collo del soprabito e vedo un viso fresco, sento che è ben profumato.
«Scusami, ma ci conosciamo?» gli chiedo fissandolo negli occhi, che ha cangianti e bellissimi.
«Adesso sì» e mi lascia scorrere i polpastrelli sul viso con molta delicatezza.
Lo faccio entrare senza chiedergli nient’altro perché sono in stato di confusione. Il cuore continua a tamburellarmi e mi sento come una cerva che sta per essere attaccata dal maschio, pronta ad essere dilaniata dalla febbre del piacere.
«Entra pure, io sto qui da solo, se vuoi puoi bere qualcosa, lì c’è il carrello dei liquori».
Lo spio senza farmi accorgere mentre si toglie il soprabito e si serve del whisky. È sulla trentina, un po’ stempiato ma asciutto, con una bocca sensuale e garbato nei movimenti. Poi ha una voce musicale che mi confonde.
Io mi tolgo il trucco, sono nel bagno ma gli parlo.
«Ma aspettavi proprio me?» gli chiedo.
«Sì» mi risponde lui dal salotto. Ecco, quell’affermazione forse è stata un po’ troppo dura, un po’ maschia, brutale, ma forse ho sentito male.
«Allora non abiti nella casa, vero?».
«No, infatti».
«Hai detto una bugia per incontrare me?».
«Sì.» Questa volta ci faccio attenzione. La voce è calda come all’ingresso.
«Senti prepara qualcosa anche per me. Un cocktail. Non ne sai preparare qualcuno un po’ robusto? C’è l’angostura da qualche parte, se ti serve».
Senza farmi vedere, arrivo sulla soglia. Lo vedo intento a mescere i liquori. Agita lo shaker con classe. Poi versa tutto in due bicchieri e si gira. Mi vede.
«Oh no, che sono tutta spettinata. Arrivo subito!».
Prendo la parrucca color mogano che tengo nell’armadio della camera da letto. È quella che preferisco e che uso in occasioni particolari.
La infilo bene, poi prendo un neo finto che serbo nel comodino e me lo applico vicino al lobo dell’orecchio sinistro. Passo due dita di rossetto sulle labbra: rosso carminio. Indosso una bella vestaglia di seta, con collo e polsini di visone grigio e mi presento a lui non prima d’aver acceso una sigaretta e averla infilata in un bocchino alla Mata Hari. Mi sorride porgendomi il bicchiere. «Sei bellissima», dice con voce quasi mozzata. Gli ho fatto colpo. Non si apettava di vedermi così, nel pieno fulgore che posso rivelare solo lontano da occhi indiscreti.
Si siede su una poltrona. Io sono seduta sul divano di fronte.
«No, perché così lontano? Vieni qui vicino». Esita. Lo fa apposta per farsi desiderare. Mi guarda. Ha uno sguardo duro adesso. Gli occhi sembrano concentrati su di me in maniera quasi malvagia. Mi spavento.
«Ma… perché mi guardi così?».
«Così, come?» chiede mentre ripone il bicchiere sul tavolino. Il suo sguardo è mutato, è tornato dolce, ma non è più quello di prima o forse mi sbaglio. C’è qualcosa di familiare in lui. Credo di averlo già conosciuto, ma quando proprio non lo so dire. Glielo chiedo.
«Conosciuti prima?» ripete e non risponde ma sorride. Si accende la sigaretta con un colpo secco del pollice sull’accendino e questo non mi piace. È una cosa che denuncia una certa brutalità. Lui aspira il fumo e me lo getta in viso.
«Come ti chiami?».
«Ah, vuoi dire… Vanessa, ti piace?».
«Affascinante».
«E tu?».
Non risponde. Si alza e prende una bottiglia in mano. Lo seguo con la coda dell’occhio. Indossa un paio di pantaloni attillatissimi. Quasi indecenti ma che sono molto sensuali. Tossisco, lui si gira mentre si sta versando da bere. Gli cade in terra la bottiglia che si rompe.
«Oh, che sbadato. Come mi spiace!».
Il liquore cade tutto sul tappeto che è la luce dei miei occhi. Io vedo rosso, vorrei saltargli addosso e graffiarlo tutto, ma mi trattengo. Già la bile me l’ha fatta venire quel rozzo di Mazzini, e non voglio rovinare l’atmosfera anche se l’incidente mi ha un poco sconvolta.
«Vado in cucina a prendere uno straccio», gli dico cercando di non tradire il mio disappunto. Appena ho finito di pulire la macchia mi cadono gli occhi sulle sue scarpe e i pantaloni a tubo. Alzo lo sguardo e mi fermo. Gli cingo le gambe, lui mi allontana con uno strattone facendomi andare a sbattere contro il tavolino della televisione.
«Ma cosa ti prende, sei impazzito?» gli chiedo portandomi la mano alla nuca. Lo vedo, ha preso il collo della bottiglia spezzata e viene verso di me.
«Ma cosa vuoi fare?» gli dico spaventata. «Non fare scherzi stupidi, che non mi piacciono».
Lui vibra un colpo deciso. Spinge il vetro nella carotide. Io apro la bocca e straluno gli occhi, lo vedo male ma mi pare che sorrida. Vomito del sangue. Estrae il pezzo di bottiglia mentre mi lascio andare perché sento che le forze stanno venendomi meno. Lui si china su di me, parla sommessamente e dice tante cose, non le afferro tutte ma alcune sì.
Ora ricordo chi è. Mi chiede se ho capito. Riesco con la testa a fare cenno di sì, poi si accanisce selvaggiamente sulla mia gola. Il lampadario a tre luci è l’ultima cosa che riesco a vedere.
La polizia venne chiamata alla mattina da un’inquilina che, passando, aveva visto la porta socchiusa. Entrata, alla vista del cadavere aveva urlato attirando l’attenzione degli inquilini dello stesso piano. Le indagini prontamente condotte negli squallidi ambienti frequentati dalla vittima non approdarono ad alcunché. Vennero controllati gli alibi di tutti quelli che frequentavano il Vinci, ma anche se un paio erano piuttosto dubbi non risultò niente a loro carico che potesse avere a che fare col delitto.
L’assassino non era stato visto da nessuno. Verso le tre del mattino, un inquilino del terzo piano, abitante nell’appartamento sottostante la vittima, sentì un rumore, come qualcosa di vetro caduto in terra. Sul collo della bottiglia vennero reperite alcune impronte ma poco nitide. La casa ne era piena, ma nessuna che riguardasse persone che il Vinci fosse solito frequentare. Non era stato asportato nulla. La gola era stata squarciata dal vetro della bottiglia. Taglio netto della vena giugulare e morte per emorragia.
Mesi dopo, il fascicolo intestato a Marco vinci, detto anche Vanessa, venne archiviato tra gli innumerevoli casi insoluti e tuttora aperti.
Nota numero due
Il telefono posto sulla sinistra della scrivania trillava con insistenza mentre Luigi Serra stava confabulando accaloratamente con un uomo in camice bianco.
– Signorina, sta dormendo? Risponda lei, non vede che sono occupato? – ringhiò verso una ragazza dai capelli sciolti sulle spalle che ondeggiava su scarpe dal tacco alto quattro dita.
– Ufficio del dottor Serra. Chi parla? Un momento per favore – poi, coprendo il microfono con la mano: – dottore, è il direttore commerciale. La vuole vedere subito! Cosa gli rispondo?
– D’andare a fare in c… – ma si bloccò per strappare l’apparecchio dalle mani della giovane.
– Sì, pronto sono Serra. Ragioniere, lei deve avere pazienza, sì… lo so, è appunto per questo, stavo parlandone adesso con il capo reparto. Sì, vengo tra un paio di minuti.
Terminata la telefonata, puntò gli occhi sull’uomo che attendeva.
– Adesso cosa gli racconto? Che abbiamo gli operai imbecilli e che non sono più capaci di montare un tubo catodico?
– È stata una produzione sfortunata, può capitare – rispose l’interrogato alzando le spalle.
– Ah sì eh? io riesco a battere tutti, a piazzare i nostri televisori a colori prima d’ogni altro e salta fuori che sono tutti difettosi. Altro che fare gli scioperi per la quattordicesima, io vi tirerei via anche la tredicesima, massa di lenoni!
E se ne uscì dalla stanza a balzi, serrando i denti e continuando a imprecare.
La segretaria si portò l’indice alla tempia, roteandolo.
– È matto. Un pazzo nevrotico.
Il capo reparto diede una rapida occhiata al corridoio e, una volta accertatosi che nessuno era in ascolto, sorrise sarcastico.
– Gli sta bene. Lui dice sempre che è il più grande venditore del mondo. Che sarebbe capace anche di vendere la merda, se ben confezionata. I televisori a colori erano in casse fiammanti. Si arrangi adesso.
Il dottor Serra batté nervosamente le nocche sulla porta della direzione commerciale.
– Avanti – gli rispose una voce robusta.
– Ah, è lei, si accomodi prego – lo invitò un signore dai capelli brizzolati, alto e secco.
Serra si sedette su una poltroncina, accavallando le gambe. Addentò una sigaretta e rifiutò l’accendino che gli porgeva il ragionier Santi, capo dell’ufficio commerciale della ditta.
¬– No grazie, fumo dopo.
– Veniamo subito al dunque. Quest’ultima fornitura di televisori a colori è un vero disastro. Ci è stata protestata da tutti i negozianti.
– È quello che dico io. Quando lei mi ha chiamato stavo parlando con il capo reparto del montaggio. Quel Saletti o Sapietti, che è un tipo irritante. Fa sempre le spallucce. Siamo ridotti ben male!
– Certo che il problema del personale – sospirò il ragioniere – è una spina nel fianco della nostra società. Purtroppo al giorno d’oggi si va avanti così. Pretese tante e doveri pochi. ma rimaniamo in tema. L’inconveniente causa notevoli danni alla nostra azienda e…
– Ed io che ero riuscito a battere tutti, a convincere anche i più recalcitranti a prendere il televisore a colori. Avevo anche vinto la riluttanza per la storia del Pal e Sécam ed ecco che tutto va in fumo per quegli stronzi che…
Il viso del ragionier Santi si irrigidì e una ruga gli solcò la fronte.
– Dottor Serra, la pregherei di usare un linguaggio più consono alla posizione che occupa qui dentro. So che adesso è di moda il turpiloquio ma nella nostra azienda, ed io sono qui da quasi quarant’anni, non abbiamo mai tollerato che i nostri impiegati si abbandonassero ad espressioni di così basso conio. – Serra alzò la fronte e la bocca si atteggiò a scherno per qualche secondo per assumere subito dopo un’espressione compunta.
– Mi scusi ragioniere, ma è che ho i nervi tesi. A quel Saletti o come diavolo si chiama, stavo facendo una paternale e quello mi guardava come se fossi stato di vetro.
– Lei non deve occuparsi di queste cose. Il suo compito è vendere bene, con il massimo dei risultati. La questione dipende dal mio ufficio. Desideravo anche richiamarla sulla delimitazione delle competenze.
Il venditore sorrise. Immaginava chi poteva aver parlato. Sapeva di essere invidiato da tutti per le sue capacità e chi poteva essere stato se non Rapetti, che lui aveva messo praticamente in un angolo?
– Ammetto di essermi lasciato prendere da troppo zelo, ma le assicuro che non intendevo interferire nel suo lavoro. Certo che la rabbia…
– Meglio così. A proposito, per quanto riguarda le sue percentuali, le dobbiamo trattenere sino a quando non avremo fatto le nuove consegne.
L’uomo impallidì e morsicò diverse volte il filtro della sigaretta che teneva serrata tra i denti.
– E no, questo non è giusto. Cosa c’entro io se quei fannulloni giù da basso fanno le cose col culo, oh pardon, con la testa tra le nuvole? Io ho fatto quello che dovevo. Vendere e ho venduto.
Il ragioniere alzò le braccia.
– Dottor Serra, lei ha un contratto invidiato e invidiabile con la società. Le viene riconosciuta una percentuale su ogni pezzo venduto che, qualora viene reso, non si può considerare tale. Dia un’occhiata alle varie postille e veda di lasciare in pace Sapietti, che bisogna trattare coi guanti. Può andare. Grazie. – Il dottore sbriciolò la sigaretta tra le mani, la gettò nel portacenere sotto gli occhi assenti del ragionier Santi e se ne andò sbattendo la porta.
– Qui dentro sto sprecando il mio tempo! – disse a voce abbastanza alta da farsi intendere da tutti mentre passava in corridoio.
– Telefonato nessuno? – chiese appena rientrato nel suo ufficio.
– Sì, una certa signora Mirella. La prega di richiamarla. – Compose tre numeri poi si bloccò.
– Signorina, veda di muovere i suoi trampoli verso la macchinetta del caffè e stia lì per qualche minuto. La telefonata è riservata.
Uscita la ragazza che gli aveva gettato addosso un’occhiata significativa terminò di comporre il numero che sapeva a memoria.
– Mirella? Perché quando telefoni dici il tuo nome? Non dovevi dire quello di una ditta?
– Ah sì, scusami, ma non mi sono ricordata. A mezzogiorno sono libera. Possiamo mangiare assieme. Stasera mio marito è in casa e non c’è niente da fare. Ho alcune cose da dirti.
– Va bene. Dove ci vediamo? Al Foyer ti va bene? All’una? D’accordo.
Il cameriere servì gli aperitivi accompagnati da olive snocciolate. La coppia non s’avvide che era stata seguita con molta attenzione in ogni suo movimento. Un giovanotto grande e robusto si diresse verso il telefono nell’atrio del ristorante e compose un numero osservandolo su un pezzo di carta che aveva estratto dalla giacca. Appena risposero abbassò la voce portando il microfono molto vicino alla bocca.
– Vuole vedere sua moglie mano nella mano con il suo amante? Non perda l’occasione. Ristorante Foyer. Sa dov’è? Chi parla? Un amico. – Depose l’apparecchio e dopo aver dato un ultimo sguardo alla coppia che confabulava fitto, Antonio Rapetti uscì in strada.
Mirella era piuttosto nervosa. Spezzettava il pane con gesto automatico ascoltando quello che il suo compagno le diceva, scuotendo la testa di tanto in tanto.
– No Luigi, non possiamo più andare avanti così. Mio marito sospetta qualcosa. Non che m’importi di lui, ma è per i bambini. Ormai… ormai è giunto il tempo di darci un taglio, un taglio netto. Sarà doloroso ma ci dobbiamo rassegnare.
– Ma che stai dicendo? – il suo compagno le prese la mano e gliela strinse con violenza per allentare subito la morsa vedendo l’espressione di dolore sul viso della donna. – Scusami, non volevo farti male, ma non posso sentire questi discorsi. Tutto quello che faccio, lo faccio solo per te.
– E tua moglie? – Mirella osservò Luigi che rimase ammutolito.
– Mia Moglie? Ma con lei è tutto chiarito. Adesso è da sua madre. Sono solo. Non ho ancora fatto la denuncia dell’abbandono del tetto coniugale perché prima volevo mettermi d’accordo con te, ma poi inizio la pratica del divorzio…
– …e ci vorranno cinque lunghi anni prima che ci si possa sposare. Ti rendi conto quanto sono lunghi cinque anni?
– Ma intanto vivremo insieme. Il tempo scorrerà via veloce, vedrai.
– E i miei figli? Mio marito? Cosa credi che farà?
¬– Posso rispondere io se mi permettete che mi sieda.
I due voltarono la testa e si trovarono di fronte all’ingegner Balleri, uomo sui quarantacinque anni, vestito in doppiopetto grigio con cravatta rosso spento.
¬– Guido tu qui? Ma non eri…
– Sì, ero in ufficio, ma qualcuno m’ha avvertito dov’eri e con chi. Non volevo perdere l’occasione di conoscere il tuo spasimante. O devo dire fidanzato?
Senza attendere risposta porse la mano a Luigi che lo osservava inebetito.
– Permette? Ingegner Guido Balleri, coniugato con Mirella Artemisi.
– Piacere… io mi chiamo Serra. Luigi Serra.
L’ingegnere prese il menu dandogli un’occhiata veloce.
– Uhm… tutti cibi un po’ troppo elaborati per il mio stomaco. Prenderò un filetto alla griglia con patatine. Voi avete già scelto?
– Guido! – la donna gli toccò il braccio con la mano tremante – non vorrai fare una scenata, spero.
– Scenata? Ma nemmeno per sogno. Desidero mangiarmi un filetto con patatine al fiammifero, e scambiare qualche parola con voi. – Indi si rivolse all’uomo che non si era ancora riavuto dalla sorpresa.
– Lei è innamorato di mia moglie, signor Serra? – gli domandò con noncuranza.
– Eh? Beh io… sì, – rispose deglutendo a fatica.
L’ingegnere assentì senza mutare espressione poi si rivolse alla moglie:
¬– Tu Mirella, sei innamorata di quest’uomo? – chiese senza alterare il tono della voce.
– Guido, ti scongiuro, non fare così. Cerca di capire… – lo implorò la donna.
– È appunto perché capisco che faccio queste domande. Parliamoci chiaro, Mirella, che tu avessi qualcuno lo sospettavo. Che fosse questo signore o un altro a me la cosa importava molto poco. Non mi va per niente per lo scandalo che ne verrebbe fuori. La mia posizione nella banca è tale che un matrimonio fallito comprometterebbe notevolmente le mie indubbie possibilità di ascesa. Quindi sono disposto a vedere la cosa sotto una luce molto tollerante ma che salvi almeno le apparenze. Sì, lo so quello che vuoi dire, che questa è ipocrisia. Io lo chiamo opportunismo. Lascia che siano i giovani a sbandierare degli ideali utopistici, noi cerchiamo di essere concreti. Vedetevi pure e amatevi, ma non tenetevi per mano in un ristorante del centro, perdio!
Serra si grattò la pelle dietro l’orecchio, quasi incredulo di quello che aveva sentito.
– Ma… io ho chiesto a Mirella di divorziare e di venire a vivere con me.
– Davvero? Non credo che Mirella acconsenta a una cosa del genere. È una perfetta borghese. Critica l’ipocrisia, ma ne è permeata. Per lei va bene un amante, che le riempia i vuoti della sua vita quotidiana, che la elettrizzi un po’. E il sapore del proibito dove lo mette? Per una semplice e magari anche acerba mela pensa proprio che Adamo si sarebbe lasciato invischiare da Eva? È un buon alibi, ma c’è la parte più soffocata di noi, quella che comunemente viene definita deteriore che di tanto intanto emerge e ha bisogno di essere pasciuta. È dolce quel prosciutto?
Luigi guardò il piatto che aveva dinnanzi e scosse il capo.
– Non lo so, non l’ho ancora assaggiato. Se vuole prenderne un po’, senza complimenti.
– Ma sì, accetto volentieri mentre aspetto il filetto. Sbaglio o qui il servizio non è dei più celeri? Ci siamo venuti diverse volte, vero Mirella? Ma diverso tempo fa.
– Guido smettila di essere così cinico. Non ti sopporto – e si alzò per correre alla toeletta.
Il marito la seguì con lo sguardo lievemente corrucciato. Poi lasciò la spazio a una fossetta sulla guancia.
– Messe con le spalle al muro, le donne hanno due soluzioni: il pianto e la fuga. Mi auguro che lei non faccia altrettanto.
– No, ma ci mancherebbe. Signor Balleri, anzi mi scusi ingegner Balleri io la capisco, quello che ha detto è molto giusto. Anzi penso che anch’io mi comporterei come lei.
¬– Ma davvero? – domandò con tono alquanto ironico l’ingegnere mentre arrotolava il prosciutto intorno a un grissino.
– No, non usi quell’ironia che mi avvilisce. Io amo Mirella, come nessun altro al mondo, ma non voglio rovinare né una famiglia né la sua carriera. Seguirò il suo consiglio, vedremo di essere prudenti e che la cosa non trapeli.
L’ingegner Balleri sgranò gli occhi poggiando lievemente il capo sulla destra. Sbirciò il suo orologio.
– Non posso trattenermi molto. Vuole andare a vedere le se Mirella ha bisogno di qualcosa?
– Sì, ma ascolti un momento ingegnere, parliamoci da uomo a uomo. Lei non mi conosce ma io sono un grande venditore, io so vendere di tutto, ho un’arte speciale per convincere la gente. Ho una parlantina fluente, un’eloquenza unica coi rivenditori perché so parlare il loro linguaggio, anticipare i loro dubbi e dissipare le loro titubanze. Io sono anche capace di vendere la merda, se ben confezionata, mi scusi il termine ma rende l’idea.
– Sì – ammise l’ospite – l’idea la rende, anche se non è proprio il luogo più adatto per la simbologia, ma… oh, ecco il filetto.
Balleri tagliò la carne cotta al sangue, mentre il suo ospite lo osservava imbarazzato.
– Beh ecco, volevo chiederle una cosa. Io adesso lavoro in una ditta di radio e televisori. Una ditta di nome, ma all’antica dove non concepiscono i sistemi moderni. Vorrei mettere su qualcosa per conto mio e…
– Ah, voleva rifare tutto da capo, Mirella e una nuova attività. Congratulazioni.
– Sì, ma avrei bisogno di un certo fido bancario e lei nella sua posizione forse può evitarmi tutte quelle lunghe pratiche di fidejussione e altre faccende che mettono i bastoni tra le ruote.
L’ingegnere aveva quasi terminato il suo pasto. Infilò in bocca l’ultimo pezzo, accompagnandolo con un sorso di vino rosso. Sì pulì con discrezione la bocca e con un sorriso tirato si rivolse al suo interlocutore.
– Da uomo a uomo posso dirle che lei è un essere viscido? Un piccolo arrampicatore, un arraffone senza arte né parte – disse freddamente.
– Lei mi giudica male. Ma se lo ricorda lei il successo degli anni sessanta? L’hoola-hoop? Bene, io ero in America, l’avevo visto e avevo intuito subito l’affare. Dei tubi di plastica arrotolati a cerchio! Avessi avuto una certa somma sarei miliardario e avrei un pingue conto magari depositato nella sua banca.
– Cameriere, il conto per favore – disse l’ingegner Balleri schioccando le dita. Estrasse di tasca un biglietto da diecimila e lo lasciò sul tavolo.
¬– Io devo andare. Penso che per la mia parte basti. Mi saluti mia moglie e le dica che l’attendo stasera a casa, come se niente fosse successo.
– Non dubiti ingegnere, riferirò. Ma per quel finanziamento? – Balleri gli diede un’occhiata dall’alto in basso, poi si alzò salutandolo con un lieve cenno del capo.
Serra stava masticando delle parole tra i denti quando arrivò Mirella. Il trucco del volto era vistosamente rovinato. Aveva pianto e lo denunciava in modo assai evidente.
– È andato?
– Sì, ma siediti, ho chiarito tutto.
– Tutto come?
– Non gliene importa niente se salviamo la forma. Faremo così, anche a te va bene, no?
Mirella strinse le labbra e si portò la mano alla fronte, due grosse lacrime le scesero sulle gote.
– Su, non piangere. Ci ho ripensato. Hai dei figli, non voglio che crescano con un padre che non è il loro. Ma noi non dobbiamo lasciarci. Tu sei tutto per me. Ora poi ho per le mani un grosso affare. Sarà la volta buona.
Mirella alzò lo sguardo. Tossì con garbo portandosi la mano davanti alla bocca?
– Un affare?
– Sì, c’è un tale che devo vedere stasera a casa mia. Si chiama Origa. Vuole mettere su qualcosa e mi vuole come consulente generale alle vendite con uno stipendio vertiginoso.
La donna assentì col capo.
– Bene, spero che tu possa combinare. Adesso scusami, ma vorrei tornare a casa. Non mi sento molto bene. Ci telefoniamo.
– Certo, certo, ti accompagnerei io, ma sai dobbiamo essere prudenti come vuole tuo marito. Ti faccio chiamare un taxi, va bene?
Che orario strano per dare un appuntamento. Le dieci e mezzo di sera. Ha una riunione importante, ha detto. Se si liberava prima mi avrebbe chiamato. Sono le dieci e diciotto vuole dire che non si è liberato. Ah, dov’è il Pernod? Uhm, non ce n’è quasi più. Mi sa tanto che se lo beve la portinaia quando viene a fare le pulizie. Quella megera è un’alcolizzata. Uhm… invece di anice sembra acido fenico. Non devono aver avvitato bene il tappo. Che idiota quel Belleri. Fa tanto il superiore, ma lo so che era lì con i nervi a fior di pelle, anche se si controllava, ma lo faceva a fatica, l’ho visto bene io.
Non vuole lo scandalo. E chi li vuole gli scandali? Io no di certo. Quella scema di Mirella nemmeno. E allora? Ma sì. Ho sempre qualcuna per spassarmela e lasciare agli altri la responsabilità. Andare a vivere con quella, così piena di se stessa, abituata a certe comodità che io non potrei darle se non andando in malora. Ma poi che me ne frega di lei? Ci sono tante ragazzine in minigonna che chiedono solo di essere violentate. Con le buone o con le cattive. Se questo Origa è uno che ha la grana è la volta buona che l’incastro, ma Cristo non arriva più?
Che ore sono? Le dieci e ventisei. Mancano quattro minuti. Spero che non sia un bidone. Oh che idiota, magari è uno scherzo di quel fottuto di Rapetti. Ma sì, stai a vedere che mi ha incastrato proprio lui. La riservatezza della telefonata, l’appuntamento a quattr’occhi. La nuova iniziativa. «Lei è un grande venditore, ho preso informazioni sul suo conto». «Lei è stato alla Corbelli Farmaceutica, vero?». Ah no, Rapetti non lo può sapere. Lì non lo sa nessuno. Questo è veramente uno che sa parecchie cose su di me. Saprà anche perché sono venuto via? No, non è trapelato niente. Ma che ora è? Le dieci e trentadue, è in ritardo l’amico. Ahia, ho paura che si tratti di uno scherzo. Ah no, il citofono, deve essere lui.
«Sono Origa» dice con un tono di voce come se tutto il mondo dovesse sapere chi è. Schiaccio il pulsante per aprirgli il portone e vado ad aspettarlo sull’uscio.
Non ha preso l’ascensore, arriva a piedi. Lo osservo bene mentre sale gli ultimi scalini. Porta un soprabito di pelle color senape, con un collo di castoro o lontra e un colbacco dello stesso pelo. Ha una figura smilza, a primo colpo parrebbe una donna. Poi si toglie il colbacco. È un tipo sulla trentina, un po’ stempiato, con i capelli sale e pepe. Mi tende la mano, ha un sorriso cordiale.
«Mi scusi il ritardo» dice cortesemente. «Il solito problema del parcheggio». «Ma niente, si figuri, sono solo pochi minuti» gli rispondo e mi mordo la lingua. Gli ho dato un vantaggio rivelandogli che ho controllato l’orologio. Nella trattativa anche questo particolare apparentemente futile può avere la sua importanza. Devo riprendere subito il vantaggio: «Mi scusi, mi si è fermato l’orologio, mi sa dire l’ora esatta?» gli domando mostrandogli il mio Piaget con cinturino d’oro. Lui non risponde. Si toglie il soprabito, lo appoggia su una sedia dell’anticamera e si guarda attorno. «Quel pendolo è esatto, dieci e trentaquattro» e mi incastra una seconda volta. Mi secca ma faccio finta di niente.
«Ah, è esatto? Funziona alternativamente, e non lo prendo troppo sul serio, ma prego andiamo in sala».
Su un tavolino avevo lasciato a bella posta diversi fogli dattiloscritti, dei rotoli di macchina calcolatrice, tanto per fare un po’ fumo. Mi affretto a raccoglierli. «Scusi, stavo controllando alcune cosette degli ultimi rilievi di vendite, stiamo andando forte!».
Quello annuisce, continua a guardare in giro, poi sceglie la poltrona vicino alla finestra e si lascia cadere sopra. Gli offro da bere e chiede whisky. Ne ho una ventina di marche e faccio il figurone dell’intenditore. Lo prende senza ghiaccio. Sorseggia un paio di volte poi sorride. È un viso che non mi è del tutto nuovo, ma ho conosciuto così tanta gente in vita mia che credo di avere impressi nella mente tutti gli archetipi del volto umano. «Bene» dico dopo essermi versato l’ultimo goccio di Pernod e avere riempito il bicchiere di ghiaccio, «se vogliamo parlare d’affari…». Quello assente col capo. Estrae di tasca un libriccino e lo sfoglia con molta lentezza. Ha le gambe accavallate. Gli guardo le scarpe: colore giallo, operate. Quasi nuove. Veste con un certa ricercatezza. Indossa un maglione girocollo blu e una giacca di cashmere che non deve essere costata poco.
«Dottor Serra, io rappresento una compagnia finanziaria che ha intenzione di invadere il mercato , e dicendo invadere esprimo il termine esatto, con alcuni prodotti di largo consumo. Creeremo diverse ditte, apparentemente senza legame tra di loro, ma il centro operativo sarà nelle mani di un ufficio commerciale e a lei spetterebbe la supervisione dell’apparato delle vendite, la sua organizzazione e il controllo».
Bene, stavolta l’errore lo ha commesso lui. Si è sbilanciato, ha dato per scontata la mia disponibilità senza prima chiedermelo. Deglutisco un po’ della mia mistura poi gli sorrido.
«Beh, vede, io sono un tipo molto aperto e sempre disposto al dialogo. Mi interessa avere contatti con ogni tipo di persona, e ogni proposta mi serve per tenermi aggiornato con la situazione economica alla base della piramide. Lei sa dove lavoro e come m’ha detto al telefono sa anche dei miei trascorsi. Dovunque sono passato, ho lasciato alle mie spalle fatturati quasi raddoppiati e incremento negli utili. Per mia natura sono sempre portato a nuove esperienze, ma ora credo che siano state sufficienti e desidererei mettere le radici in una poltrona che mi possa dare adeguate garanzie per il futuro». Mi fissa con attenzione. D’ogni tanto assente col capo ed è l’unico gesto che fa, oltre che portarsi il bicchiere alla bocca per assaggiate il whisky di cui non deve andare matto.
«Bene» riprendo io, «dove mi trovo non sto affatto male, anzi le prospettive per il futuro sono molto interessanti e non so quindi se posso prendere in considerazione la sua proposta a meno che non sia così allettante che…»
Non mi lascia finire. Dopo avere continuato ad abbassare il capo in segno affermativo alza la mano e io taccio di colpo, e commetto un nuovo sbaglio. Me ne accorgo subito, ma tanto vale che lo lasci parlare.
«Sessanta milioni all’anno di stipendio li ritiene allettanti?» domanda quasi sillabando le parole. Io emetto un fischio. Sì, lo so che è un altro errore, ma non mi aspettavo un’offerta del genere e non è facile sapersi controllare in certi frangenti. Cinque milioni al mese di stipendio beh… non so se mi spiego».
«Naturalmente avrà anche una percentuale su ogni pezzo venduto» prosegue compiaciuto, rendendosi conto di aver fatto colpo. Mi alzo e muovo qualche passo per riordinare le idee. Mi accorgo di serrare il bicchiere in mano in modo spasmodico. Lo depongo sul tavolino di fianco.
«Senta» gli dico fissandolo negli occhi, «ammetto che l’offerta può essere interessante, ma devo sapere di più. Mi scusi la franchezza, ma lei mi sembra così giovane che, sì lo ammetto, lei può avere tutti soldi del mondo, lei e i suoi amici della finanziaria, ma dobbiamo giocare a carte scoperte. Tocca a lei parlare».
«È giusto», dice dopo essersi fatto schioccare la lingua nel palato. «Posso avere un altro goccio di whisky?». Lo servo senza parsimonia.
Con un gesto mi ferma e con un altro ringrazia. Beve lentamente mentre io friggo. Lo so che lo fa apposta, ma sto al gioco con naturalezza.
«Dunque, prima di giocare a carte scoperte, come dice lei, avevo bisogno di sapere se potevano esistere i presupposti di una trattativa di cui conosce già una parte dei termini. Dopo questo breve colloquio ho quindi la possibilità di fissare con lei un appuntamento alla sede della finanziaria dove conoscerà gli altri soci: potremo rispondere a tutte le sue legittime domande. Ora me ne astengo per un riguardo ai miei amici».
Gli faccio anch’io un segno con la mano per fargli capire che comprendo bene la sua forma di riguardo.
«Mi può dire almeno di quale prodotto o prodotti si tratterà?». «Certo che sì», risponde pronto come se aspettasse la mia richiesta. «Ne tratteremo parecchi, ma su uno io conto in modo particolare ed è questo».
Accompagna la parola con un gesto. Infila la mano nell’interno della giacca e ne estrae un astuccio. Lo apre e toglie una forbice lunga e stretta.
«Una forbice?» dico io stupito.
«Esatto una forbice, che ha la particolarità di non perdere mai il filo. È quindi un aggeggio eterno. Una meraviglia. Ma la prenda e la osservi. Ne vale la pena».
Sono un po’ scettico. Tutto quel parlare che lasciava intendere chissà cosa e poi mi tira fuori una forbice. Ma molto diversa dalle altre. Mi viene anche il dubbio che il signor Origa sia un mezzo matto.
«Un aggeggio eterno dice? Ma una volta che avremo saturato il mercato, l’articolo viene ad essere superato». E qui commetto un’ulteriore gaffe. Quell’avremo, mi dà già per scontato come parte dell’organizzazione. Ma sono un po’ confuso e anche dubbioso. Passo istintivamente l’indice sulla lama che è affilata come un rasoio e mi taglio.
«Si è tagliato» mi dice in modo quasi soddisfatto, «ha una lama taglientissima».
«Me ne sono accorto!» sbotto io, succhiandomi il dito. Poi comprendo che mi sto comportando come un perfetto idiota e mi attorciglio intorno al dito ferito il fazzoletto che si macchia subito di rosso. Ho anche una coagulazione lenta e il taglio non è mica da ridere.
«Noi produrremo molti articoli, diversi uno dall’altro. Sempre alla ricerca di nuovi mercati, dei beni di consumo di cui creeremo la necessità. La pubblicità che faremo alla televisione, alla radio e su tutti i giornali, compresa quella murale, darà i suoi risultati».
Annuisco mentre vedo che il fazzoletto è ormai quasi tutto insanguinato.
«Senta mi scusi, vado un attimo in bagno a medicarmi. Devo essermi fatto un taglio profondo».
«Mi spiace», dice lui con il tono di voce di un cui non gliene importa un bel niente, mentre io gli lascio rimirare le mie scapole uscendo dalla sala.
Infilo il dito sotto l’acqua corrente e vedo che la ferita è parecchio profonda. Rumore non ne ho sentito ma alzo istintivamente lo sguardo e lo vedo riflesso nello specchio col braccio alzato. Impugna la forbice.
Mi colpisce alla schiena. Emetto un rantolo e casco sul lavandino battendo forte il mento. Cerco di respirare, ma sento la forbice infilata nella schiena che me lo impedisce. Apro le labbra ma non esce alcun suono. Ho in bocca uno strano sapore. Qualcosa di caldo che mi sta per soffocare. Trovo la forza di sputare.
«Perché?» gli chiedo con un altro rantolo, mangiandomi tutte le vocali.
Lui si china verso il mio orecchio e sussurra diverse parole. Parla svelto ma chiaramente. Sapevo di averlo già conosciuto. Continua ancora a parlare ma non riesco più a sentirlo. Con una pupilla vedo che muove le labbra e mi ci fisso sopra.
Avvertito dalla portinaia, salita come tutte le mattine per fare le pulizie, il pronto intervento rimosse la vittima dal bagno dopo aver fatto tutti i rilievi. Una signora abitante la casa di fronte affermò d’aver visto una donna camminare avanti e indietro davanti al portone dove dimorava il Serra, verso le dieci e mezzo della sera precedente. Le indagini rivelarono la relazione esistente con la signora Balleri e fu su di lei che si puntarono i sospetti. Unico suo alibi la permanenza in casa con marito e figli. Ma la polizia, sia pure trattandosi di una persona da prendere con le pinze, non lo ritenne credibile, e anche grazie alla deposizione della moglie del Serra, che era al corrente della tresca, fu incriminata e rinviata a giudizio.
Battuta numero tre
– Che soffitto strano! – notò l’uomo mentre tentava senza successo di fare dei cerchi col fumo.
– Perché strano? – chiese la donna che gli stava accovacciata accanto nel letto – io lo trovo singolare, non ti piace amore? – L’interrogato piegò la testa d’un lato mentre spegneva la sigaretta nel portacenere che teneva sul petto nudo.
– Un soffitto viola. In genere sono tutti tinteggiati di bianco ghiaccio, ma viola proprio! E poi è un colore che mena gramo. – La ragazza alzò le spalle e si raccolse dietro la nuca le chiome fluenti mentre si sedeva sul letto. Il suo compagno la imitò con occhio voglioso, poi affondò la bocca tra i seni prosperosi passandovi rapidamente la lingua e dando un lungo bacio su un capezzolo.
– Filiberto, mi fai male!
– Mi chiamo Alberto, non Filiberto.
La donna gli raccolse la testa portandola vicino alle sue labbra. Gli passò la lingua sul viso, lenta e con metodo.
– Hai ancora voglia? – gli sussurrò all’orecchio strusciando le sue mammelle contro il petto villoso.
– Forse, – rispose sconsolato – ma non ho più l’età. Quando avevo vent’anni ero insaziabile, ma adesso…
– Ma no che sei sempre virile. Nessuno mi ha mai soddisfatta come te. Sapessi con che tipi mi capita d’andare a letto…
Alberto intanto si era alzato e si era infilato pantaloni e camicia. Stava riannodandosi la cravatta quando si fermò a osservare il corpo statuario della donna che sortiva dalle lenzuola per infilarsi una vestaglia lilla con ricami stampati in rosso violaceo.
– Anche questa frase fa parte della messinscena? – domandò con una punta di ironia.
– No dico la verità, amore – rispose la donna che s’infilava le pantofole rosa con un pon pon rosso.
L’uomo sorrise un po’ amaramente e riprese a vestirsi.
– Non te lo dico per farti un complimento – affermò dopo aver calzato con fatica le scarpe – ma tu sei una delle rare puttane che sa fare bene il suo mestiere.
La donna gli cinse le braccia intorno al collo, incollando il suo corpo contro quello dell’amante occasionale.
– Sei stato contento, amore?
– Sì, passerò il tuo indirizzo anche agli amici, e naturalmente tornerò anch’io.
La donna non celava la sua soddisfazione.
– La prossima volta ti farò uno sconto – disse mentre prendeva tre biglietti da diecimila che l’uomo le porgeva, per farli rapidamente sparire nella tasca della vestaglia. – Vuoi un goccio di cognac? – offrì indicando un vassoio fitto di bottiglie di alcolici.
– Due dita. È tardi e non posso fermarmi di più – accettò l’uomo.
– Sei sposato, vero? Non porti la fede al dito, ma hai il segno della vera.
Nella penombra l’uomo arrossì lievemente. Per un attimo. Scosse un po’ il liquido biondo cupo del bicchiere e lo trangugiò d’un fiato.
– Da sette anni. Ho due figli. E una moglie rompicoglioni – sentenziò a mo’ di scusa avviandosi verso il corridoio.
Arrivato davanti a una porta a vetri notò la luce accesa.
– C’è di là qualcuno? – domandò preoccupato.
– No, ho dimenticato di spegnere la luce prima, quando sono andata a prendere il ghiaccio.
L’uomo assentì rassicurato. Diede un bacio sulla guancia della donna e uscì sul pianerottolo.
– Il pulsante è a sinistra del portone – gli rammentò la donna mentre gli apriva la porta dell’ascensore. – Il mio numero di telefono te l’ho dato. Chiamami dall’una alle due. È l’orario sicuro per trovarmi.
La ragazza si chiuse la porta alle spalle. Tirò un lungo sospiro poi diresse i suoi passi verso la cucina.
Seduta su uno sgabello, una ragazza con i capelli sciolti sulle spalle e con le orecchie ornate da due spessi anelli ciondolanti, stava spiluccando senza molta convinzione del pollo freddo.
– Se n’è andato, Milly?
– Sì. E per stasera ho finito.
La ragazza dai lunghi orecchini si guardò attorno ammirata.
– Hai una bella cucina. C’è proprio tutto, lavello in acciaio inossidabile, frigorifero, lavatrice. Non è molto grande ma è messa molto bene.
– Vieni che ti faccio vedere il resto della casa. Mi spiace di averti lasciato qui Elena, ma quello non si decideva mai a venire.
Elena emise un risolino acuto.
– Un matusa eh? Quanti anni ha?
– Non lo so, ma deve averne più di cinquanta.
– Sono quelli che fanno lavorare di più, eh?
– Non me lo dire. Sono incontentabili. Fai questo, fai quello, mettiti così, girati di là. Uno giovane è diverso. In pochi minuti concludi, poi gli fai quattro moine e quello se ne va via contento.
– Ne hai tanti di clienti giovani?
– No, non molti. Con tutte le troiette che ci sono in giro, quelli vanno a puttane solo per diversivo, e allora anche loro vogliono quelle cose speciali che le ragazzine sono restie a fare.
Elena disse qualcosa all’orecchio di Milly, per emettere ancora un risolino acuto.
– Sì, sì, quello specialmente – e rise anche lei. – ma vieni che ti faccio vedere la sala.
– Bella! – esclamò Elena con occhi sfavillanti – ma è arredata proprio bene. Chissà quanto ti sarà costata!
– Oh, una volta avevo un vecchio bavoso che non funzionava più. Io gli leggevo dei libri pornografici seduta sulle sue ginocchia, lui mi toccava tutta, ansando come un mantice e mi dava trecentomila lire per volta. Poi è morto e allora…
– Che fortunata che sei – commentò ammirata Elena – ma voglio anch’io farmi una bella casetta come te. Ho intenzione di mettermi a lavorare seriamente.
– Basta che non fai come quelle povere stronze che vanno a battere per mantenersi il magnaccia. Io non ne ho. Sono sola e indipendente. Ho incominciato comprando una cinquecento con quarantotto rate e mi sono messa a girare per la città. Io i clienti li scelgo. Se non m’ispirano li lascio perdere. Bisogna fare attenzione, ci sono anche degli spostati, i maniaci religiosi e quelli sono i più pericolosi.
– Ah, la camera da letto – esclamò Elena roteando gli occhi ammirata. – Il soffitto viola! Che bella idea. È stata tua o dell’arredatore?
– Mia, mia. Quello scemo mi sconsigliava di farlo, invece mi è utile. Attira l’attenzione di tutti. Quello di prima diceva che il viola mena gramo, ma invece è il mio colore. Io adoro il viola! Tutte le gradazioni di colore che vanno dal viola intenso al lilla chiaro.
– Che gusto che hai! Bisogna che impari da te.
– Ma non hai visto ancora il bagno. Guarda! – e così dicendo Milly aprì una porta con l’espressione di chi lascia finalmente vedere un tesoro inestimabile.
– Oh! – uscì dalla bocca della ragazza estasiata. Al posto delle piastrelle c’erano degli specchi che correvano da entrambi i lati della stanza per unirsi al soffitto, anch’esso arredato di lastre speculari ambrate.
– Ma è meraviglioso, meraviglioso. L’ho visto una volta in un film americano. Specchi dappertutto. Bellissimo!
– Anche le mattonelle sono a specchio. Ti puoi guardare da tutte le parti!
– Ma come ti è venuta in mente un’idea simile? Io non ci sarei mai arrivata.
– Conoscevo uno strano tipo, un inglese o americano, che voleva fare all’amore nel bagno. Gli piaceva vedersi mentre lo faceva e mi ha detto lui di fare così. Pagava qualsiasi cifra senza fiatare. È un po’ che non si fa vedere. Si vede che ha degli affari al suo paese.
Gli occhi di Elena luccicavano di ammirazione.
– Sei in gamba Mariuccia. Non avrei mai creduto che saresti stata capace di fare tanta strada.
– Non chiamarmi Mariuccia. Mi chiamo Milly adesso. Non uso mai il mio vero nome. E ti consiglio di fare altrettanto. Bisogna usare dei piccoli accorgimenti. Prendere la casa in un posticino tranquillo, dove non ci sia la portinaia. Mai mettere il nome fuori dalla porta, ma un bell’occhio magico così puoi vedere sempre chi viene.
Elena assentiva deglutendo.
– Sì, sì certo, ma chissà mai quando potrò permettermi una cosa del genere. Sono appena arrivata dal paese e conosco solo te in città.
– Non ti preoccupare Elena. Domani ti manderò da una signora, un’aristocratica. Ha una casa di appuntamenti frequentata da gente su, se le fai una buona impressione ti farà lavorare lì. Non chiede mai nomi né niente. Dice solo quando devi andare. Non devi mai accettare soldi dai clienti, penserà lei a pagarti. Guarda che su questo è molto severa. Ti faranno delle fotografie nuda, in diverse posizioni. Sai, è per il loro catalogo. Io m’interesserò per vedere di trovarti un monolocale. All’inizio lo prendi in affitto. Li danno già arredati. Ti prenderai una macchinetta a rate, insomma farai come ho fatto io all’inizio. Vedrò di mandarti qualche cliente. A loro piace cambiare, poi tu sei giovane, fresca, bella, hai tutte le qualità per sfondare.
– Potessi anch’io in poco tempo riuscire a fare quello che hai fatto tu!
– Ci riuscirai, stai tranquilla – la incoraggiò Milly, mettendole una mano su una spalla per lasciarla poi scivolare lentamente sul seno.
– Facciamo un bagno insieme prima di dormire?
– Sì, sì, con tutti quegli specchi, che idea fantastica Milly!
Le due donne si abbracciarono, si diedero un bacio sulla guancia e le loro lingue si incontrarono per un attimo. Frementi.
La millesei blu mi sta seguendo da una decina di minuti. Se rallento, rallenta pure lei. Giro e mi viene dietro. Vediamo che intenzioni ha, adesso sbuco nel viale e ci do dentro con l’acceleratore. C’è anche il verde, bene. Guardo nello specchietto retrovisore e lui è sempre lì, alle calcagna. Non riesco a vederlo bene. Mi sembra che porti gli occhiali ma non ci posso giurare adesso svolto a destra e mi fermo. Vediamo se non è un perditempo.
Eccolo che arriva, mi sorpassa, ah, ora mi ha visto. Frena e si porta a destra in parcheggio. E no, cocco mio, io sin lì non ci vengo. Metto la freccia e riparto. Lui sempre dietro. La macchina è nuova, una targa delle ultime. Non porta gli occhiali, mi sono sbagliata. È un tipo bellino sulla trentina. Adesso vado avanti lentamente e appena trovo un posto dove si possano accostare due macchine mi fermo. Eccolo lì, sono fortunata.
Si infila dietro alla mia, ma non scende. Beh cocco, che aspetti? Ti do il tempo di una sigaretta, poi, se non ti decidi, me ne vado. Non posso sprecare tutta la sera per te. Mi accendo una Muratti e l’aspiro mentre lo tengo d’occhio dallo specchietto. Si accende una sigaretta anche lui. Ah, fa la guerra dei nervi? Beh, forse è un timido. Vedo d’incoraggiarlo, schiaccio il pedale del freno due, tre, quattro volte. Vedendo la luce che diventa acuta dovrebbe decidersi. Macché, continua a fumare. Metto la freccia a destra. Questa lampeggia a intermittenza. Stavolta se non si muove, me ne vado. Niente. Spengo la sigaretta che è ancora a metà, e giro la chiave. Si è deciso finalmente. Esce dall’auto accostando la portiera e si avvicina a passo lento. Io continuo la messa in moto e metto la freccia sulla sinistra, segnalo che esco. Arriva all’altezza del mio vetro ma faccio finta di non vederlo e giro lo sterzo. Picchia con le nocche. Abbasso di poco il finestrino.
«Buonasera» dice con un sorriso forzato. Lo osservo mentre sta martoriando la sigaretta. Sì, dev’essere un timido. Indossa un soprabito marroncino con bottoni scuri sulle spalline. Dà l’idea del militare. È smilzo, e una faccia anche simpatica. Non ha molti capelli anche se li ha gonfiati.
«Ti sei deciso eh, amore?» gli dico per incoraggiarlo un po’. Lui sorride nuovamente, stavolta in maniera meno forzata.
«Quanto vuoi?» chiede con voce roca. «Dipende da quello che vuoi fare, tesoro, minimo è trenta!» Si guarda intorno un po’ spaurito. In genere tutti gli sposati fanno così. Si passa la lingua sulle labbra poi muove la testa di qualche millimetro. «Per me va bene, ma… ma non voglio andare in nessun albergo. Non mi va di essere registrato», dice tutto d’un fiato. «Ma per chi mi hai preso?» gli rispondo risentita. «Non sono mica una battona io!» E tiro su il finestrino.
Lo vedo imbarazzato. Apre la bocca un paio di volte senza profferire parola. Io torno a mettere in moto la macchina. Lui si fa deciso, apre la portiera. «Non ti volevo offendere, scusami. Dove si va?» Così va bene. Si è fatto coraggio. Il lampione lo illumina chiaramente in quella posizione. Ha un bel paio d’occhi, ma d’espressione indefinita. Mi sembra anche di conoscerlo, ma forse mi sbaglio. «Seguimi e quando mi fermo aspetta che abbia aperto il portone prima d’uscire dalla macchina. Quando l’ho aperto entra subito, hai capito?». Fa cenno di sì con la testa e ritorna nella sua vettura. Io esco tirando su il motore al massimo di giri. La mia Mini è una saetta, ma la sua macchina non è certo inferiore, quindi mi tallona con facilità. Arrivo davanti a casa. Scendo, apro il portone e lui da bravo esegue le istruzioni alla lettera. Saliamo in ascensore senza dire una parola. I suoi occhi guardano dappertutto meno che verso di me. È proprio un timidone. Questo lo condisco via senza spremermi troppo. Entriamo in casa e lui si ferma nel corridoio. «Togliti pure i panni di dosso», gli dico e lo precedo in sala. Apro l’armadietto bar e tiro fuori cognac e whisky. In genere non bevono altro. Qualcuno mi chiede della birra e certe volte della coca-cola, ma solo quando fa caldo.
«Cosa bevi?». «Whisky», risponde pronto. «Con un po’ di ghiaccio se non è troppo di disturbo». Fa l’educato e forse lo è anche. È vestito bene. Una giacca a quadri marrone smorzato con righe arancioni, pantaloni e golf accollato verdi e scarpe gialle. Gli porto il ghiaccio e lo trovo ancora impalato a braccia conserte. «Siediti pure, mi sembri un po’ tirato». Ringrazia con un sorriso e si siede. Gli porgo il bicchiere che afferra deciso. Lo muove, facendo oscillare il contenuto, poi lo assaggia. Non mi pare un gran bevitore. Io mi verso del cognac e mi siedo vicino a lui. «Allora amore, cosa vogliamo fare? Ma bevi pure con comodo, non voglio farti premura». Mi osserva sorridendo. Si sta sciogliendo perché lo vedo più rinfrancato. Mi stanno sui nervi i tipi ipertesi, non dico che preferisco gli invadenti, ma c’è la giusta via di mezzo. «Fai tu», dice dopo aver ingollato qualche goccia di liquore, «fai il meglio che sei capace e metti tu la cifra». «Beh» gli rispondo io, « se chiedi un lavoro sopraffino, allora ci vuole un bel centone». Reclina la testa da un lato e storce la bocca. «Se li vali…». «Li valgo» lo assicuro. Mi prendo una sigaretta. Lui si tasta le tasche. «Le mie le ho lasciate in macchina, posso averne una delle tue?». «Ma certo» gli rispondo e gliela porgo. Per centomila lire, gliene do quante ne vuole di sigarette. Afferra l’accendino e mi accende la mia. È molto garbato. Cerco di indovinate che mestiere faccia, ma non riesco a quadrarlo.
«Che mestiere fai?» gli domando. Lui sorride. Ho notato che lo fa sempre prima di rispondere. «Compongo». «Ah, che cosa? Canzonette?». Scuote il capo mentre sputa fuori il fumo dalle narici. «No, musica sinfonica». «Oh, quelle barbe» dico io senza riflettere. Non mi pare che si sia offeso perché non cambia espressione. «Scusa sai, non è che la trovi brutta, ma è che non la capisco. Forse ci vorrebbe del tempo, della passione. Cosa hai scritto? Sei famoso?». E sorride, ma già lo sapevo. «Non ho ancora finito il mio primo lavoro. Sono alle prime armi. Sto componendo una pièce in nove battute. Sino ad ora ne ho finite due e sto iniziando la terza». «Ah, ci vuole così tanto tempo?» e mentre dico questo mi cade la cenere sui suoi pantaloni. Ha uno scatto di nervi, ma si blocca subito. Se la spazzola via con la mano aggrottando la fronte. «Scusami mi spiace, ma ho una spazzola di là e…». «No» dice senza lasciarmi finire, «non fa niente. È già a posto così».
«Andiamo in camera?»
Gli faccio strada, cammina un po’ barcollando, forse non tiene i liquori o forse è una mia impressione. Accendo la luce che si riflette sul soffitto e lui alza la testa. Non dice niente del colore e si toglie la giacca un po’ impacciato. Io con un colpo di lampo mi sfilo il vestito. Lui guarda i miei seni, ma senza particolare emozione. Mi tolgo il collant e le mutandine e mi sdraio sul letto.
«Senti amore, non per sfiducia, ma ti spiacerebbe darmi i soldi subito? Sai io non ti conosco, la prossima volta sarà diverso». Stavolta non sorride. Rimane immobile per qualche secondo, poi infila la mano nell’interno della giacca e tira fuori diversi biglietti, sfila un Manzoni e lo mette vicino al comodino, mettendoci sopra il portacenere. Riprende a svestirsi, il golf, la canottiera. Si siede e sfila le scarpe. Ha un’espressione preoccupata, come se temesse di non funzionare. Voglio rincuorarlo e gli dico «Sei un po’ timido vero? Non ti preoccupare, con Milly non ha mai fatto cilecca nessuno». Mi punta il mento. Sorride ma in modo strano. Si porta alla bocca il mignolo e si mordicchia l’unghia.
«Senti», dice puntando gli occhi sulle mie gambe e sfiorandole coi polpastrelli, «io ad andare a letto con una in maniera tradizionale non mi diverto proprio. A me piace fare certi giochetti un po’ particolari». «Che giochetti?» gli domando puntando i gomiti sulle lenzuola. «Beh, io godo soltanto creando un’atmosfera di sadismo». Faccio per replicare, ma lui tende una mano. «No, non fraintendermi, non voglio picchiarti, ma creare la scenografia. Ad esempio se ti lego, ecco che allora mi carburo nella maniera giusta».
Butto le gambe giù dal letto decisa. «No, cocco bello, me lo dovevi dire prima, io a fare queste cose non ci sto», gliela canto in maniera chiara e la mia voce è dura. Lui mi prende le mani. Sta tremando. «No, non fare così, sono disposto a pagarti bene. Centomila ancora ti bastano? Duecentomila?» lo fisso portandomi le mani sui fianchi. Lui afferra la giacca e tira fuori altri due Manzoni, poi ne tira fuori un terzo e lo aggiunge a quello deposto sul comodino. «Va bene così?» domanda ansioso. Annuisco anche se non sono troppo convinta. Quattrocentomila e appena il mattocchio ha finito lo sbatto fuori e per stasera basta. «Cosa ti serve?» gli chiedo sgarbata. «Bah, non so, una corda e se non l’hai delle bende e un cerotto». Vado in bagno, prendo dall’armadietto quanto mi ha chiesto e glielo do in mano. «Ecco qua, ma non stringermi troppo, non voglio che mi rimangano i segni».
Mi rimetto sul letto e lui si mette subito al lavoro. Arrotola un po’ le bende, mi lega un polso alla spalliera, poi l’altro. «Hai stretto troppo, mi si è fermato il sangue!» gli dico sgarbatamente ma lui finge di non sentire. Mi divarica le gambe e fa altrettanto con le caviglie. «Mi fai male, ho detto!». Alza la testa e mi guarda. I suoi occhi sono freddi. Ho un po’ di paura. Non avrei mai dovuto acconsentire. Nel cassetto del comodino ho una pistola, ma a che serve? Vedo di spaventarlo. «Non ci sto più. Liberami subito o mi metto a urlare!». Aggrotta la fronte e stacca un pezzo di cerotto e me lo appiccica sulla bocca a mano aperta facendomi sanguinare la gengiva. Tento di parlare, ma mi escono solo suoni soffocati. Sgrano gli occhi, ora ho davvero paura. Lo osservo. Mi guarda con espressione quasi assente. Il mio cuore tamburella e le tempie paiono scoppiare. Richiamo tutta la forza che ho e cerco di liberarmi, ma mi ha legato troppo bene. Non c’è niente da fare. Aspetto che si spogli, invece si rimette canottiera e golf. Si infila anche giacca e scarpe. Beh, forse è contento così. Mi pianta in quella posizione e ci dovrò rimanere fino a mezzogiorno di domani, quando verrà Elena. Le ho dato la chiave. È ancora il minore dei mali. Ma non se ne va. Si china a raccogliere il mio collant e lo tira, assottigliandolo. Si siede vicino a me e me lo gira intorno al collo. Incomincia a stringere, ma lentamente. Mugolo e cerco di chiedergli pietà con gli occhi. Lui abbozza un sorriso. Mi chiama Mariuccia, sa chi sono, dice anche il mio cognome, ma come è possibile? Io non riesco proprio a ricordarmi di lui. Dice qualcos’altro mentre mi stringe sempre di più la gola. Non ha espressione, solo gli occhi gli brillano. Socchiudo i miei, vedo un gran buio davanti a me, quando allenta la stretta. Mi dice un nome e capisco tutto. Mi chiede se ho capito quello che m’ha detto. Gli rispondo con frenesia con la testa. Pare soddisfatto. Digrigna i denti e stringe, sempre più forte. Una saracinesca nera mi cade sugli occhi.
Elena arrivata il giorno seguente verso mezzogiorno, trovò la sua amica con attorno al collo il cappio di nylon che l’aveva soffocata ed era scappata urlando, lasciando la porta spalancata. Gli inquilini accorsi alle grida, fecero la macabra scoperta. Le indagini della polizia portarono solo alla scoperta di una Alfa Romeo millesei blu, che risultava rubata il giorno prima, ferma davanti all’abitazione della vittima, e dato il particolare lavoro della vittima, indirizzò le ricerche verso il giro dei maniaci, senza però approdare a nulla.

La battuta numero quattro, stonata
– Hanno messo tutti il necrologio, meno Enrichetta – disse la vecchia signora deponendo il giornale sul tavolo. Si tolse gli occhiali a pince-nez e guardò i presenti.
Suo fratello Giacomo, seduto sulla punta della sedia, la osservava distratto, la cognata Marina appollaiata sul divano sbatteva le ciglia guardando il cielo, e la sorella Edvige, compuntamente seduta in poltrona, continuava ad armeggiare con ferri e lana.
– Nostra sorella non ha perdonato allo zio Luigi di non averla nominata nel suo testamento.
– E come fa a saperlo, se non è stato ancora aperto? – domandò stizzita la vecchia signora. – E come fai a saperlo tu?
Edvige alzò un attimo gli occhi fermando il lavorio metodico delle mani.
– Lo sappiamo tutti invece. Zio Luigi non ha mai fatto mistero che non avrebbe mai lasciato neppure un centesimo a Enrichetta, e le ragioni le conosciamo bene. L’ha cantato a tutti che avrebbe sperperato il suo patrimonio in donnacce piuttosto che lasciare qualcosa a lei.
– Beh se è per questo… – disse allusiva la cognata agitando la mano in modo eloquente.
– Non siamo qui a fare il processo ai defunti – sentenziò stizzita la vecchia signora che si era rimessa gli occhiali sul naso. – Zio Luigi aveva forse una morale un po’ elastica, ma non ha mai mancato di riguardi verso la sua famiglia e nemmeno verso i suoi parenti.
– Che Dio se l’abbia in gloria, – mormorò Giacomo portandosi la mano aperta sul cuore – ma mia moglie ha ragione. Sono proprio curioso di sapere cosa rimane esattamente del suo patrimonio. Ultimamente frequentava solamente delle prostitute, spendeva e spandeva senza ritegno, tanto che, se ben vi ricordate, volevamo vedere se c’era la possibilità di farlo interdire.
Luisa si alzò di scatto.
– Non posso stare ad ascoltare questi discorsi. Si sta insultando la memoria di un uomo giusto!
Edvige, che continuava a muovere ritmicamente le mani con i suoi diritti e rovesci, lanciò un gridolino.
– Lo sappiamo, Luisa, che sarai la più grossa beneficiaria del suo testamento, ma vorrei sentire la tua opinione se per caso il lascito sarà minore di quanto ti aspetti.
La sorella la guardò da capo a piedi arricciando il naso e dopo aver sbuffato, uscì dalla stanza con portamento eretto.
La cognata la seguì con una espressione di sarcasmo e appena ebbe chiuso l’uscio rise nervosamente.
– Tua sorella, caro Giacomo, si considera ancora quella che era una volta quando aveva servi e serve ai suoi piedi. E tratta tutti come tali.
– Non essere ingiusta con Luisa – la rimbrottò il marito. – Era molto attaccata allo zio, anche se proprio adamantino non era.
– Una canaglia, ecco cosa era, una canaglia.
Giacomo e Marina osservarono Edvige che continuava a sferruzzare senza alzare lo sguardo.
– Ma cosa dici? – la rimproverò Giacomo.
– So perfettamente ciò che dico! – e smise di lavorare per guardare i coniugi. – Zio Luigi una volta ha licenziato più di trecento persone solo perché gli andava di farlo, per il piacere di vedere la gente sul lastrico. Non c’era alcuna necessità di imporre una così drastica riduzione degli operai, ma lui lo fece ugualmente, e il perché poi è uno dei più schifosi che si possa immaginare.
Tacque un momento ruotando gli occhi addosso agli attenti astanti.
– Sapete come faceva le assunzioni delle ragazze dell’ufficio, perché le faceva lui, il capo del personale lì dentro era un semplice manichino, mentre parlava con loro infilava le dita sotto le mutande e se quelle ci stavano venivano assunte, altrimenti niente lavoro.
– Ma Edvige, tu stai delirando! – grugnì scandalizzato Giacomo. – Queste sono basse calunnie che mi meraviglio di sentire in bocca a mia sorella!
– Basse calunnie, eh? E sai come avvenne la storia di quel licenziamento? Uno dei componenti della commissione interna aveva una moglie giovane e carina che faceva l’operaia ma che non aveva mai accettato la corte di quel bel tomo di nostro zio. Lui la circuì, le mandò regali che tornarono sempre indietro. Non poteva accettare di venire rifiutato da una donna, da un’operaia poi! Così, visti inutili i suoi tentativi di corruzione, sfidò la commissione interna, fece apposta a perdere delle commesse con l’estero e licenziò quelle trecento persone per sfida. Quando la donna andò a supplicarlo di ritornare sulla sua decisione, lui le pose il ricatto. Lei accettò, ma quando si era preso la sua bella rivincita, invece di mantenere i patti non riassunse il personale.
– Ah, questa è davvero bella! – squittì Marina accendendosi una sigaretta. – Non la sapevo proprio.
– Ma tu – l’investì duramente il fratello – come fai a conoscere queste cose? Te le ha raccontate quell’operaia?
– No, caro Giacomo – rispose compunta l’interrogata – dimentichi che sino a pochi anni fa ho lavorato in contabilità nella fabbrica? Ero io che provvedevo a inviare prima i fiori e poi brillanti a casa di quella poveretta. Ho sentito il loro colloquio quando è andata quel famoso sabato nel suo ufficio.
– E perché nessuno ne ha mai saputo nulla? – ringhiò Giacomo.
– Perché coi soldi si mette a tacere tutto. Il marito di quella sciagurata aprì alcuni mesi dopo una piccola fabbrica per conto suo che lavorava dietro comando di nostro zio. L’onore è stato lavato a suon di milioni.
Giacomo scosse la testa come incredulo.
– Ma come è possibile un’azione del genere? Enrichetta non ha torto a non aver fatto il necrologio se le cose stanno davvero così.
– Enrichetta è una persona con una sua dignità! – confermò la sorella. – Non si sentiva certo di fare stampare il suo nome come vedova inconsolabile che piange la morte del suo amato congiunto.
Suonarono alla porta. Istintivamente tutti e tre voltarono la testa in direzione del suono. Il campanello trillò una seconda volta.
– Ma non c’è Luisa?
– Si sarà ritirata nella sua camera a pregare per la buon’anima dello zio – disse sarcastica Marina.
– Ne ha proprio di bisogno, anche se non credo che servirà a qualcosa – disse sospirando Edvige mentre si alzava.
– Lascia Edvige, vado io – le disse il fratello con un cenno della mano.
Giacomo si trovò davanti un uomo sulla trentina, un po’ stempiato, avvolto in un paletot blu scuro, che serrava in mano un quotidiano.
– Desidera?
– È vero quello che c’è scritto qui? Il commendatore Luigi Sforzi è stato seppellito ieri? – domandò quasi irato.
– Sì, è vero. Lei non sapeva nulla signor…
– No, non lo sapevo affatto. Pensavo che godesse di ottima salute.
– Ma non vuole entrare un momento signor…
– Non servirebbe a niente. Sono stato a casa sua ma nessuno mi ha risposto. Il portinaio non ha voluto dire nulla. Sembra un segreto di stato.
– Beh, la morte di nostro zio ci ha dolorosamente colpiti. Siamo tutti affranti. La vedova poi… ma mi scusi, qual è la ragione del suo interessamento per il commendatore? Le doveva forse qualcosa?
– L’uomo sulla porta osservò Giacomo un attimo con uno sguardo tagliente.
– No, lui a me non doveva niente. Ero io che dovevo qualcosa a lui.
– Ma chi è? – Marina era spuntata dalla porta della sala e osservava il visitatore che non voleva entrare nell’appartamento.
– Niente, niente, un signore che voleva sapere dello zio…
– Mi scusi se vi ho disturbato. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia, vero?
– Sì, stamattina.
– Grazie e mi scusi di nuovo.
E l’uomo scomparve rapidamente dalle scale lasciando perplessi i coniugi.
– Ma cosa voleva quello? – domandò Marina con malgarbo.
– Non lo so. Pareva seccato della morte dello zio. Ecco, più che spiaciuto sembrava proprio seccato.
– Ma chi era?
– Non me l’ha voluto dire.
– E tu dai informazioni a chiunque capiti? – lo investì la moglie sbattendo la porta.
– Informazioni, informazioni, cosa gli ho detto di speciale? Piuttosto è strana una cosa, ha detto che aveva un debito con lo zio.
– Un debito? Forse gli avrà imprestato dei soldi. E magari voleva renderglieli e tu l’hai lasciato andate via.
– Macché imprestare soldi, lo zio sì, proprio lui. No, ma aveva un’aria strana. Non l’hai visto anche tu?
– A me sembrava semplicemente uno che avesse una gran fretta.
– Chi era? – Luisa era apparsa nell’ampia anticamera. Serrava tra le dita una corona del rosario.
Ð Niente, niente, avevano sbagliato porta – si affrettò a dire Giacomo.
«Eccoti lì nel tuo bel mausoleo. Hai finito di decomporre l’aria con la tua presenza, vecchio ladro. Ora sai tu a essere decomposto. Ma non era così che avevo progettato le cose. Credevo che tu godessi ottima salute, come tutti gli esseri ignobili come te, che pare siano immortali. Invece anche per loro viene il momento di crepare. Ma dovevo essere io a procacciarti la morte, dovevi sapere che ero stato io. Avrei dovuto metterti per primo sulla lista. La mia quarta nota, stonata.
Sono divorato dal furore di essere arrivato tardi. Ma se non posso più colpire te, posso colpire la tua memoria. Prendi per ora questo sputo su questa bella costruzione eretta apposta perché non ti dimentichino».
– Una cosa scandalosa! – sentenziò Luisa piegando il giornale e togliendosi gli occhiali a molla piazzati sul naso.
I presenti annuirono. Giacomo allargò le braccia con fare perplesso.
– Tre zingari che forzano la serratura della cripta, entrano e si mettono a ballare e a suonare il violino! Incredibile!
– Incredibile? Profanare un tempio? – urlò dimena dosi Luisa, per ricomporsi subito dopo.
Marina sgranava gli occhi fuori dalle orbite.
Quegli zingari hanno affermato di essere stati pagati da un uomo, che ha dato loro centomila lire a testa per compiere quel sacrilegio. Ballare sulla tomba di un morto.
Edvige che stava raccogliendo un rotolo di lana chiara che le era caduto dal grembo, ridacchiava contenta.
– Ballare sulla tomba di un morto. È un segno di disprezzo. Un disprezzo pagato anche bene. Ballare, cantare e suonare sula sua tomba. Era “Occhi neri” che suonavano poi?
Luisa la fulminò con gli occhi.
– Ha importanza una cosa del genere? Spero proprio che la polizia riesca ad arrestare quel pazzo!
Giacomo e Luisa si rivolsero lo sguardo l’un l’altra contemporaneamente.
– Per me dev’essere quel tipo che è venuto ieri. Avevo detto subito che mi pareva seccato dal fatto che lo zio fosse morto. E il fatto che avesse detto d’avere un debito con lo zio adesso si spiega. Un debito da salvare, un conto in sospeso.
– Con quella bella descrizione che hai dato tu alla polizia, – lo investì la moglie a denti serrati – non lo troveranno mai. Hai detto loro che aveva i baffi e che era robusto. Non aveva baffi ed era magro come un chiodo.
– Ma no, ti sei sbagliata tu. Ti sembrava magro perché era vestito di scuro ma era un tipo robusto, e i baffetti erano sottili, tu l’hai appena intravisto.
– No – rimbrottò subito la consorte – io l’ho visto e tu senza occhiali l’hai a malapena individuato. Vecchio come sei non dovresti avere vergogna a portare le lenti. Danno anche un tono di distinzione.
– È veramente deplorevole – disse Luisa con un tono di voce tagliente – che dobbiate lasciarvi andare a queste meschine diatribe quando è stata compiuta una profanazione così scandalosa alla tomba di vostro zio.
I due abbassarono la testa mentre Edvige che sferruzzava con solerte maestria, sorrise.
– Chissà se sabato, quando il notaio aprirà il testamento, avrai sempre la stessa opinione di nostro zio, o se piuttosto, in cuor tuo, ringrazierai quel tale, chiunque sia, di aver adeguatamente onorato la sua memoria.
Luisa si alzò e con portamento eretto uscì dalla stanza seguita dal risolino flebile della sorella.
I tre zingari diedero delle descrizioni alquanto contrastanti della fisionomia del presunto mandante e gli inquirenti furono concordi nel credere che l’atto inconsulto fosse stato compiuto per uno degli strani riti che, di tanto in tanto, usavano fare. La sommarietà dei dati forniti dai coniugi circa l’uomo che si era presentato il giorno prima alla loro porta fu di scarsa importanza e il fatto in se stesso venne giudicato casuale, la pratica aggiornata con l’incriminazione degli zingari.
La donnetta, avvolta nello scialle, attraversò guardinga la strada facendo ciondolare con la mano la borsa che aveva conosciuto tempi migliori e serrando con l’altra un guinzaglio con a capo un cane: un tipo di bassotto imbastardito con un volpino. Il pelo era fulvo, il muso rincagnato. Un occhio, coperto di peluria nera, sembrava sempre immobile, l’altro invece roteava da ogni parte, come se anche un camaleonte ci avesse messo la mano per comporlo.
– Flic non farti tirare, non fare lo stupido, vieni – gracchiò la vecchia mentre il cane si era fermato ad annusare il marciapiede macchiato di orina.
Una donna sulla cinquantina con la scopa in mano si fermò a osservarla imitata da un’altra signora su per giù della stessa età.
– Guardala come va in giro conciata, con tutti i soldi che ha! – esclamò la prima con disgusto.
– Dicono che abbia più di cento milioni, tutti nascosti in casa – aggiunse febbrile la seconda.
– No – rispose la donna con la scopa scuotendo la testa – in casa tiene poco. Li ha tutti in banca. Vuole che non lo sappia io che sono la portinaia e che vedo tutta la sua posta?
Fece una breve pausa per lumare la bocca aperta dell’inquilina che non le toglieva gli occhi di dosso.
– Ah sì, eh? E quante banche?
– Tante! – rispose la portiera riprendendo a lavorare di ramazza. – Più di dieci. Arrivano, anzi arrivavano le buste con i saldi di conto. Poi non li ha fatti arrivare più perché credeva che io li aprissi. Si figuri lei signora Mirka se io posso essere capace di fare una cosa del genere!
– Ah, senz’altro no! – esclamò pronta la donna con uno sguardo che lasciava intendere il contrario.
Il cane che rispondeva al nome di Flic, trotterellava avanti scomposto, seguito dalla sua padrona, avvicinandosi all’entrata dello stabile.
– Va in giro conciata come una barbona – sibilò a mezza voce la custode prima di dipingere sul suo volto uno smagliante sorriso e pronunciare un…
– Buon giorno signora Adelchi. È uscita presto stamattina!
– Ma che stupidate sta dicendo? – rispose la vecchia seccata. – Sono dieci anni che esco presto tutte le mattine, con neve e pioggia. Andiamo Flic vieni via che dopo dicono che sei tu a fare la piscia nell’androne.
Con le mani strette intorno al manico della scopa, la custode e la sua amica osservarono la vecchietta che raccoglieva il cane da terra e s’infilava in ascensore.
– L’ha sentita? Non si può essere gentili con quella vecchia taccagna. Ha sentito come risponde?
L’interrogata annuì gravemente.
– Ma mi dica, è vero che fa la strozzina? Sì, insomma, che impresta i soldi ad alto interesse?
La custode le rivoltò lo sguardo contro.
– Ma come? Non mi dirà che non lo sa! Nel rione lo sanno tutti. Certo che fa la strozzina. Approfitta dei bisogni della povera gente per specularci sopra, e poi va in chiesa tutte le mattine, ha capito?
La donna storse la bocca disgustata.
– Magari non dà mai una mancia, vero? – domandò insinuante.
– Ah, a me le mance non interessano, io faccio il mio dovere, pulisco anche dove sporca il suo cane, anche se lei dice di no. L’ho pregata una volta di fargli fare i suoi bisogni lontano dalla porta e mi ha risposto con una parolaccia.
– Ma davvero? A vederla sembrerebbe una persona così mite e modesta.
– Ha il diavolo nelle ossa quella, altro che andare in chiesa! – Come per intesa, le due donne si salutarono con un cenno e la portinaia riprese a pulire il selciato.
Arrivato sul ballatoio del suo piano, la signora Adelchi depose il cane sulle piastrelle e si avvicinò alla sua porta. Quasi contemporaneamente due teste fecero capolino dalla porta accanto, due teste incanutite di vecchie, vestite di lunghi abiti neri arricciati in vita.
– È arrivata!
– Buon giorno signora Adelchi, possiamo venire?
La vecchia diede loro un’occhiata di sfuggita poi, dopo aver sbuffato, aprì la porta.
– E venite, venite, dai Flic, fila dentro adesso che la tua passeggiata l’hai fatta.
Nell’austero salotto di noce, le due vicine si sedettero compunte sulle sedie rigide. Estrassero il rosario dalle tasche e una iniziò con una voce stridula:
– Nel primo mistero glorioso si contempla… – ma non poté finire perché la padrona di casa la bloccò con la mano.
– Aspetti un momento signora Adele. Prima devo dare da mangiare a questa povera bestia.
Andò nel cucinino ad armeggiare nel frigorifero ed estrasse un piatto con delle polpette e delle frattaglie.
– Toh, prendi Flic, mangia che sono buone.
Le due vecchie la rimiravano attente e compunte e quando alfine si lasciò cadere esausta sulla sedia, una riprese con la sua voce stridula:
– Nel primo mistero glorioso si contempla…
Ma non poté finire neanche stavolta perché la signora Adelchi aveva lasciato cadere pesantemente la mano sul tavolo, facendo traballare il portafrutta di porcellana.
– Prima di pregare dobbiamo parlare di alcune cose. Io sono stata a messa questa mattina; ne ho anzi sentite due. Una per qualche ateo che conosco io. Quindi parliamo d’affari. I soldi delle sigarette?
L’interrogata impallidì mentre la sua compagna si mordicchiava le unghie.
– Ma signora Adelchi le ho detto che me li portavano giovedì, e quel giovanotto è sempre stato così puntuale…
– Oggi è giovedì!
– Di già? Ma lui viene sempre nel pomeriggio dopo le cinque. Stasera glieli do, stia tranquilla.
– Io per mia abitudine – riprese subito l’Adelchi – mi sento tranquilla solo quando ho i soldi in tasca.
Poi si rivolse alla compagna della Adele.
– I soldi della pensione sono arrivati, signora Daniela? – domandò freddamente.
– Macché, non ancora, non capisco il ritardo. Queste poste funzionano così male.
La donna sbuffò mentre cavava di tasca un piccolo libriccino nero. Alla lettera S l’aprì e scorse alcune righe.
– Sono già tre giorni di ritardo e aggiungiamo un altro cinque per cento. Siamo già al quindici.
La Daniela impallidì e si mordicchiò le dita con maggior avidità.
– Ma signora Adelchi, che colpa ne ho io dei ritardi postali? Pagato il debito non mi rimarrà più niente.
– E devo rimetterci io allora? – rispose pronta infilando nuovamente il libretto da dove l’aveva tolto. – Mio marito m’ha lasciato quattro soldi e una pensione da morti di fame, se non ci penso io ad amministrarmi, non ci pensa nessuno.
La Daniela abbassò il capo e lasciò scivolare due lacrime che si fermarono sulla pelle increspata.
– Oh adesso non incominciamo mica a piangere , se no può andarsene a casa sua. Io non voglio mica la gente che frigna.
– Nel primo mistero glorioso si contempla… – attaccò decisa con voce lamentosa l’Adelchi facendosi il segno della croce, ma neanche stavolta poté continuare.
Flic che aveva finito di mangiare, si mise prima a ringhiare poi ad abbaiare correndo in corridoio.
– Dev’esserci qualcuno,ah già che sono le dieci. Filate di là in camera da letto e state zitte, guai se sento un rumore. – Mentre le due pie donnette si dirigevano obbedienti verso una porta, la donna si era alzata dalla sedia e inforcati gli occhiali tolti da un astuccio damascato, si diresse verso la porta.
– Chi è? – domandò decisa.
– Sono… sono il ragionier Prunetti – rispose una voce indecisa e flebile dall’altra parte della porta. – Le ho telefonato ieri. Posso entrare?
L’uomo, un tipo con occhiali a stanghetta cerchiati d’oro, si lasciò annusare i polpacci dal cane che ringhiava sordo.
– È… è pericoloso? – domandò inquieto.
– Ma no! Non vede che robino che è? Gli dà una pedala e lo getta via. Certo che se morde, male lo fa anche se ormai i suoi denti sono tutti cariati. Ma venga dentro, si accomodi, e tu Flic lascia stare il signore e fila in cucina.
Il ragioniere rimase ritto davanti al tavolo, con il cappotto abbottonato.
– Non è qui faccia molto caldo, ma se vuole togliersi il cappotto, lo può mettere lì, sulla poltrona.
– No, grazie, è che avrei premura. Ho chiesto un permesso di un’ora e non vorrei fare tardi. Sa, in ufficio badano a certe cose.
– Faccia come vuole. Cos’ha portato?
Con mal simulato imbarazzo l’uomo tirò fuori di tasca un pacchettino avvolto in carta leggera. Lo sfece e apparve un bracciale d’oro di lavorazione accurata.
– Mi piange il cuore venderle questo, sapesse cosa significa per me! – disse con voce quasi rotta dall’emozione, mentre la signora Adelchi come fosse trasparente.
– È un ricordo di mia mamma, la mia povera mamma. Ma lo prenda, lo guardi. Sono almeno centocinquanta grammi d’oro, e la lavorazione poi…
La donna palpeggiò sulla palma il monile con fare accigliato, poi sentenziò:
– Peserà sì e no settanta grammi, in quanto alla lavorazione, quella non conta un bel niente.
– Settanta grammi?!? – esclamò inorridito il ragioniere – ma no guardi che si sbaglia, è impossibile.
La padrona di casa non disse parola. Aprì la cassapanca e tirò fuori una bilancia con pesi. Appoggiò da una parte il braccialetto e mise un peso da cinquanta e due da dieci. La parità era precisa senza alcuna oscillazione.
– Questa non sbaglia mai, è perfetta, come tutte le cose vecchie.
L’uomo deglutì e si lasciò cadere sopra la sedia.
– Eppure io credevo… pensavo…
– Le do cinquantamila lire – disse la Adelchi tenendo tra le dita il gioiello.
– Cinquantamila? Ma se l’oro adesso vale più di tremila lire al grammo!
– Se lo riprenda allora e lo venda a chi le darà di più – e glielo gettò sul tavolo con malgrazia. L’uomo arrossì, fece per incartarlo ma ci ripensò.
– Sessanta no?
– Cinquantamila e non un centesimo di più. Prendere o lasciare e decidersi subito perché ho da fare.
– Va bene, vada per cinquanta, ma ci fa un affare.
– Io non ho bisogno di questa roba, ma lei dei soldi sì. Aspetti che li vado a prendere.
Tornò alcuni minuti dopo con cinque biglietti da diecimila in mano.
– Ecco, prenda. Oh, naturalmente mi garantisce che non è roba rubata vero?
– Ma signora, scherza? Glielo giuro sulla memoria di mia mamma che ho cara e sempre nel cuore.
– Se dice così, le credo. Fa sempre piacere della gioventù che vuole bene alla propria mamma, come una volta!
Uscito il visitatore, la donna aprì di colpo la porta che dava nella sua camera da letto e trovò le due amiche appoggiate al baldacchino che sgranavano sottovoce il rosario.
– Io devo uscire. Vado in banca. State attente a quella povera bestia. Adele, lo tenga lei che mi vuole venire sempre dietro. Fatevi un caffè e dategliene un po’ nel piattino che ne è ghiotto, non dopo averlo zuccherato.
– Ma non gli fa male il caffè? – chiese sorpresa l’Adele.
– So io quello che gli fa bene e quello che gli fa male. Dategli il caffè, che in meno di mezzora sono di ritorno.
– Possiamo finire il rosario prima? – domandarono quasi all’unisono.
– E finite pure il rosario – concesse la donna mentre si metteva lo scialle sulle spalle.
Avviandosi alla porta accompagnata dall’abbaiare di Flic trattenuto per il collare, sentì la voce di Adele levarsi stridula:
– Nel terzo mistero grandioso si contempla la natività. Dopo il lungo viaggio di Maria e di Giuseppe, dopo i rifiuti di ospitalità, in una grotta Maria dà alla luce il Bambino Gesù.
La cassetta di sicurezza è ormai piena. Bisognerà che ne prenda un’altra o un’altra più grande. Ne parlerò al direttore domani. Ma dov’è finito Flic. Flic, brutta bestia, vieni fuori da lì. S’è rifugiato sotto il letto per non farsi fare il bagno. Va bene, stai pure lì, intanto io ti riempio la vasca, che ti ho messo pure i sali al gelsomino. Tutte le volte che ti lascio andare torni a casa sporco come un maiale. Chissà dove vai, che razze di cagne frequenti! Vecchio come sei dovresti startene in casa con me, invece di andare a zonzo. Ma se torni a casa così lordo un’altra volta ti lascio fuori dall’uscio, altro che metterti ad abbaiare. Ti faccio portare via da quelli del canile!
Ecco, l’acqua incomincia a essere calda, stai lì, ci vorranno ancora dieci minuti, poi ti tiro fuori con la scopa! Ah, brutta bestia mi ringhi dietro eh?
Il campanello? Chi è a quest’ora? Chi viene in casa della gente all’ora di cena? Ah, adesso vieni fuori, eh? Sei curioso come una betonica, lui deve sempre vedere chi è che viene e chi è che va.
«Chi è?», domando, ma forse non mi sente perché il cane abbaia. «Piantala Flic, fila via» e gli do un calcio, piagnucola un po’ e se ne va in fondo al corridoio con le orecchie dritte. Guardalo com’è sporco. E pensare che ho dato la cera stamattina. «Chi è?» dico di nuovo e sento tossicchiare fuori dalla porta. «È la signora Adelchi?» mi chiede una voce da uomo. «Non è capace di leggere? C’è la targhetta fuori dalla porta».
«Mi scusi ma la luce del pianerottolo è così fioca» mi risponde, poi si ferma. «Beh, che vuole?» gli domando. E lui «Un amico mi ha dato il suo indirizzo, ho una cosa… una certa cosa da farle vedere». «Torni domattina, devo fare il bagno al cane e poi è l’ora di cena».
«Signora domani sarà troppo tardi. Devo pagare entro mezzanotte un debito di gioco e… e non so cosa mi può capitare. Ho bisogno di denaro».
Si era messo a parlare a voce alta, l’imbecille. «Ma parli piano» gli dico io mentre socchiudo la porta che lascio sempre con la catenella di sicurezza. Lo guardo. È un giovanotto sui trent’anni, magro, con un impermeabile chiaro. Ha le mani affondate nelle tasche. Mi sembra una persona per bene. Ha un viso aperto e uno sguardo sincero. «Un momento che apro», tolgo la catena e lo faccio entrare. «Lei è già stato qui» gli dico sicura del fatto mio. «No, signora, si sbaglia. È la prima volta». «No» gli rispondo secca. «Lei è già stato qui. Il suo viso non mi è nuovo». Lui allarga le braccia «Come crede signora, ma forse mi scambierà per qualcun altro». «Può darsi» gli rispondo mentre lo faccio entrare in sala, ma non sono convinta. Flic gli si mette a ringhiare contro e gli afferra i lembi dei pantaloni coi denti. Lui fa per accarezzarlo, ma lo morde. «Flic stupido, guarda cos’hai fatto, fila via brutta bestiaccia» e gli do una pedata di punta. Guaisce, abbassa le orecchie e si infila sotto la poltrona. «Mi faccia vedere un po’» gli prendo il dito ma non sanguina nemmeno. «Ha i denti ormai tutti smangiati, non è più nemmeno buono a masticare. Gli devo dare da mangiare polpette e formaggio molle. È vecchio». Lui sorride in uno strano modo. Io apro il cassetto con indifferenza e tiro fuori la vecchia Beretta di mio marito e la tengo in mano. «Giovanotto», gli dico «tanto per essere chiari, con chi non conosco la tengo sempre a portata di mano. Chi è che la manda?». «Chiaretti», mi dice senza far vedere di essersi spaventato troppo. «Chiaretti? E chi è? Non ricordo nessuno con questo nome». «Forse lei lo conosce solo col nome di battesimo, si chiama Franco», mi spiega mentre si slaccia l’impermeabile. «Franco quale?» indago io. «Ma Franco, quello della salumeria». Sì, un certo Franco della salumeria dall’altra parte della piazza era venuto un paio di volte da me, ma diversi anni prima. Non so più nemmeno se sia al mondo. «Ma come mai questo Franco si ricorda di me solo adesso?».
«Non saprei dirle signora», mi risponde sempre con un sorriso forzato, «gli ho esposto il mio problema e lui m’ha fatto il suo nome e mi ha fornito l’indirizzo».
«Va beh», mormoro senza perderlo mai di vista ma mettendo nella tasca del grembiule la rivoltella. «Mi faccia vedere cosa mi ha portato». Esita un momento poi tira fuori un astuccio ed estrae un anello di rubini, tempestato di brillanti. «Ecco» dice semplicemente.
È veramente un bel lavoro, fatto a mano, lo capisco subito. Solo la lavorazione dev’essere costata un patrimonio, il rubino è grosso ed emana una luce purissima, quei brillanti intorno poi… mi puzza di roba rubata e glielo dico chiaro. Lui inarca un sopracciglio «Rubata? No l’ho regalato a una mia vecchia fiamma. Ci siamo lasciati e me l’ha reso». Non ci credo troppo, ma mi viene da ridere. «Non mi venga a raccontare che una donna ritorna un anello come questo. Io non l’avrei mai fatto e non credo nemmeno che esista qualcuno capace di farlo». Lui allarga ancora le braccia e sorride, «Una l’ho trovata io, forse l’unica». Non l’aria di quello che è abituato a svendere la roba di valore per procacciarsi del denaro. Ha detto che deve pagare dei debiti di gioco e il tipo che si lascia prendere la mano dal demone del gioco ce l’ha. Ostenta un’aria abbastanza sicura ma dentro di sé dev’essere senz’altro turbato, ma si maschera bene. Eppure io quella faccia io l’ho già vista, tanto tempo fa, ne sono sicura.
«Quanto pensa di ricavare da questo?» gli domando a bruciapelo. Lui mi guarda assorto. «Non ho esperienza in questo genere di cose. A me serve mezzo milione. Può pagarmi così?». L’anello poteva valerne due di milioni o anche di più, ma storto la bocca e nego col capo. «No, assolutamente, qui trecentomila sono già tante, anzi duecentocinquanta. Questi sono gioielli per amatori. Se trovasse chi è interessato può ricavarne senz’altro di più». Lui sorride, stavolta ironicamente. «Certo, ma ci riesco a trovarlo prima di mezzanotte?». «Io le posso dare solo la metà di quello che lei ha bisogno, come fa poi?». Tira un largo respiro, strizza gli occhi, ecco quel gesto mi è familiare, se solo riuscissi a ricordare, ma la mente mi è un po’ confusa da un po’ di tempo a questa parte. «Vedrò di tacitarli con un acconto, poi mi darò da fare per trovare il resto», soggiunse alla fine. «Va bene, resti qui, vado a prendere i soldi. Dia l’addio al suo anello adesso». Lo lascio che se lo rimira con attenzione. Mentre apro la porta dello sgabuzzino, dove tengo la borsa coi soldi sento Flic che gli ringhia, quello stupido cane, poi una specie di tonfo e più niente. Torno in sala e non c’è nessuno, né l’uomo né l’anello e in terra c’è dell’acqua che viene dal bagno. La vasca, ho dimenticato il rubinetto aperto, e l’acqua è fuoriuscita. Corro nel bagno e vedo Flic che galleggia da un lato, mi chino e lo chiamo. Sembra morto, ma è morto! Affogato! Sento che la porta che mi si chiude alle spalle e due mani che mi serrano il collo e mi spingono verso la vasca. Porto la mano alla tasca del grembiule per prendere la pistola, ma me la fa cadere con un colpo di gomito che quasi mi spezza le costole. Ho bocca e naso immersi nell’acqua. Mi lascia andare un attimo per prendermi per i capelli e mi caccia dentro la testa. Mi lascia qualche secondo mentre cerco di trattenere il respiro e sento il cuore che batte convulsamente. Mi ritira fuori e mi dice un nome. Ecco chi è, sapevo di averlo già conosciuto anni prima. Me lo ripete tre, quattro, cinque volte all’orecchio con tono aspro, poi mi immerge con violenza. Sento le gote che si gonfiano, non riesco più a trattenere il respiro. Urto con la mano il corpo senza vita di Flic quando apro la bocca. Sento che la gola viene invasa dall’acqua. Poi un bruciore acuto allo stomaco, poi le mie braccia cadono lentamente nell’acqua. Mi sembra di galleggiare in un mare, poi affondo.
Adele e Daniela trovarono il corpo della loro amica, riverso nella vasca con la testa immersa dentro, vicino alla carogna gonfia del cane. Si inginocchiarono e recitarono un rosario prima di avvertire la portinaia. Venne trovato il taccuino della vecchia Adelchi fitto di nomi e di cifre e tutti vennero interrogati dalla polizia. Due risultarono senza alibi per la presumibile ora del delitto e vennero fermati. Non venne rintracciata la pistola che le sue amiche sapevano essere in casa e che era stata regolarmente denunciata.
Nota numero sei
– Stavolta è quella giusta – affermò categorico un donnone dal petto esuberante, mal contenuto da una guaina. Nessuno dei presenti le aveva prestato attenzione. Un giovanotto di ventidue anni camminava nervosamente avanti e indietro nel corridoio. Si fermò un attimo, per lasciare passare un’infermiera che spingeva un carrello pieno di medicinali, e riprese il suo moto. Mani dietro la schiena e capo chino, fissava le punte dei piedi, mormorava di tanto in tanto qualcosa di inintelligibile.
Il donnone si guardò attorno e visto che non c’era nessuno scosse le spalle di un ometto dalla testa quasi completamente calva che si era appisolato nell’unica sedia disponibile.
– Hai capito cos’ho detto? – ringhiò ferocemente – spero che sia la volta giusta!
– E speriamolo, speriamolo! – confermò il vecchio quasi automaticamente per riprendere subito dopo la posizione raccolta. La donna sospirò e alzò la mano al cielo guardando la porta numero cinquantanove della clinica Magistra.
In quel momento il dottore uscì dalla stanza, si tolse gli occhiali dalla grossa montatura di tartaruga guardandosi attorno. Il giovanotto e la donna gli si fecero appresso.
– Allora dottore? – chiese il giovane ansioso.
– Beh, che volete che vi dica? È sotto la tenda a ossigeno. È senza conoscenza. Se credete in Dio pregate, dal canto nostro faremo del nostro meglio.
– Ma cosa vuol dire esattamente? – chiese la donna fermando il medico e trattenendolo per il braccio. Questi le diede un’occhiata e lei lasciò confusa la presa. – Sì, insomma, volevo dire… ci sono speranze?
– Mia cara signora, più chiaro di così… Mi scusi ora, ho altri pazienti da visitare.
Due occhiacci seguirono le sue spalle mentre questi si allontanava per entrare in un’altra stanza.
– Hai sentito? Parlano sempre per enigmi. È grave o non è grave? – domandò rivolta al giovane.
– Ma mamma – le rispose sconsolato – mi pare sia stato esplicito. Uno che è sotto la tenda a ossigeno ha le ore contate. – La donna tirò un sospiro di sollievo indirizzando lo sguardo verso il marito che, rilassato sulla sedia, col capo reclinato, russava in modo discreto.
– Ma guardalo. Il vecchio sta morendo e lui è lì che russa. Dorme sempre, non fa altro che dormire, mi fa venire una rabbia…
– Ma lascialo stare, povero vecchio. Che male ti fa? È stato sveglio tutta la notte. Tu vai a casa che rimango io qui a prendere notizie del nonno.
– No, signorino. Tu devi studiare. Ci sei costato una montagna di soldi e adesso fai il piacere di filare a casa e di mettere la testa sui libri.
Il ragazzo rimase perplesso battendo la punta della scarpa, poi girò i tacchi senza salutare e infilò dritto la rampa delle scale.
Passò una suora dal portamento robusto che si fermò a osservare il dormiente.
– Poveretto. È un congiunto del ricoverato del cinquantanove?
– Sì, sorella – pigolò la donna – è il figlio. Io sono la nuora. Mi chiamo Lanzi, è proprio grave, eh, il malato?
– Eh sì, poveretto, non so nemmeno se riuscirà a tirare sera. – La signora Lanzi sospirò sconsolata, per subito riprendersi, sbatacchiò le ciglia e mosse i muscoli facciali per un sorriso di circostanza.
– Lasciamolo nelle mani di Dio. Certo che piuttosto che soffrire, poveretto…
– La nostra vita è nelle mani del Signore. Lui solo può decidere quando troncarla.
– Sì, ma le spese non le paga mica il Signore, le paghiamo noi, – disse tutto d’un fiato divampando in volto. Si conficcò l’unghia nella mano e allargò la bocca, – dicevo insomma che il Signore dovrebbe guardare un poco giù!
La suora la osservò compunta salutandola poi con un lieve cenno del capo.
– Sia lodato Gesù Cristo!
– Sempre sia lodato!
– Che voleva la suora? Novità del papà? – domandò il signor Lanzi che si era destato dal suo pisolino.
– Faceva la grande coi soldi degli altri. Non si vogliono sbottonare, ma mi sa che qui lo tengono in vita il più possibile per scroccarci del denaro.
– Ma insomma Maria, stai parlando di mio padre, che ci ha lasciato quello che ci ha lasciato. Se spendiamo dei soldi per lui, è nostro preciso dovere.
– Sì, ma i milioni fanno alla svelta ad andare. C’era bisogno di portarlo qui, in una clinica di lusso? Potevamo portarlo in un ospedale fuori mano, meno pretenzioso, dove potevano curarlo lo stesso con rette più accessibili. Ma lo sai che qui prendono sessantamila lire per la sola degenza? Se questo tira una settimana, passiamo il milione come ridere. E chissà cosa ci faranno pagare per la tenda a ossigeno.
– Maria, se non ti conoscessi dovrei scandalizzarmi. Sei così meschina e insensibile che non hai posto per alcun sentimento, ma solo per il denaro.
– Sentilo lui! Mi hai fatto passare una vita incolore, sciatta, opaca, poi finalmente quel vecchio avaro di tuo padre decide di cedere tutto a noi prima di morire per evitare le tasse di successione. Si vede che si sentiva già un piede nella fossa e da quando ci ha passato i suoi soldi e i suoi investimenti, si è ammalato. Facciamo un po’ di conti, avanti facciamoli, poi vediamo un po’ quel che rimane. Quello mi sa che l’ha fatto apposta.
Il marito sbuffò guardandosi intorno. Visto che il vestibolo era deserto, assentì lievemente col capo.
– E facciamo questi conti, ma parla piano, che qui non siamo mica al mercato.
– Oh sentilo, l’orecchia delicata! L’anno scorso il tuo paparino è stato male. Aveva bisogno di mare, ed è andato a Sanremo, in una clinica dove ci costava trentacinquemila lire al giorno. Quella ce la manteniamo da sei mesi. Poi l’ultimo attacco e dove lo si porta? Qui, nel posto dei milionari.
– Ma mio padre è milionario. Spendiamo i suoi soldi e non voglio più sentirti parlare in questo modo. Anzi ti prego, lasciami solo, torna a casa, stai dietro a Filippo ed evita di parlare di queste cose con lui, sai com’è attaccato a suo nonno.
– Ma cosa vale lasciarci i suoi averi se poi li dobbiamo spendere tutti per lui? Questa non è una clinica, ma una macchina mangia soldi. Appena abbiamo portato qui tuo padre, sono stata portata in economato e mi hanno chiesto subito un deposito di mezzo milione. A rendere nel caso non si superasse la cifra. Figurati se vedremo indietro qualcosa! – L’uomo sbuffò nuovamente e girò la testa dall’altra parte. La donna indispettita, mento all’aria, si diresse verso le scale.
Giunta a casa il figlio le si fece incontro.
– Ha telefonato adesso il papà; ci sono delle buone novità. Ha parlato col primario e pare che la situazione non sia del tutto disperata, anche se è da ritenersi purtroppo sempre grave.
– E sarebbero delle buone notizie? – disse fra sé la donna ondeggiando il capo. – Staremo a vedere – disse a voce alta e si pilotò in cucina. Aprì tutti i cassetti. L’aveva messo da parte ma non si ricordava dove l’avesse esattamente ficcato, finché tra le pagine di un ricettario spuntò fuori il ritaglio di un giornale.
“Madame Destiny predice il futuro. Riceve solo per appuntamento”. Seguiva il numero di telefono.
– Qui in casa non posso farlo. Se mi sente Filippo… scenderò a fare la spesa e telefonerò da un bar.
Dopo diverse insistenze riuscì ad avere l’appuntamento per le nove del mattino seguente. Il marito si dava il turno con Filippo ad assistere il moribondo le cui condizioni rimanevano sempre stazionarie. Si offrì lei per la veglia mattutina e alle otto e mezzo era già in clinica giusto in tempo per dare il cambio al figlio.
– Filippo vai a casa che rimango qui io per questa mattina. Il nonno come sta?
– Sempre lo stesso, non ha ancora ripreso conoscenza. Lo nutrono a fleboclisi – rispose sbadigliando.
Appena il figlio scomparve alla vista, la donna mise la testa dentro alla stanza cinquantanove. Osservò il letto circondato da un quadrato trasparente attraverso il quale si vedeva, offuscato, il volto terreo del morente. Aveva la bocca aperta e gli occhi chiusi.
– A vederlo così parrebbe morto – mormorò piena di speranza la signora Lanzi e mentre stava socchiudendo la porta, sentì un dito battere sulla sua spalla.
– Signora ma che fa? Non ha letto il cartello? È vietato entrare.
La donna si girò e si trovò davanti un’infermiera secca dai denti sporgenti.
– L’ho letto ma sa, è mio suocero, come sta? Mi sembra morto! – L’infermiera strabuzzò gli occhi e aggrottò la fronte. S’infilò nella stanza per dirigersi verso un’apparecchiatura a fianco del letto. Uscì subito dopo.
– Il polso è debole, ma c’è. Dorme.
Il donnone si lasciò andare sconsolata sulla sedia e finse di raccogliersi portandosi la mano davanti alla fronte. Appena il corridoio si fece deserto si alzò con agilità sorprendente, vista la sua mole, per dirigersi all’uscita.
Arrivò da Madame Destiny alle nove e cinque minuti.
– Lei è in ritardo – la redarguì la maga con voce gutturale – stavo per ricevere un’altra cliente.
– Mi spiace, ma il traffico sa… – e fu introdotta in una stanza semibuia al cui centro troneggiava un tavolino ricoperto da una tovaglia verde cupo con dei ricami eseguiti manualmente. Un mazzo di tarocchi era appoggiato in mezzo.
– Si accomodi e prenda tre carte.
La visitatrice scelse l’asso di picche, la donne di picche e il tre di quadri.
– Uhm – mugolò la scrutatrice del destino. – Mi dica cosa vuol sapere.
– Ecco – disse la signora Lanzi abbassando la voce e occhieggiando intorno per essere certa che non vi fosse alcuno ad ascoltare – ho mio suocero che è malato grave, vorrei sapere se potrà cavarsela oppure se dovremo rassegnarci.
Madame Destiny la fissò negli occhi. Le sue pupille brillavano nella semioscurità e la visitatrice ne ebbe paura.
– Lei non ha a cuore la salute di suo suocero, e gli vuole male, lo sento. È così?
L’interrogata arrossì, poi si conficcò l’unghia del pollice nella palma della mano.
– Ma cosa dice? E poi cosa le interessa? Io sono venuta a consultarla professionalmente, mi vuole rispondere allora?
L’indovina mischiò le carte che gettò aperte con mano sicura sul tavolo. Gliene fece scegliere tre.
– Ancora tre? Eccole!
Asso di picche, re di quadri e fante di picche.
Madame Destiny rimase perplessa, poi sentenziò:
– Morirà, ma non di morte naturale. Il fante di picche, lui penserà a ucciderlo. C’è un fante di picche, un uomo, che gli vuole male e che l’ucciderà.
Nel tratto di strada che la separava dalla clinica, la signora Lanzi si lambiccava il cervello per riuscire a immaginare chi degli uomini che conosceva lei potesse desiderare la morte del suocero. Scartati figlio e marito che si auguravano ben altro, non riusciva a pensare ad alcuno.
Venne rilevata alle due dal figlio, alla sera alle dieci il posto fu occupato dal marito.
– Il signor Lanzi? Stanza cinquantanove signore, ma è gravissimo, non può essere disturbato – disse la suora che stava alla ricezione.
– Non c’è nessuno che lo veglia? – domandò il visitatore avvolto in un giaccone di pelle col bavero di pelo alzato sino a coprirgli metà faccia. L’altra metà era coperta da un colbacco di pelo più chiaro calzato su tutta la fronte che lasciava liberi solo gli occhi.
– C’è sempre un parente fuori. Terzo piano.
Sbucato in corridoio il visitatore arrivò subito davanti alla porta che cercava. Seduto sulla sedia, quasi di fronte all’uscio, c’era il figlio con la testa reclinata sul petto, completamente addormentato. Si sentì un trillo e una lampadina si accese alcune porte più avanti. L’uomo si appiattì contro la parete. Poco dopo, da una stanza in fondo, uscì un’infermiera, si trattenne nella stanza alcuni minuti, per ritornarvi poco dopo con una bottiglia di acqua minerale. Poi il silenzio, rotto dal lieve russare del signor Lanzi figlio.
Si avvicinò con cautela alla porta cinquantanove ed entrò rapido.
«Ma che razza di cretini. Tenermi chiuso in questo affare di plastica. Ma che cosa credono che sia? E quella scema dell’infermiera? Le ho fatto cenno con la mano, ma non s’è data la pena di guardarmi. Quando mi ha infilato l’ago nel braccio mi ha fatto un male boia. Guarda quanti puntini che sulla vena, e com’è diventato grosso il braccio. Ma si può sapere cosa sto qui a fare? Io ho fame, non voglio nutrirmi con glucosio! Accidenti nel braccio destro c’è infilato l’ago e col sinistro non arrivo al campanello, ma dovrei trovare la maniera di ficcare la mano fuori da questo coso. E come ci riesco? Oh, entra qualcuno, è un uomo, forse un dottore. Ma non che non è un dottore. Non ha il camice, ha un colbacco e un giaccone col collo di pelo. Ah, ecco l’apertura, c’è una cerniera lampo, mi apre, bene! Ma cosa mi succede? Non riesco mica a parlare. I miei sono solo rantoli. Mi è andata via la voce! E per curarmi la voce mi mettono dentro quest’affare? Una tenda a ossigeno. Cosa vuole questo? Mi chiede se riesco a capirlo., mi ha preso per un encefalitico? Certo che lo capisco, vuole che gli faccia un segno con la testa, e accontentiamolo. Sorride. Ma non mi piace mica come tipo. Ha degli occhi freddi che fanno paura. Vuole sapere se lo riconosco, e chi l’ha mai visto? Gli faccio segno di no con la testa e mi sembra deluso. Si mette a parlare a voce bassa e gira sempre il capo verso la porta. Non capisco cosa dice. Poi mi fa un nome, ah sì, sì, ora sì che lo ricordo. Ma com’è cambiato, una volta era… era tutto diverso. E cosa vuole? Perché mi mette il fazzoletto sul naso? Non ho bisogno di soffiarmelo. Tento di fermargli la mano e sento l’ago che mi punge in profondità producendomi un dolore incredibile. L’idiota mi mette il fazzoletto sul naso e preme anche sulla bocca. Ma che gli prende, perché mai, mi chiedo? Me lo dice nell’orecchio. Mi sembra che le pupille mi schizzino fuori dalla cavità degli occhi. Sento lo stomaco che mi si gonfia. Se non mi toglie subito il fazzoletto rischio di morire soffocato. Agito la mano sinistra, vengo preso da un fremito, ma quello niente. Dice che vuole ammazzarmi, dice anche altre cose. Non riesco più a tenere gli occhi aperti, gonfio il torace, poi dentro qualcosa si lacera».
Il viso del signor Lanzi era tutto afflosciato, pareva che la notizia l’avesse fatto invecchiare di colpo di vent’anni. Le rughe della fronte e del viso si erano increspate, gli occhi erano arrossati. Suo figlio Filippo continuava ad asciugarsi gli occhi gonfi di pianto mentre la moglie concordava con quanto diceva il prete, con una espressione di circostanza.
– …appena sono stato convocato gli ho dato l’olio santo. È morto con tutti i conforti religiosi. Dio l’ha accolto tra le sue braccia. Non è più tornato in sé e non ha potuto confessarsi, ma la generosità del Signore gli avrà certo assegnato un posto tra i giusti. A proposito, la funzione funebre potrà essere pagata in economato.
– E va beh, tanto è l’ultima – sospirò la signora Lanzi. Solo il sacerdote captò la frase e strinse per qualche istante le labbra.
– Vi lascio soli col vostro dolore. Sia lodato Gesù Cristo.
– E sempre sia lodato – rispose la donna alzando le spalle e fregandosi istintivamente le mani. – Beh, è inutile che restiamo qui tutti. Bastate voi due. Tu sei suo figlio e tu il nipote. Io vado a casa. Il funerale è domani a mezzogiorno. Mangeremo alle undici, poi veniamo qui. Io intanto telefono a tutti i parenti e amici.
I due uomini non risposero, rimasero impietriti a guardare davanti a loro e a singhiozzare mentre la donna si allontanava soddisfatta.
La maga aveva avuto ragione. Sarebbe morto presto con il fante di picche. E chi sarà mai stato questo? Forse un medico che avrà sbagliato a fare una puntura. E sia benedetto il medico. Ne ammazzano tanti più giovani e sani che se anticipano un po’ un vecchio moribondo tanto di guadagnato, di risparmiato.
Chissà cosa volevano dire le prime tre carte che Madame Destiny le aveva fatto scegliere. Non aveva voluto dirglielo. Beh, per ventimila lire poteva anche darle quella spiegazione, ma comunque era stata sufficiente la buona notizia. Una cartomante seria quella.
Arrivò a casa e si attaccò al telefono. Ci vollero più di due ore prima che avesse provveduto a portare la ferale notizia al lungo elenco dei parenti che la osteggiavano perché l’accusavano del passaggio delle proprietà prima della morte del vecchio.
Quando poté sedersi in cucina a prepararsi un buon caffè con la napoletana, suonarono alla porta.
Un giovane sulla trentina con colbacco calcato in testa e con indosso una giacca di pelle con il collo di pelo le si presentò davanti.
– La signora Lanzi?
– Sì, lei chi è scusi?
– Vengo dalla clinica Magistra. Ho assistito agli ultimi momenti di vita di suo suocero.
– Oh – disse sorpresa e si scostò per lasciarlo entrare. – Ma prego, si accomodi. Stavo facendomi un caffè, ce n’è per due se vuole favorire in cucina, e si tolga pure la giacca.
L’uomo si tolse il copricapo e sin allentò la cintura. Si sedette sulla sedia vicino alla cucina a gas posando il berretto sul tavolo.
– Mi trattengo pochi minuti. Poi devo tornare.
– Ah capisco. Mi scusi devo girare la napoletana. Ma dica, voleva dirmi qualcosa?
– Sì, suo suocero m’ha pregato di venire da lei e dirle che l’aspetta. Almeno così ho capito. Parlava con un filo di voce e nemmeno chiaro.
– Ah sì? – domandò non molto interessata mentre versava il caffè in due chicchere di gres. – uno o due cucchiaini di zucchero?
– Lo prendo amaro, grazie.
Il donnone porse la tazzina e mescolò la sua in cui aveva messo tre cucchiaini abbondanti di zucchero.
– Sa una cosa? Mi sembra di averla già vista da qualche parte. Forse in clinica. Lei è un dottore?
– In un certo senso sì – rispose e tracannò d’un fiato il liquido nerastro.
– Brucia, eh? – domandò la donna.
– Mi piace caldo – rispose sorridendo.
Maria lo osservò bene. Era un po’ stempiato, occhi freddi e un sorriso un po’ enigmatico. Sì che l’aveva conosciuto, ma non in clinica, tempo prima, ma in quale occasione?
– Mi può dare qualcosa d’accendere per favore? Vorrei fumare ma ho dimenticato i cerini.
La signora Lanzi si girò per prendere i fiammiferi da cucina che porse nella mano del visitatore.
– Ma dica un po’, ha detto proprio così: ditele che l’aspetto? Forse voleva che andassi a trovarlo? Strano, mio suocero aveva una spiccata antipatia per me. Pensi che quando mio marito m’ha sposata si è persino rifiutato di venire al matrimonio.
– Io sono venuto a riferirle quanto mi ha detto signora. Altro non so. Era mio dovere, lei capisce?
– Certo, certo – e in due sorsi bevve il caffè che non era dei migliori, ma era un po’ eccitata.
– Ma sa che sono convinta di averla già conosciuta. Più la guardo e più ne sono sicura.
– Forse in un’altra vita – rispose l’uomo e rise, ma fu un attimo solo. Il suo riso si spense in un sorriso tirato.
– Bene signora, se permette io andrei.
– Ma certo, l’accompagno alla porta. – Il donnone fece per alzarsi, ci riuscì per metà, barcollò, investì la sedia e rovinò a terra.
– Ma… ma che mi succede? Sento… sento… la testa che mi gira… la vedo in maniera confusa… forse sto male…
– È solo del Valium, signora Lanzi. La intontirà un po’. Io gliene ho versato una boccetta intera. In genere l’usano per curare gli schizofrenici. Non morirà stia certa, non per quello almeno. Ma le impedirà di muoversi e quando il gas avrà saturato l’ambiente…
– Gas? Ha detto… gas? – domandò ansante.
– Sì. Ora spengo la sigaretta. Chiudo bene la finestra e apro il rubinetto. Ci mettiamo sopra la napoletana. Sembrerà che se la sia dimenticata e… Forse le faranno un’autopsia, ma il Valium è un calmante e, data la tensione di questi giorni, risulterà del tutto naturale che lei ne abbia fatto uso.
– Assassino… assassino… ma perché? – riuscì a dire con uno sforzo la donna riversa sul pavimento, mentre il gas incominciava a fuoriuscire con un lieve sibilo.
– Glielo dico appena sarò certo che non riuscirà a chiuderlo, – le rispose freddamente l’uomo.
– L’asso… l’asso di picche. Le tre carte che ho… scelto prima – la donna tossì. Riuscì ad alzare lo sguardo per osservare il suo giustiziere. L’uomo si teneva un fazzoletto davanti alla bocca. Richiamò dentro se stessa tutta la sua forza e strisciando riuscì ad arrivare vicino alla cucina a gas. Le manopole però erano in alto. Tentò di alzarsi ma ricadde pesantemente su un fianco. L’aria cominciava a essere satura di gas. L’uomo si chinò su di lei e disse qualche parola. La donna sbarrò gli occhi.
– Mas… Massimiliano – gemette, poi tornò a tossire. La bava incominciava a uscirle dalla bocca.
L’uomo si alzò e uscì dalla cucina richiudendosi la porta alle spalle.
 Settima nota
Settima nota
Maria Letizia Borromei puntò il suo nasino davanti all’uomo dalla barba ispida e dai lunghi capelli incolti.
– Ma io ho un appuntamento con Rocky. Devo intervistarlo! – disse indispettita.
– Abbia pazienza ancora qualche minuto. Sta finendo di registrare poi sarà da lei. Vede quella luce rossa sulla porta? Ecco, se lei entra manda a monte la sua registrazione. E Rocky andrebbe su tutte le furie.
– E va bene, ma eravamo d’accordo che mi aspettasse prima di registrare. Aveva detto alle cinque e mezzo, e adesso sono le cinque e ventidue. Non ha mantenuto la parola.
Il ragazzo si grattò la barba sorridendo.
– Le sale di registrazione costano un pozzo. Sarà venuta libera prima. Ma ecco là il suo manager, se intanto vuole parlare con lui. Si chiama Claudio Berreta, ma tutti lo chiamano Clyde.
Maria Letizia andò vicino a un uomo dai capelli che gli cascavano sulle spalle, ben curati, dal viso ornato da due baffi alla moicana e da un paio d’occhiali a lente rotonda e stanghetta di metallo bianco. Stava parlando sottovoce con tre ragazzi, eskimo verde e blue-jeans sdruciti, che continuavano ad assentire. Dopo avere pronunciato alcune parole univa pollice e indice della mano destra e muoveva il capo con gesto imperioso e i tre confermavano sempre con la testa e con qualche mugugno.
– Signor Clyde, io sono Maria Letizia Borromei, dovevo intervistare Rocky per “Noi Tutte” e assistere alla registrazione del suo ultimo pezzo. Sono arrivata in anticipo, ma lui sta già registrando – pronunciò tutto d’un fiato con un tono di voce un po’ irritato.
– Ma cara Maria Letizia – proruppe rumorosamente il manager battendo le mani sull’avambraccio della ragazza – chiamami Clyde e diamoci del tu, che è mai questo formalismo borghese? Ma siediti, vuoi un caffè? Una coca o una fanta? Lì c’è il distributore automatico.
– No, grazie – rispose sempre indispettita la giovane – ho già preso un caffè prima di venire qui – e si sedette compunta su un seggiolino di legno.
– Ma bene, allora dove scrivi? Ah, già sì “Noi Donne” hai detto vero? Bel giornale, mi piace un sacco. Io sono sempre stato un femminista.
– La rivista si chiama “Noi Tutte” – lo corresse aggressiva la ragazza.
– Ma sì, noi tutte, noi donne, tratta di problemi femminili, no? Poi io ho l’idiosincrasia per i titoli. Pensa un po’ che mi dimentico sempre anche di quelli di Rocky. Sai come dicevo io del suo ultimo successo, quello che è da tre mesi in hit-parade? “Non ti posso mollare” invece di “Non ti lascerò andare” – e proruppe in una fragorosa risata sotto lo sguardo gelido della ragazza.
– Volevo assistere alla registrazione di Rocky perché ero interessata al testo. La sua ultima dichiarazione, quella di una nuova ideologia no… Rocky si è detto novello apportatore di un verbo, per usare le sue parole, ha fatto scalpore tra il mondo dei giovani. La nostra rivista, che come lei ha ben detto tratta di problemi femminili, è aperta a ogni nuova forma che vada contro questo sistema repressivo e soprattutto antifemminista.
Clyde la osservava sbalordito.
– Ma ragazza mia, parli come un libro stampato e continui a darmi del lei. Certo, Rocky è stato il primo a schierarsi per i diritti della donna, parità, parità su tutto, in tutto e per tutto. Rocky sa che tramite le sue canzoni porta dei messaggi ai giovani. Ma non si limita alle parole, passa anche ai fatti. L’altro giorno ha dato un concerto privato in un ospedale, senza volere una lira eh, per i ragazzi antispastici o antiplegici, accidenti non ricordo bene. Giacomo, – urlò l’uomo verso dei ragazzi che confabulavano tra loro – dove cacchio è andato Rocky a fare quel concerto per i moribondi?
– Dai ragazzi paralitici – disse uno.
– Ecco, paralitici – confermò Clyde annuendo e gesticolando con le mani.
– Beh, queste cose le hanno fatte un po’ tutti e la notizia è stata riportata da parecchi giornali. Un po’ di pubblicità, non le pare? Se Rocky vuole essere veramente il nuovo Messia deve essere…
– Ecco, silenzio, fermati – il manager aveva portato il braccio alla fronte e gettato il capo all’indietro – ripeti quello che hai detto, ma scandendo bene le parole.
Maria Letizia era confusa. Arrossì lievemente e congiunse le punte delle scarpe.
– Ma non lo so, cosa ho detto? Dicevo solo che se Rocky vuole essere veramente il nuovo Messia…
– Ecco, questo, il nuovo Messia – e Clyde pronunciò le ultime parole a voce stentorea. – Il nuovo Messia, giusto, Rocky è il nuovo Messia, e attraverso i dischi, la radio, la televisione ei concerti lui porta il nuovo verbo, quello della fratellanza, dell’uguaglianza, della giustizia e della libertà.
– Fraternité, liberté et égalité – disse compunta e un po’ ironica la ragazza.
– Ecco, sì, in latino fa sempre effetto, ma è meglio in italiano – confermò l’uomo che si agitava tutto – non dobbiamo dare l’impressione di voler essere dei classisti, tutt’altro, Rocky è per i negri, per gli arabi e per tutti i popoli che non possono avere autodeterminazione.
– Sono cose molto belle, Clyde – e la ragazza sorrise a mo’ di scherno – ma si può avere almeno il testo della canzone, e sapere come si chiama? È poi vero che li scrive lui, testi e musica?
– Ma certo, certo! Ma il testo dattiloscritto te lo faccio avere subito dalla segretaria di produzione. Ma dov’è quella scema di Concetta? Sì, dai lavoro ai terroni, quelli se la prendono calma calma. Capisce poco e non fa niente. Rocky è troppo buono.
In quel momento si spense la luce rossa e pochi istanti più tardi uscirono alcuni orchestrali con gli strumenti in mano.
– Rocky ha finito! Vado ad avvertirlo che sei qui Maria Pia, aspettami e non ti muovere eh? – e le mandò un bacio con le dita.
Rocky era seduto su uno gabellino nella stanza dei comandi. I capelli biondi naturali con lievi riflessi verdognolo cupo, il bicchiere di cognac in mano, camicia di raso blu, aperta sino all’ombelico e uno sguardo corrucciato. Il fonico stava riavvolgendo il nastro.
– Dai Gionni sbrigati, che voglio risentirlo, mi sembra che ci sia un ottone che stoni.
– Ma no, Rocky, ti dico che è perfetto. La tua interpretazione poi è stata davvero grande. Supereremo subito il milione di copie. E sei ancora in testa alla hit-parade con “Non ti lascerò andare“.
– Pattumiera! – disse il cantautore tracannando una generosa sorsata di cognac. – Quella roba è zozzura, non ne voglio neanche sentire parlare. Una cosina sdolcinata. Basta! Questa sì che è roba elettrizzante.
– Rocky, Rocky, sei stato grande, grande come sempre, anzi meglio di sempre, – disse Clyde abbracciandolo. – Dammi un sorso di quella roba, e devi berne meno o ti rovinerai il fegato. Vacci piano.
– Sei venuto qui a rompere Clyde? Fammi sentire qualcosa di più interessante. – Il nastro era completamente riavvolto ma il tecnico puntò lo sguardo sul manager che estraeva di tasca un taccuino.
– Ah sì, ecco allora, domani alle sei ho appuntamento con quelli della Fantastic Records. Offrono il dodici per cento di royalties ma io gli ho risposto cacca! Ho detto che il quindici ce lo possiamo avere dalla Novelty Records e se non ci offrono di meglio rinnoviamo il contratto. Sono rimasti annichiliti, ma hanno confermato l’appuntamento, vedrai che ci mollano il sedici con duecento milioni di minimo garantito da versarsi alla firma.
– Okay, okay, d’accordo, non mollare sul sedici se puoi, ma al quindici accetta e porta i milioni a trecento. Altro?
– Sì, dunque ci sarebbe una richiesta da parte di un ricovero per vecchi. Ti vorrebbero per presenziare alla ricorrenza di non so quale patrono. Canti un paio di canzoni e te la fili.
– Quanto offrono?
– Ma niente, sono squattrinati, anzi contano sulla tua presenza per una questua per ampliare i dormitori o i refettori o qualcosa del genere.
– Si possono attaccare. Io per delle vecchiacce e dei vecchi rottami canto solo se pagano. Vogliono sfruttare il mio nome per tirare su della grana, e che paghino allora!
– Ma Rocky, la pubblicità dove la metti? Oh, a proposito, ho trovato il nuovo slogan per lanciare il nuovo singolo e l’ellepi, ti va: “Il nuovo Messia“? Eh, dai ammettilo, ho un grande cervellone, eh? Dai! – e gli diede una pacca sullo stomaco.
– Ma tieni ferme quelle manacce, sì mi va! E il lancio? Voglio lo spettacolo del sabato sera, devo essere l’unico ospite d’onore. Ma scenografie, niente micragnosità, l’austerity la facciano gli altri. Voglio roba in grande col nome scritto a caratteri cubitali tutto illuminato a intermittenza, se no ti faccio saltare il contratto!
– Ma certo, certo Rocky, stai tranquillo – bofonchiò Clyde impallidendo, – non ti ho sempre accontentato? Non ho sempre fatto quello che volevi tu? In me non hai un manager ma un amico, un fratello, devoto e dedito solo al consolidamento del tuo successo.
– Sì, sì, va beh, adesso smamma che voglio sentire la registrazione.
– D’accordo Rocky, ti aspetto fuori. Andiamo a mangiare tutti insieme da Nando e… oh, a proposito c’è di là una stronzetta di un giornale femminile tutta sulle sue perché l’avevi invitata alla registrazione e poi hai iniziato prima. Che faccio? La scarico?
Il biondo finì il contenuto del bicchiere e fece una smorfia.
– È un bel pezzo di manza?
– Beh, bellina, con il naso all’insù. Un tipo che si da un po’ d’ariette. Non so se è il tuo tipo.
– Mandala dentro e poi non rompere più le balle.
Maria Letizia mise piede nella cabina di registrazione mentre le prime note di “Vogliamo la libertà” si spandevano nell’aria. Rocky schioccò le dita indicandole uno strapuntino. La ragazza si accovacciò facendo attenzione a non scoprire troppo le ginocchia e rimase immobile per tutta la durata dell’audizione.
Quando l’ultima nota di una chitarra si perdeva in lontananza per l’effetto del missaggio, il cantante dette una pacca sulla spalla del fonico.
– Avevi ragione Gionni, è veramente grande. Sei sempre in gamba.
– Hai fatto tutto tu, Rocky. Sei tu il cervello, io sono solo un braccio meccanico.
– Allora pupa – disse allargando la bocca e mostrando i denti bianche e perfetti – che te ne pare? Una bomba, vero?
– Sì, non è malaccio. Il motivo è orecchiabile, il testo è un po’ banalino però – concesse la ragazza.
Un muscolo della faccia si mosse rapido chiudendo l’occhio sinistro di Rocky per una frazione di secondo.
– Testo banalino? Ma stai scherzando? Ci ho impiegato due notti con simpamina per cavarlo fuori, per limarlo, aggiustarlo e renderlo funzionale con la musica.
La ragazza si passò un po’ imbarazzata la lingua sui denti.
– Mi spiace signor Rocky, ma questa è la mia opinione. Parole del genere le ho sentite sin troppe volte e credo che siano diventate un po’ troppo conformiste. Mi aspettavo di più. – Il cantante la osservò duramente, con gli occhi arrossati e vogliosi. Soffiò sul ciuffo che gli cadeva sulla fronte e, sorridendo, lasciò andare la mano sulla natica di Maria Letizia.
– Mi piaci, sì mi piaci pupa, e sai perché? Perché non lecchi il culo come questi stronzi che mi girano attorno come le api col miele. Ti piace questa simil…
– Similitudine vuole dire? – rispose la ragazza staccando la mano del ragazzo dalla sua coscia – sì, molto, è soprattutto nuova.
Rocky rise sgangheratamente attirando la ragazza a sé, che si svincolò con decisione.
– Ollalà, come siamo pudibonde. Non ti volevo mica violentare sai – e giù un’altra risata. – Gionni dammi il cognac che offro da bere alla signorina…
– Maria Letizia Borromei, giornalista di “Noi tutte”.
– Ecco alla mia amica Maria Letizia. Le piace il cognac?
– In genere lo bevo dopo cena, ma un sorso, solo uno però. – Rocky si riempì generosamente il suo bicchiere dopo averne passato uno abbastanza colmo alla ragazza.
– Ma lei beve sempre e solo cognac? Lo trangugia come fosse acqua fresca – domandò sorpresa la ragazza dopo che d’un sol fiato il cantautore aveva ingollato tutto il liquido.
– Eh – rispose con voce rauca, – sì, sempre e solo cognac. E non un cognac qualsiasi, ma quello spagnolo, e sai perché? Perché è più stagionato di quello francese. La Spagna non ha avuto l’invasione nazista, mentre i crucchi si sono portati via quello della Francia! Eh? – disse trionfante strizzando l’occhio – sono in gamba o no?
– Osservazione molto acuta. Di chi è? Del suo manager? Di Clyde?
– Chi, quello? Ma è uno stronzo, un galoppino. Lo tengo con me solo perché mi fa pena. Se gli dessi un calcio nel sedere e lo gettassi sul marciapiede, morirebbe di fame – e si colmò il bicchiere con altro cognac.
– Adesso mi rifaccio un po’ l’alito e poi andiamo a mangiare io e te e ti rilascio tutta l’intervista che vuoi.
– Veramente io stasera avevo un impegno – rispose Maria Letizia con freddezza.
– E non lo vuoi rimandare per me? – gli chiese Rocky mettendole una mano sul seno.
– Ma insomma, tenga giù le mani – squittì seccata la giornalista.
– Non porti il reggitette, eh? Bene, mi piacciono le donne “nature”. Senti come pronuncio bene il francese? E pensare che non l’ho mai studiato.
– Si sente, anche – gli rifilò seccata la ragazza puntando il mento.
Rocky ebbe una vampata in volto. Si girò verso il fonico che stava staccando tutti i contatti.
– Gionni fila fuori che do qui l’intervista alla signorina, e dà ordine di non seccarmi per nessuna ragione.
– D’accordo Rocky, qui è tutto spento.
Uscito il tecnico, Rocky si versò dell’altro alcol nel bicchiere.
– Ma lei ce l’ha ancora il fegato? – domandò ironicamente la ragazza osservandolo a braccia conserte.
– Qualcosina dev’essermi rimasto – e tracannò tutto d’un fiato. Tossì, poi si diresse verso la ragazza. – Come la dobbiamo fare l’intervista? Registri, annoti o cosa?
– Tengo tutto a memoria. Dica pure, l’ascolto.
Rocky le balzò addosso e la strinse forte a sé.
– E piantala con quell’aria da esercito della salvezza, mi piaci, te l’ho detto.
– Mi lasci andare o urlo!
– Le porte sono antiacustiche, non ti sentirà nessuno! – E la strinse nuovamente a sé con violenza. – Fai la brava – le sussurrò all’orecchio mentre le slacciava la lampo con un colpo secco – ti do il servizio in esclusiva e tutto quello che vuoi.
Non ottenne risposta e nemmeno resistenza.
Che male di testa! Mi sta scoppiando e un tarlo trapana il cervello. Ho già lo stomaco in panne. Ma cosa mi hanno dato da bere quegli stronzi? Roba fatta con i fichi o chissà che cosa, e poi con tutta l’erba che ho fumato… Maledizione, ma quel trillo che ho nella zucca non è altro che il maledetto telefono. E dov’è? Ah sotto il letto. «Pronto!» macché non è lui, allora suonano alla porta, ma che ora è? Le cinque e mezzo di mattina! Ma chi è quel folle che viene a svegliarmi proprio adesso che stavo per addormentarmi? Se è quel rompiballe di Clyde è la volta che gli rompo il grugno. Apro e mi trovo davanti un tizio che non ho mai visto. Smilzo, vestito di scuro. «Rocky» dice e non si capisce se è una domanda o un’affermazione. «Fratello» gli dico «chiunque tu sia mi hai gettato giù dal letto, quindi entra». Poiché dormo sempre nudo m’infilo un paio di slip e un maglione. Mi verso da bere del cognac e quando torno nell’atrio non lo trovo più. Guardo attorno e me lo ritrovo sprofondato in una poltrona in sala, con un taccuino e una matita in mano. «Ah sei qui? Vuoi un goccio?» gli offro porgendogli il bicchiere, ma quello rifiuta con la mano e mi sorride. Ha una faccia antipatica. Dovrei prendere un cachet per il mal di testa e qualcosa per tirarmi su. Butto giù l’alcol e sento un bruciore tremendo e lo stomaco che si contrae. Mi lascio cadere sul divano e piombo sul bracciolo e ci casco letteralmente dentro. Quello mi guarda con quel sorriso ebete e non dice una parola. Mi rendo conto dell’assurdità della situazione e glielo dico. «Vorrei sapere alcune cose: primo come hai fatto a entrare. Secondo chi cavolo sei; terzo che diavolo vuoi. Rispondi pure!». Lui assente. Sorride ancora e mi viene voglia di tirargli il bicchiere in faccia. «Sono un giornalista del Transcontinental Music, dovevo intervistarla ieri sera» mi dice pacifico e serafico. «Cristo!» dico io comprimendomi la bocca dello stomaco, «dovevi venire ieri sera, e non ti sei fatto vedere e per farmi un’intervista vieni a quest’ora del mattino? Io dormo sempre fino a mezzogiorno o anche alla una. Adesso sparisci e fissa un altro appuntamento che me ne ritorno a letto». Quello manco si muove. Scuote lentamente il capo e sorride. Ha una fossetta sulla guancia destra.
«Oh, hai capito? Ti ho detto di smammare, di filartela, non sei mica sordo vero?».
«No» risponde, «non sono sordo, ma io alle nove devo mandare il pezzo altrimenti non se ne parla più non so fino a quando. Dai Rocky non fare le bizze che ti stendo quattro cartelle per gli americani e vedrai che sfonderai anche laggiù». «Oh, pezzo di merda» gli rispondo risentito, «credi che abbia bisogno di quattro righe buttate giù alla carlona da un nessuno come te? Ma sai con chi stai parlando? Con Rocky, il nuovo Messia!». Mi sono alzato in piedi ma ricado giù di colpo. Quello scemo si mette a sghignazzare. «Andiamo Rocky, incomincia a dirmi quanti anni hai e quando hai incominciato, tanto per rompere il ghiaccio,» aggiunge quando ha finito di ragliare. Bene, i casi sono due, o lo sbatto fuori a pugni o sto al gioco. Viste le mie condizioni devo rinunciare alla violenza e gli rispondo: «Ho ventisei anni, e sono tre anni che incido, prima ho girovagato un po’ dappertutto, chiedendo l’elemosina ai capoccioni del settore che mi scartavano perché dicevano che ero troppo acerbo. Adesso le teste d’uovo vengono qui a leccarmi i piedi e a scongiurarmi di incidere per loro. Ce n’è uno che ho lasciato ad aspettare per tre ore, poi gli ho mandato a dire che non volevo riceverlo. Se n’è andato lanciandomi insulti e improperi. Poi il giorno dopo mi manda dodici bottiglie di Dom Perignon del sessantaquattro, con un bigliettino con scritto “va a cacare!”». Stavolta sono io che sghignazzo, lui non muove un muscolo della faccia. Mi secco. «Senti fratello,» gli dico «visto che ormai sono sveglio, tanto vale che lo sia del tutto. Io vado a farmi un bagnetto. L’intervista la continuiamo lì. Tanto un maschietto sei tu e maschietto sono io. Non sarai un orecchione, vero?». Storta la bocca. Bene, meglio così. Filo nel bagno e apro l’acqua che scende copiosa e calda. Lo sento arrivare alle spalle e fermarsi sulla soglia. Dal vetro lo vedo tutto compunto appoggiato allo stipite. Non parla e mi va bene. In fin dei conti questo stronzo mi può anche venire utile. L’America è sempre l’America e cosa ci vuole a bestemmiare qualche parola in inglese? Niente! Ecco, l’acqua e pronta. La schiuma è bella soffice, mi lascio cadere dentro mollemente e chiudo gli occhi. Mettendomi in ammollo mi tiro su e riprendo forza. «Posso farmi la barba?» mi domanda il giornalista. «Ma sì, fatti quello che vuoi. C’è il rasoio elettrico e la lametta, come preferisci». Dal ronzio capisco che ha optato per il Braun. Mi sento proprio bene, l’acqua è bollente e mi sto per appisolare. «Senti fratello, mi viene voglia di dormire. Se vuoi veramente fare quel pezzo è meglio che parli, così mi tieni sveglio». Il ronzio cessa. Lo sento muoversi. Sento qualcosa di leggero che mi passa sui polsi e provo un senso di caldo particolare. Apro gli occhi e quel becero mi ha tagliato le vene con una lametta.
«Oh, ma sei scemo?» gli urlo cercando di alzarmi, ma quello mi spinge giù per le spalle. «Che ti salta in mente? Vuoi ammazzarmi?» «Non con le vene tagliate» mi risponde con un tono di voce come se dicesse che non gradisse il ghiaccio nel cognac. «Ma cosa vuoi da me?» gli chiedo non spaventato ma irritato. «È uno scherzo di dubbio gusto». «Come i tuoi, Francesco». Ah così questo mi conosce, bene. «Asino, prepotente e rissoso» mi dice fra i denti. Spalanco gli occhi e tiro fuori un braccio. Il liquido rosso che esce dalle mie vene mi macchia il petto. Mi dà fastidio la vista del sangue e mi sciacquo subito. «Senti, lo scherzo è stato molto divertente, adesso dammi l’alcol che è lì nell’armadietto». «Nemmeno per sogno. Ti stai suicidando Rocky. Il successo ti ha disgustato. La vita non ha più senso per te e hai deciso di morire». Mi parla con un tono di voce che non mi piace per niente. «Ma chi sei?» gli chiedo. Me lo dice sillabando il nome. «Tu?! Accidenti non ti avevo riconosciuto proprio. Ma quanto tempo è passato? Dieci? Quindici anni?». «Sedici per essere esatti» mi risponde sorridendo. Molla la presa sulla spalla e si dirige al lavabo. Io tento di uscire. Quello riaccende il rasoio elettrico e lo getta nell’acqua.
Il mio corpo viene scosso da un fremito.
Il salone delle riunioni era pronto con tutti i dettagli. Magda, la segretaria dell’amministratore generale, diede una veloce occhiata intorno per vedere se tutto era in ordine. Ad ogni posto c’era un blocco con una matita perfettamente temperata. Un bicchiere vuoto e una bottiglia di acqua minerale. Vicino alla poltrona dell’amministratore era installato un grosso registratore, con dei cavi che erano infilati a tanti microfoni posti ognuno frontalmente alle poltrone; i portacenere erano a destra di ogni convenuto, con dei fiammiferi a strappo.
Il direttore amministrativo fu il primo ad arrivare: classico doppio petto blu, camicia bianca e cravatta scura, si portò in un angolo del salone, dopo avere deposto sul grande tavolo di ebano la cartelletta con tutte le sue note. Si mise a rimirare fuori dalla finestra con uno sguardo assente, tutto concentrato in cifre che riportava mentalmente.
Il responsabile della produzione, Marco Baneri, entrò circa cinque minuti dopo. Spense il suo sigaro e notò la presenza del collega.
– È già qui Franzosi? Ma è una stupida domanda la mia, lei è sempre il primo ad arrivare. La scienza della matematica implica anche quella della precisione, conseguentemente è d’uopo la puntualità – e sghignazzò per alcuni istanti. Visto che non ricevette altra risposta che un lieve cenno del capo, si sprofondò nella poltroncina di pelle che occupava abitualmente in occasioni del genere e si mise a sua volta a spulciare degli appunti estratti dalla tasca.
Il dottor Balestri della contabilità generale arrivò assieme al capo ufficio progettazione Tarchini. Esaminò la bottiglia di minerale ed ebbe un’espressione di disgusto.
– Acqua, sempre acqua. Non c’è un goccetto di whisky, oppure vodka, qualcosa di forte insomma.
Tarchini indicò con un sorriso un mobiletto bar al lato nord della stanza.
– Sì, lo so, ma il capo non vuole che ci si serva senza che lui sia presente e mai prima delle riunioni.
Poggiò la cartella sul tavolo e si lasciò cadere nella poltrona di pelle, appoggiando le ginocchia al tavolo.
Tarchini gli si sedette di fronte. Aprì la sua cartellina e depositò con ordine sul tavolo alcuni fogli.
– Manca solo il capo del personale e naturalmente sua eccellenza – disse con un tono ironico. Nessuno gli rispose, così si immerse nella lettura dei suoi appunti.
La signorina Magda, una bella ragazza slanciata sui venticinque anni, entrò nell’ufficio dell’amministratore generale, dopo aver sfiorato con le nocche il pesante uscio.
– Dottor Forti, manca solo il capo del personale. È stato trattenuto in stabilimento per una vertenza. Ha telefonato dieci minuti fa che partiva in quell’istante. Dovrebbe essere qui a momenti.
Il dottor Forti la guardò con odio.
– Lo sa che non voglio ritardi a queste riunioni. Niente che potesse essere rimandato?
– Credo di no, dottore. È per quella faccenda dell’operaia, quell’Amalfi…
– Ah sì – tagliò corto il responsabile primo dell’azienda agitando la mano. – Va beh, appena arriva mi avverta con l’interfono.
Uscita la ragazza, si infilò nel bagno personale e andò a lisciarsi i capelli corvini che aveva impomatato con la consueta cura. Con la spazzola si mise in ordine i baffettini, si sciacquò le mani e si passò sul viso un’abbondante razione di colonia dal profumo aspro. Nel salone i quattro convenuti si erano assisi ai loro posti e si guardavano in silenzio.
– Tre minuti di ritardo! – esclamò Balestri tirando a sé l’orologio da polso, modello antiquato. – Strano. Succede ben di rado. Tempesta in vista?
– Non vede chi manca? – chiese quietamente Tarchini. – Non c’è il capo del personale, chiamato in fabbrica per sbrogliare una delicata matassa, ovvero se una operaia, che abbia usufruito della licenza matrimoniale, possa impunemente riprendere il lavoro senza avere contratto regolare matrimonio.
– Un caso appassionante – affermò Franzosi, mentre inforcava un paio d’occhiali sormontati da bachelite nera.
– Visto che non c’è di meglio, – proseguì Balestri – versiamoci questo champagne d’austerità – terminò riempiendosi il bicchiere. Ingollò metà del contenuto poi fece una smorfia. – Ma è anche caldo! – e depose il bicchiere.
Baneri si accese un sigaro, aspirando a fondo per due volte e tentò di fare dei cerchi col fumo senza riuscirci. Franzosi tamburellava sul tavolo con la matita. Aveva uno sguardo assente e seccato.
Finalmente entrò Magda per annunciare che il capo del personale, dottor Impronta, era entrato nel cortile con l’auto.
– Ah ecco una bella notizia. Signorina Magda brindo alle sue gambe che sono la cosa più bella qui dentro – esclamò Balestri alzando il bicchiere al soffitto. La ragazza si schermì per uscire immediatamente dalla stanza.
– Bella figliola, eh? – disse al suo dirimpettaio – ma mi sa che è tabù. Lei che in queste cose è più approfondito di me, che ne dice?
Tarchini allargò le braccia e sorrise in modo allusivo.
Impronta entrò trafelato aggiustandosi la cravatta.
– Scusate il ritardo ma ho dovuto appianare una faccenda scabrosa. Ah, il dottor Forti non c’è?
– Lo sa, esimio, che il gran capo presenzia solo a quadri completi, o con assenti altamente giustificati, vale a dire febbre almeno a quaranta o missione di lavoro – disse ridendo Balestri imitato ma con più contegno da Tarchini. Gli altri posarono solo uno sguardo distratto sull’ultimo arrivato.
L’uscio venne spalancato di colpo e Magda annunciò con voce modulata ma stentorea: – Il dottor Forti!
L’amministratore generale entrò nello stanzone a passo di marcia, viso truce e in pochi secondi aveva posato gli occhi su tutti e puntava dritto alla sua poltrona, più ampia e capiente delle altre, che era a capo del tavolone.
I cinque che si erano alzati di scatto all’annuncio dell’arrivo del maggior titolato, si erano messi a sedere su invito di quest’ultimo.
Un cenno del dito e la segretaria mise in moto il registratore. Il dottor Forti si schiarì la gola e iniziò con la solita dichiarazione di prammatica che era sempre uguale, fatta eccezione per la data e l’ora.
– …e detto questo devo purtroppo iniziare con una nota di biasimo per il signor Impronta, capo del personale, giunto con ben sei minuti di ritardo.
L’imputato, che si aspettava il rimprovero, si allentò il nodo della cravatta, e con viso dolente espose le sue ragioni.
– Sono veramente mortificato dottore, ma creda mi è stato impossibile tornare prima. Ho dovuto affrontare quella questione dell’operaia e…
– Sono perfettamente al corrente – tagliò corto con voce gelida il presidente della riunione – spero almeno si sia risolta nel migliore dei modi.
– Certamente, dottore – rispose l’interrogato asciugandosi il sudore che gli bagnava la fronte. – Le farò poi avere un dettagliato rapporto.
– Molto bene, la parola al dottor Balestri.
Il responsabile della contabilità generale si mise a leggere cifre, dati, analisi fiscali, che attirarono solo l’attenzione dell’amministratore generale, mentre gli occhi degli altri, sia pur posti sullo speaker, denunciavano una certa sonnolenza.
– …e con questo ho finito, a meno che lei non voglia avere qualche dettaglio più particolareggiato.
– No, non per ora almeno – rispose soddisfatto il dottor Forti che fece partire l’indice in direzione del direttore amministrativo.
– La parola a lei, dottor Franzosi.
La voce di quest’ultimo si levò lenta e cadenzata nella stanza. Teneva la bocca quasi appiccicata al microfono. Parlava senza consultare appunti, come se avesse tutto bene impresso nella memoria. Continuò a fare il quadro della situazione per circa mezz’ora, mentre il direttore della riunione lo seguiva con interesse, mento appoggiato alla palma della mano.
– …e per il resto mi associo alle conclusioni tratte dal dottor Balestri, con quale concordo su tutto, meno sui punti che ho appena sviscerato. Per un approfondito studio analitico di questi problemi proporrei una riunione ristretta coi responsabili contabili.
Il dottor Forti assentì. – Sì, d’accordo. Fisseremo poi la data, ma mi sembra che non ci sia premura particolare. La sostanza del problema è ben delineata, quindi occorre solamente mettere a fuoco i contorni e questo è lavoro di routine. Molto bene, la parola al responsabile della produzione, che è invitato a spegnare quel sigaro puzzolente.
Baneri arrossì ed eseguì l’ordine un po’ seccato.
– Chiedo scusa, vedrò di cambiare marca. Ho qui una serie di note che confermano il quadro delle previsioni fatte nella riunione di tre settimane fa. Allora avevo fatto alcune riserve, ora che ho avuto maggior tempo per bilanciare gli elementi, annuncio ufficialmente che quelle riserve sono cadute e che pertanto può essere considerato valido a tutti i suoi effetti. – si guardò intorno con aria soddisfatta, nessuno dei presenti parve essere particolarmente emozionato dalla sua dichiarazione.
– Rilegga pure le note di produzione – lo invitò l’amministratore.
– Se lo ritiene opportuno – un’occhiata del dottor Forti confermò a Baneri l’opportunità della lettura.
Attaccò con una voce cantilenosa e strascicante a leggere per venti minuti buoni. Alla fine ci fu un attimo di silenzio.
– La bobina sta per terminare dottore – disse Magda che era addetta alla registrazione.
– La cambi.
– Ne ho una piccola soltanto. Se non c’è molto da dire. Manca solo il signor Tarchini, più il commento conclusivo.
– Stia più attenta Magda. Sa che voglio sempre che ci siano parecchie bobine di riserva. Non se lo faccia più ripetere – disse seccato. – Avanti, inserisca quella piccola.
Ci furono alcuni minuti di pausa, mentre la ragazza, col volto completamente purpureo compiva l’operazione con le mani tremanti. Alcuni ne approfittarono per bersi un goccio d’acqua e per accendersi una sigaretta.
– A posto? – domandò sgarbatamente il dottor Forti. Magda annuì sempre con le gote arrossate.
– Avanti allora, tocca a te Massimiliano. La parola al signor Tarchini.
L’ultimo in ordine di relazione prese la parola con un sorriso ironico. Inforcò gli occhiali e si mise a leggere a voce bassa una relazione sulle nuove possibilità di mercato derivanti dalla situazione di crisi settoriale, con interventi e tagli nel programma precedentemente presentato.
– …passo adesso a una più chiara esposizione di quanto intendo per rinnovo della progettazione e…
– Scusa, Massimiliano – lo interruppe il dottor Forti alzando la mano, mentre con l’altra si lisciava i baffetti – il nastro è corto. Ci saranno ancora una decina di metri, necessari per la chiusura della sessione.
– Ma io ho ancora parecchie cose da dire – esclamò un po’ risentito l’interrogato.
– Alla prossima riunione. Tanto tra due giorni chiudiamo per una settimana e ne riparleremo al rientro.
Alquanto seccato, Tarchini batté i fogli sul tavolo e li ripose con cura nella cartelletta.
– Dunque, signori, nel porre termine a questa riunione desidero innanzi tutto ringraziarvi per lo spirito di collaborazione che avete dimostrato e… – continuò a parlare anche quando il nastro, sotto gli occhi sbigottiti di Magda, aveva già finito la sua corsa nella pista. Il discorso era sempre il solito, non mutava mai né di un termine né di una pausa.
– …Ora signori vi lascio perché ho un impegno. Se qualcuno vuole bere qualcosa, Magda ha la chiave del mobile bar. – E detto questo l’amministratore generale se ne uscì con lo stesso passo di marcia con cui era entrato.
Tarchini sbuffò: – Magda a me un goccio di bourbon con ghiaccio per favore.
– Anche a me – intervenne pronto Balestri, – ma senza ghiaccio per favore.
– Un po’ di vodka per me, se è ghiacciata però – chiese garbato Impronta.
– Scusatemi cari colleghi – disse Franzosi alzandosi, – io avrei da fare, poi ho il fegato in disordine.
– Me ne vado anch’io – aggiunse Baneri portandosi verso l’uscita. – Ho un paio di lettere da dettare prima che la segretaria se la fili. Appena finisce l’orario quella se la batte a tempo di record – e uscì dalla porta seguito dal collega della direzione amministrativa.
– Sbaglio o non abbiamo sentito la tua voce? – domandò ironico Balestri centellinando il suo whisky.
Impronta, il capo del personale allargò la bocca scoprendo i denti.
– Mi ha voluto punire per il ritardo. Ma che ci posso fare? Non ho il dono dell’obiquità – e trangugiò la sua vodka.
– Io non ero in ritardo – intervenne Tarchini sorridendo amaro, – comunque non è che le mie proposte gli abbiano destato eccessivo interesse, visto che non mi ha fatto finire.
– La colpa è di Magda – esclamò ridendo Balestri occhieggiando la ragazza che metteva a posto le bottiglie. – È libera stasera signorina?
– No, mi spiace ma ho tutte le serate occupate – e dopo aver fatto una smorfia col naso se ne uscì lentamente, ancheggiando.
– Un bel pezzo di figliola! – disse Balestri con un sospiro. – Beato chi se la gode.
– Già chi sa chi sarà il beato – disse ironico Tarchini.
– Bene gente, io vado a fare rapporto. Chissà che non riesca a farmi perdonare.
Il contabile principe e il responsabile della progettazione osservarono il capo del personale che si allontanava asciugandosi la fronte.
– Ha una fifa blu del capo – proruppe Balestri, – quasi quanta ne ha lei.
– Io non ho paura di lui. Mi fa semplicemente rabbia. Ma tant’è… – e s’infilò la cartellina sotto il braccio mentre si alzava. – Ci vediamo – disse al collega che gli rispose alzando il bicchiere.
È solo. Sta finendo di mettere a posto le sue scartoffie. L’impresa di pulizie non sarà qui prima di un’ora. Sono le otto. Ho il treno alle nove meno dieci. Non ho molto tempo da perdere. Batto con le nocche alla porta ed entro. Lui alza la testa.
«Posso entrare Dottor Forti?» gli chiedo ironico. Lui alza gli occhi e li riabbassa subito. Sta prendendo delle note. «Ma non dovevi partire?» mi domanda continuando a scribacchiare. «Ho il treno che parte tra tre quarti d’ora circa. Mi sono fermato perché volevo dirti quello che non mi hai consentito di esporre nella riunione di prima. Ritengo che siano cose importanti » gli rispondo. Smette di scrivere, ma lo fa solo per accendersi una sigaretta. Me ne offre una che rifiuto. «Massimiliano, lascia perdere, ho tante faccende per la testa. Ti ho già detto che non sono cose urgenti. Ne riparliamo quando torni. Fa’ un buon viaggio e divertiti» e riprende a scrivere.
«Sai che soddisfazione c’è a essere trattati così!» gli dico tra i denti. «Andiamo Massimiliano, non fare il bambino, ho da fare». Risponde senza alzare lo sguardo.
Afferro l’impermeabile che avevo deposto sulla spalliera della sedia ed estraggo la pistola. La guardo senza che lui se ne accorga, poi gliela punto addosso.
«Ettore, non è più possibile continuare così». Il mio tono di voce è tale che lo costringe a smettere di annotare. Alza le labbra e le sue pupille si concentrano sulla canna della pistola.
«Cos’è quell’affare?» chiede seccato. «Una pistola», gli rispondo ironico. «Quello lo vedo anch’io, ma cosa avresti intenzione di fare?». «Spararti» gli rispondo con un bel sorriso. Tira un lungo sospiro poi si abbandona contro la spalliera della sua comoda poltrona.
«Perché non ti ho fatto terminare la tua relazione?». Scuoto il capo. «Ettore, non hai capito niente, ma proprio niente di me». Ho il braccio teso e la mano ferma. L’indice è sul grilletto, pronto a scacciarlo se fa un qualsiasi movimento. Lo intuisce perché muove solo la bocca. «Sei esaurito Massimiliano. Prenditi una ragazza e stai via questi sette giorni. Divertiti e vedrai che ti passeranno tutte le ubbie». «Una ragazza mi aspetta alla stazione. Andrò via con lei. Ma non tornerò più. Questa è l’ultima volta che ci vediamo». Fa per muoversi, io allungo il braccio, «attento Ettore, non sto scherzando». «Non lo metto minimamente in dubbio» risponde pacato, «volevo solo prendere una sigaretta, posso?». «Certo» gli rispondo con ironia, «non si rifiuta niente a un morituro». La cosa non sembra interessarlo. S’infila tra i denti una Pall Mall, dà due colpi all’accendino con mano assolutamente ferma. Questa sua sicurezza mi urta e mi offende. Sento l’impulso di scaricargli addosso l’arma, ma mi trattengo perché prima di farlo ho diverse cose da dirgli, senza le quali tutto sarebbe inutile. «Sei a posto adesso?» gli domando deglutendo. Lui assente con la testa e butta fuori il fumo dal naso. Possibile che si senta così sicuro? Recita, sì, per me recita. Io al suo posto non saprei articolare una parola e sarei preso dalle convulsioni.
«Prima mi hai detto di non fare il bambino, vero Ettore?» inizio con voce studiatamente lenta, «ecco come mi tratti tu, da bambino! Sono sette anni che lavoro qui, e anche se ho compiuto degli inevitabili errori dovuti all’inesperienza, ho anche dato il mio fattivo apporto allo sviluppo dell’azienda». «Nessuno te lo ha mai negato» afferma con tono cordiale. «Non mi interrompere e rispondi solo se ti interrogo» gli dico con rabbia. Mi pare di vedere un lieve pallore dipingersi sul suo volto, ma forse è solo suggestione. «Qui dentro io comunque faccio la parte del parente povero. Il fatto che io sia tuo cugino mi ha sempre impedito di brillare di luce propria, dovunque vada, io non sono il signor Massimiliano Tarchini, ma il cugino del dottor Forti. Tra i tuoi innumerevoli amici dubito che ci sia uno che sappia come mi chiamo veramente, ma non è colpa tua, certo, questo non te lo imputo, ma di avermi continuamente umiliato sì, di avermi fatto la carità della tua compagnia al contagocce, di avermi sempre escluso dai veri problemi aziendali, anche da quelle burlette di riunioni che ti piace fare per sentirti potente. Mi fai sempre parlare per ultimo, e mentre, quando parlano gli altri, presti sempre attenzione, quando parlo io il tuo sguardo girovaga per la stanza e la tua mente è chissà dove! Se posso definirmi un braccio in questo corpo che è l’azienda, l’ho legato con delle catene, di platino se ti fa piacere, ma pur sempre catene. Ogni qual volta ho avuto delle idee un po’ originali, me le hai subito bocciate, per riprenderle magari mesi dopo spacciandole come parto del tuo cervello. Questa tua continua prevaricazione, questo reiterato tentativo di annullarmi mi ha sconvolto. Ha creato dentro di me un vuoto incolmabile, vuoto che posso solo riempire con la tua morte, per mano mia». «E poi cosa fai?» mi domanda ironico. «Credi di riuscire a farla franca? Guarda che la polizia è meno tonta di quanto si creda comunemente». «Me ne frego del dopo» urlo esasperato, «non c’è più domani per me, tu ma non solo tu comunque, non sentirti così importante, me l’hai distrutto, ora quello che mi preme è finire la mia composizione». «Composizione?» domanda con l’espressione di chi crede di aver capito male. «Sì proprio così, composizione. Una fantastica pièce, che nessuno ha mai scritto, una pièce di nove battute. Tu sei l’ottava. Ne manca solo una. Poi ho finito la mia opera unica. Una composizione di cesello, fatta da un artista che nessuno conoscerà mai, perché morirà con me!». Mi guarda assorto, come si osserva un pazzo. «Credi che sia pazzo, eh? Può darsi, ma ho la lucidità che si dice dia la pazzia. Ma io non mi ritengo tale. La mia è esasperazione. Ho sempre teso la mano e mi ci hanno sputato dentro, tu come gli altri e anche tu farai la fine degli altri». Piega la testa per osservare l’orologio da polso. «Se pensi che possano arrivare quelli delle pulizie non ci sperare! Mancano più di quaranta minuti, sono puntuali ma mai in anticipo!». «No» mi risponde calmo, «pensavo solo che se non esco tra un paio di minuti, arriverò tardi a cena». La pistola forse non è l’arma adatta a sopprimerlo. Avrei dovuto portare un’accetta e tagliarlo a pezzi. Quella superiorità che dimostra anche davanti al pericolo della vita mi distrugge. «Ettore, forse non hai capito bene» gli dico con un groppo alla gola, «ma tu da qui vivo non ci esci. Ho la ferma intenzione di ucciderti!». «Immagino che ci avrai pensato bene, ma guarda che tra il desiderare di ammazzare e il farlo c’è una bella differenza!» mi dice in tono paterno. «Lo so» gli rispondo i indispettito, «ma guarda che ho già ammazzato sette persone in quaranta giorni e ormai non solo ci ho fatto il callo, ma uccidere mi dà una gioia che non avevo mai provato prima». Scuote il capo e atteggia gli occhi a espressione incredula. «Non ci credi, eh? Bene, leggi i giornali vero? Ti ricordi di quell’omosessuale trovato con la gola tagliata, e di quel tale pugnalato con le forbici? No, e nemmeno di quella vecchia affogata nel bagno assieme al suo cane? Sì, di quella ti ricordi? Bene, questa pistola è la sua. L’ho tenuta appositamente per te». Stavolta impallidisce sul serio. Ma si riprende subito. «I giornali li leggi anche tu. Potresti esserti inventato tutto con l’illusione di spaventarmi» dice con una voce un po’ tremante. «Sì, effettivamente potrebbe essere ma non lo è, e quando te ne convincerai sarà veramente troppo tardi». Le mani adesso gli tremano. Forse non è del tutto convinto, ma sono almeno riuscito a infilargli nel cervello il tarlo del dubbio, e incomincia ad avere paura. È l’attimo più bello, quello che ho atteso. Prima di ucciderlo volevo che perdesse quella sua odiosa aria di superiorità e finalmente ora le parti si sono invertite. Sono tronfio, mi godo il mio agognato trionfo, un’emozione mai provata. «Prenditi un bel pezzo di ragazza e chiuditi in una stanza per una settimana e togliti tutti i complessi, una che ci sappia fare» dice con un tono di voce che non gli ho mai sentito. Provo per lui dell’ammirazione. Si sta rendendo conto che posso anche fare sul serio e tenta di mantenere l’autocontrollo, ma la voce lo tradisce.
«Non sai consigliare altra terapia che d’andare a puttane!» gli rido addosso. «Una medicina semplicistica, ma parlare con te di problemi interiori è come discutere della consistenza del vento. Non li capisci perché non ne hai. Ecco, ti dico una cosa: vorrei essere così superficiale come te, non portarmi dentro arrovellamenti, ma sempre una sfacciata e insensibile patina di menefreghismo. Purtroppo non ci riesco, i miei nervi si sono corrotti da un logorio incessante. Ormai è tardi per tutto». «Senti» mi parla con una voce accorata adesso, «posso avere sbagliato nei tuoi confronti, ma nessuno è perfetto. Ora tu sei eccitato, ma se ne riparlassimo in un altro momento, con più calma? Vedrai che potremo trovare delle soluzioni meno drastiche che possano compensarti dei torti che, involontariamente, e ci tengo che tu lo sappia, quindi ribadisco involontariamente, posso averti arrecato. Se è questione di soldi… ». «Non è questione di denaro» gli rispondo aspro. «Va bene» riprende sempre in tono accorato «lo immaginavo, ma non volevo lasciare nessuna possibilità scoperta. Vedi, ti sto dimostrando la mia buona volontà. Guarda che mancano venti minuti alle nove, se non ti sbrighi perdi il treno, ma se vuoi rimandare la partenza, possiamo andare a cena assieme, io e te. Telefono per avvisare che ho un impegno importante che non posso rimandare e andiamo. D’accordo?». Lo guardo fisso negli occhi. Lui fa altrettanto cercando di indovinare cosa può balenarmi nella mente. Abbozza un sorriso che gli riesce male. Io non cambio espressione. Continuo a fissarlo. Se mi avesse parlato così qualche mese fa…, ma per riuscirci ho dovuto puntargli addosso una pistola. Forse ho mancato anch’io. Non ho mai avuto il coraggio di affrontare un discorso chiaro, per farlo ho dovuto drogarmi con un’arma. Legge la mia indecisione negli occhi. Apre l’agenda, scorre il dito su una serie di nomi, si ferma su uno, ripete mentalmente il numero muovendo le labbra e afferra la cornetta del telefono. Sparo tre colpi, uno dietro l’altro che producono un rimbombo fastidioso. Col primo gli ho centrato la fronte facendogli un buco grosso come una noce. La testa gli è caduta all’indietro e gli altri due si sono conficcati nella poltrona. Il sangue è schizzato fuori assieme a una materia biancastra ed è andato a imbrattare la parete, di poco sotto il quadro di Chagal. Getto la pistola in terra e afferro l’impermeabile che infilo al braccio.
Tendo le orecchie per sentire se per caso qualcuno sta arrivando. Non può aver sentito nessuno nel palazzo, che è adibito a uffici, e che forse è anche deserto. Esco facendomi scattare la serratura alle spalle e mi avvio a passo deciso verso la mia macchina. Guardo l’orologio. Le nove meno diciotto.
Forse faccio in tempo a prendere il treno.
Sospeso per riflessione
Massimiliano Tarchini salì sulla sua auto parcheggiata un isolato più avanti da quello dell’edificio e rimase immobile per alcuni minuti. Un suono di clacson lo destò dalla meditazione. Si infilò automaticamente la mano sotto la nuca per ritrarre le dita bagnate di sudore. Si accorse di tremare quando gli risultò difficile infilare la chiave di avviamento nella sua scannellatura. Il motore non partiva. Tirò l’aria e alfine si accese. Tenne il piede sull’acceleratore sino a raggiungere i mille giri e ne approfittò per riordinare le idee.
Si sentiva svuotato. Passata l’eccitazione del momento sentì la testa girare e chiuse gli occhi. Mancavano quindici minuti alle nove. Cinque minuti di tempo per arrivare alla stazione. Ce l’avrebbe fatta? Forse, dato anche che i treni non partono mai in orario. O quasi mai. Quelli delle pulizie sarebbero arrivati alle nove e in pochi minuti avrebbero trovato il cadavere di Ettore e dato l’allarme. Sì, il tempo bastava, sempre che il diavolo non ci mettesse la coda.
Riaprì gli occhi, chiuse lo starter e alzando molto di giri il motore partì facendo attrito con le gomme sul selciato. La strada era libera e il traffico minimo. Davanti alla stazione vide un buco di parcheggio libero. Si infilò e discese dall’auto portandosi dietro l’impermeabile. Nove meno dieci esatte. Si mise a correre incurante delle urla del custode del parcheggio che per un po’ lo inseguì per poi fermarsi imprecandogli dietro.
Facendo i gradini a tre a tre raggiunse il transatlantico dove aveva appuntamento con Sonia. Era là. Roteava attorno le pupille in cerca del suo uomo. Lo vide, sorrise e guardò subito l’orologio.
– Finalmente, pensavo fosse successo qualcosa – disse preoccupata.
– È successo qualcosa! Ma ce la dovremmo fare. Che binario è?
– Otto.
Le prese la valigia e si indirizzò verso il binario di partenza con dietro la ragazza che lo seguiva a saltelli. Salirono sull’ultimo vagone che era di prima classe e non fecero fatica a trovare posto. Era semivuoto.
– Mettiamoci qui che siamo soli – disse appoggiando la valigia.
– Ma cos’è successo? Ti vedo turbato.
Massimiliano si lasciò andare pesantemente sul divanetto.
– Ti racconterò tutto, ma non ora. Mi devi scusare, sono esausto. Vorrei riposare. Appena il treno parte voglio dormire per almeno mezz’ora.
– Puoi dormire anche di più. Abbiamo circa tre ore e mezzo prima di arrivare a Venezia e…
– No! – l’interruppe deciso l’uomo. – C’è un lieve cambiamento di programma. Scendiamo a Brescia, poi prendiamo una macchina a nolo e arriviamo a Venezia in auto.
– E perché? – domandò stupita la ragazza.
– Ti prego Sonia, è troppo lungo da spiegare. Sono stanco. Svegliami tra mezz’ora, dovrebbe essere poco prima della fermata.
La ragazza lo guardò sempre più sorpresa, mentre Massimiliano guardava l’orologio della pensilina. Con dodici minuti di ritardo il treno si mise alfine in moto e il viaggiatore sentì una morsa che si allentava intorno al cuore. Poggiò la nuca sullo schienale imbottito e chiuse le palpebre. Ce l’aveva fatta. A quell’ora la polizia aveva senz’altro trovato il cadavere di Ettore e la macchina si era messa in moto, ma anche il suo treno. La discesa a Brescia era una precauzione per essere certo che nessuno di sua conoscenza l’avesse visto prendere il treno per Venezia, e se così fosse stato non lo avrebbero trovato facilmente. Ma erano tutte precauzioni eccessive in quanto prima di risalire a lui avrebbero impiegato del tempo. La pistola era della vecchia signora, avrebbero collegato almeno i due delitti, ma era incensurato e le sue impronte non figuravano da nessuna parte, ma così il gioco era più professionale e divertente. Ammesso che lo fosse ancora. Il cadenzare monotono delle ruote metalliche sulla rotaia gli parve un invito irrimandabile e si lasciò catturare da un sonno profondo.
– Svegliati Max, sveglia, tra due minuti siamo a Brescia – la ragazza lo scosse più volte e con decisione prima che si risvegliasse.
– Accidenti, sono caduto come un sasso. I nervi non mi reggevano più. Prendi la valigia – disse stiracchiandosi.
– Ma la tua dov’è? Non l’avevi quando siamo saliti.
Massimiliano alzò gli occhi al soffitto e si ricordò di averla dimenticata nel portabagagli dell’automobile.
– Oh già, la valigia. L’ho lasciata nella macchina. Beh poco male, compreremo a Venezia quello che mi serve. Rinnoverò il guardaroba.
Si portarono verso la porta d’uscita mentre la ragazza lo osservava con espressione assorta.
Non fu facile trovare un autonoleggio aperto, ma alla fine, con una buona mancia, riuscirono ad affittare una cinquecento.
– Prendiamola a tuo nome – disse Tarchini alla ragazza mentre l’impiegato chiedeva una patente.
– Come vuoi – rispose Sonia frugandosi nella borsetta.
Fatto il pieno si misero sulla provinciale.
– Tra due chilometri c’è da girare per prendere l’autostrada – gli annunciò la compagna. Il guidatore annuì.
Una volta entrati nella strada riservata ai motori, la ragazza accese due sigarette infilandone una in bocca al suo compagno.
– Senti adesso devi spiegarmi un po’ cos’è tutto questo giochetto.
– Ma niente signorina Botti – gli rispose allegro il guidatore – tanto per cambiare un po’. Altrimenti sembra un viaggio organizzato. Un’improvvisazione, ecco.
Sonia non parve convinta di quello che le si ammanniva, ma preferì tacere. La piccola cilindrata correva a quasi cento all’ora sulla strada quasi deserta. Pochi sorpassi per rientrare subito nella corsia di destra e qualche bolide che passava veloce superando i limiti di velocità.
– Senti – chiese dopo una mezz’ora di silenzio opprimente – hai detto che è successo qualcosa. Cosa? Mi vuoi dire almeno quello?
Massimiliano scosse la testa. – Sono questioni di lavoro. Non ti voglio annoiare con queste beghe. Abbiamo una settimana tutta per noi, vediamo di godercela lasciando le rogne alle spalle. Non sei tu quella che mi criticava sempre perché penso solo al lavoro?
La ragazza lo ammise e constatato che la conversazione languiva preferì chiudere gli occhi e assopirsi.
Quando arrivarono all’Hotel Gritti, era notte fonda. L’auto era stata lasciata sulla terraferma e con un motoscafo avevano raggiunto il celebre albergo.
– Siamo due sposini in viaggio di nozze – disse sorridendo Massimiliano al portiere, – vorremmo fare uno spuntino in camera se è possibile e domani non avremmo intenzione di muoverci e ci piacerebbe essere lasciati tranquilli.
– Ma certo signore, certo – lo rassicurò il portiere rinsecchito e dalla testa pelata e lucida come la palla di un biliardo, – stia tranquillo, nessuno vi disturberà. Potrà prendere i pasti in camera. Quella che avete riservato ha un ampio salone con balcone sulla laguna.
Data la mancia al facchino, la coppia entrò nella camera trecentodiciotto.
– Vorrei farmi un bagno! – disse l’uomo con tono deciso – o vuoi farlo prima tu?
– Non lo facciamo insieme? – modulò Sonia accarezzando il suo uomo.
– No, ho voglia di fare un bagno per rilassarmi, non un bagno erotico. Ne ho bisogno come l’aria. Abbi pazienza, abbiamo tutta la notte per sfogarci.
La ragazza allargò le braccia e si distese supina sul letto, mentre sentiva lo scrosciare dell’acqua che riempiva la vasca.
«Ma cosa gli ha preso? Ultimamente è più strano del solito, ma oggi non ha paragone con niente. Questo mi vuole far pagare la storia di quella settimana famosa. È una carognetta e figurarsi se lascia perdere l’occasione. Spero soltanto che non la tiri troppo alla lunga altrimenti questi sette giorni che dovevano essere paradisiaci diventeranno d’inferno. Chissà poi perché ha detto che siamo in viaggio di nozze, quando di matrimonio non ne ha mai voluto parlare. Va beh che io ho sempre sostenuto che non voglio legarmi, ma di fatto siamo legati e lui non ha mai fatto niente per convincermi del contrario. Ma sì, tanto che importanza ha? Sposati o no, quello che conta è stare insieme qualche volta. Mi piacerebbe avere dei figli, ma ogni volta che accenno all’argomento storce il naso e parla d’altro. È fatto così, dolce come un cucciolone e odioso in modo insopportabile. Bisogna sapere gustare i momenti buoni che però ultimamente sono diventati sempre più rari. Si è incupito ed è diventato irascibile. Nervoso lo è sempre stato, ma come adesso mai. Che abbia un’altra donna? Sì, forse, un’altra donna, che sciocca a non averci pensato prima. Io ho ventotto anni e non sono più la ventiduenne che conobbe sei anni fa. Qualche ruga qua e là ha incominciato a fare capolino e non sono più fresca come una volta. Forse sarebbe meglio che lo piantassi prima che lo faccia lui, ma che cambia in definitiva? E allora tanto vale lasciare le cose come vogliono andare. Certo che mi aspettavo di più. Da un paio d’anni a questa parte andare a letto insieme per lui è diventato un sacrificio e me lo dice anche. Poi quando io mi arrabbio lui si rabbonisce, ma intanto l’ha detto.
Non l’attiro più. È piuttosto volubile ed è già durata molto. Ha le stesse reazioni di un bambino capriccioso, ma purtroppo amabile. Ed è questo che mi frega. Avevo preso la decisione di chiudere ma è bastata una sua carezza, un suo gesto garbato, che fa col contagocce, e tutta la mia sicurezza è andata a farsi benedire. Mah, sette giorni tutti per noi, quasi non ci credo. Che sia la fine in grande stile? Con quello che costa questo albergo! Ma quanto ci impiega a fare il bagno?»
Sonia si alzò e bussò lievemente alla porta senza ottenere risposta. Riprovò un’altra volta, più forte.
– Max, stai bene? – domandò angosciata.
– Entra, Sonia, entra pure, mi ero addormentato.
La ragazza osservò il viso che emergeva dall’acqua a occhi chiusi.
– Credo che ti faccia male stare dentro così tanto. Sai che è più di mezz’ora che sei a mollo?
– Adesso esco. Prendimi l’accappatoio. Grazie.
La ragazza obbedì. L’uomo uscì dalla vasca per stringersi addosso il panno lasciato a scaldarsi sul calorifero.
– Non hai del borotalco? Il mio era nella borsa dentro la valigia che ho dimenticato.
Sonia lo coprì di povere bianca passandogliela con un tocco lieve della mano. Massimiliano si guardò nello specchio.
– Accidenti come sono brutto. Faccio impressione! – esclamò convinto.
– Brutto lo sei sempre stato – gli fece eco ridendo la sua compagna e si abbracciarono.
– Fai il bagno anche tu? – le domandò dopo averla baciata dentro l’orecchio.
– Una sciacquatina, ma farò più alla svelta di te.
Socchiusa la finestra, l’uomo si tolse l’indumento per mettersi sotto le coperte. Portò le mani dietro la nuca e si mise a fissare il lampadario a gocce che troneggiava.
«Domani, dopo aver preso la prima colazione di domani. Questa sera gliela devo dedicare senza riserve. È un dovere e una consuetudine. Ai morituri non si deve mai negare nulla e fare di tutto per accontentarli. Poi, poi le dirò tutto e compirò la pièce. Com’è volato il tempo in queste ultime settimane. Quasi non me ne sono accorto. Ho portato a quasi totale compimento la mia opera e stento a crederci. A volte mi sembra di muovermi in un sogno, dove la scenografia e suoni sono completamente assenti. È la prima cosa veramente importante della mia vita e ne sono soddisfatto. Ma dico sul serio o sto barando? Non saprei neanch’io. Se ci ripenso mi sembra persino incredibile di essere riuscito a compiere tutti quei delitti che mi ero prefisso, eppure non è stato affatto difficile. Mi spiace solo di non essere arrivato in tempo con quel cane di Sforzi. La vecchia falciatrice di vite mi ha battuto in volata e quasi mi stava scappando anche il vecchio Lanzi, e ci sono arrivato sul filo di lana. Meno male che aveva ripreso conoscenza. Non ci sarebbe stato gusto ad ammazzarlo senza sapere chi lo faceva e il perché. È stata una grossa rivincita, una vendetta fredda e gustosa. Quasi mi spiace di essere arrivato al termine della corsa. Di ricominciare tutto da capo non me la sento. Ormai ho anch’io il tempo contato. Due giorni dopo al massimo, poi con l’omicidio di Ettore la polizia vorrà pure interrogarmi. Devo essere ben lontano per quel momento. E lo sarò di certo. Ah, Sonia sta facendo scorrere l’acqua. Deve aver finito».
La ragazza si fermò davanti alla porta. Si era tirata indietro i capelli e il suo corpo odorava di un profumo ricercato. Era nuda e ancora affascinante. Massimiliano le strizzò l’occhio e batté la palma della mano sul posto vuoto nel letto matrimoniale.
– Sposina, ti sto aspettando con ansia. Bella quella camicia da notte. Molto fine e di prezzo modico.
La ragazza si infilò sotto le coperte e con la punta del dito spense la luce.
– Sai Max, sono tremendamente felice di essere qui con te – fece una pausa attendendo un qualcosa di analogo che non venne.
– Max, mi ami ancora? – domandò con una vocina flebile.
– Ci perdiamo ancora in queste frescacce piccolo-borghesi? – le rispose il suo uomo mentre le accarezzava il seno. – Godiamoci questa notte come se fosse l’ultima.
La ragazza lo serrò forte tra le sue braccia con un brivido di paura.
Rilettura della composizione ancora incompiuta
Il cameriere posò il vassoio della colazione sul tavolino e dopo aver intascato mille lire, si eclissò con un inchino. Massimiliano guardò se c’era tutto quanto aveva ordinato. Caffè, latte, brioches, tosti, burro, tre tipi di marmellata, miele, e una copia del Gazzettino. Cercò nella pagina della cronaca nera, ma di Ettore nessuna notizia. Forse ci sarebbe stato qualcosa sui giornali di Milano. Andò in camera a chiamare la sua compagna che aveva già messo i piedi giù dal letto.
– Ma che ora è? – domandò assonnata.
– Le dieci e un quarto. Ho ordinato la colazione, un menu speciale che ci verrà servito alle due, tutto con champagne naturalmente.
La ragazza annuì infilando i piedi nelle pantofole rosa con un pompon rosso.
– Ne aveva un paio così anche Mariuccia – notò Massimiliano.
– E chi è questa Mariuccia? – domandò Sonia con fare sorpreso.
– Oh, una tizia di cui ti dirò poi. Ora vieni a prenderti il caffè prima che diventi freddo.
La ragazza eseguì senza fare altre domande. Si riempì la chicchera e trangugiò il caffè amaro. Se ne versò una seconda aggiungendo un po’ di latte. Addentò un tosto che Massimiliano le aveva imburrato e spalmato con marmellata di arance.
– Sai che è la prima volta che prepari tu un tosto? L’ho sempre fatto io le volte passate – notò piacevolmente stupita, – sei in vena di attenzioni. Quasi non ti riconosco più.
– Non ci si conoscerà mai Sonia. Mai, una vita non è sufficiente per conoscere nemmeno se stessi, figurarsi gli altri, – rispose con tono quasi divertito continuando a imburrare.
La colazione fu terminata senza altri commenti. Massimiliano suonò per fare ritirare il vassoio pregando di non venire assolutamente disturbati. Il cameriere annuì con un sorriso comprensivo e appose alla porta il cartello “non disturbare”.
Sonia infilatasi una vestaglia azzurra che lasciava scoperti i seni si era raggomitolata su una poltrona. Massimiliano la rimirò pensoso per qualche minuto, poi le porse una sigaretta.
– Ne vuoi una?
– Accendimela tu, cucciolotto.
L’uomo eseguì prontamente e gliela cedette accesa tra le dita.
– Immagino che vorrai parlarmi. Hai l’atteggiamento di uno che vuole fare un discorso importante. Cos’è, mi vuoi annunciare che questa vacanza rappresenta la chiusura del nostro rapporto? In parole povere, mi scarichi?
Il suo compagno si morse il labbro, camminò avanti e indietro fumando nervosamente, poi si accovacciò sul letto, che era di fronte alla poltrona.
– Cosa diresti se ti dicessi che ho ucciso otto persone? – domandò a bruciapelo.
– Che sei matto!
– E basta?
– Oh, dai cucciolo, ti prego non girare attorno al punto. Se mi devi dare una stoccata dammela subito, senza farmi agonizzare.
Massimiliano spense la sigaretta nel portacenere spezzandola in due.
– Già, capisco, forse fai fatica a seguirmi ed è anche comprensibile. Bisognerà che inizi da capo, con l’antefatto introduttivo, poi man mano le varie sequenze. Vedrò di riassumere con precisione. Prestami molta attenzione ti prego, è molto importante.
– Sono tutt’orecchi – confermò Sonia increspando la fronte.
– Bene, allora ecco qui. Tutti noi nello svolgere della nostra vita abbiamo incontrato delle persone decisamente nefaste, esseri odiosi che ci hanno fatto del male. Nessuno ne è esente credo, né è limitato in modo inversamente proporzionale alla sua potenza. Per me ci sono stati otto individui che per una ragione o per l’altra mi hanno particolarmente amareggiato l’esistenza. Otto persone, anzi nove, l’ultima si è aggiunta da poco.
Massimiliano tacque un attimo per constatare se la ragazza lo seguiva.
Constatato che la giovane era assolutamente attenta, proseguì.
– Il ricordo di queste persone me lo sono trascinato avanti per anni. Mi ha sempre seguito come un peso che mi opprimeva e un bel giorno ho deciso di togliermelo per sempre. A spingermi nella mia decisione sei stata tu!
– Io? – domandò perplessa la ragazza.
– Sì, tu Sonia, ma non interrompermi per favore. Involontariamente certo, e fu quella famosa settimana, quel lunedì, seguito dal mercoledì e giovedì. L’opera completa che mi fece prendere la decisione irrevocabile. Ma di quei giorni ne parleremo dopo, vorrei continuare la mia esposizione in ordine cronologico. Ho sempre seguito l’esistenza di quelle persone e sai come? Con la guida del telefono. Ogni qualvolta venivano cambiate andavo a controllare se tutti abitavano sempre nello stesso posto o se avevano cambiato indirizzo. Due soli mi sfuggirono, ma uno era diventato famoso e non fu difficile sapere dove reperirlo, più arduo fu invece per una ragazza che aveva rinunciato all’apparecchio. Credetti di averla persa, e mi ci rassegnai anche, ma per un puro caso, e guarda che il caso gioca un ruolo importante nella vita di ognuno di noi, dicevo per puro caso la scovai. Presi nota del suo nuovo indirizzo, della sua abitazione, ma poi misi tutto in un cassetto e per un paio d’anni tutto rimase lì, quasi nell’oblio.
«La vendetta cui aspiravo era semplicemente saperli morti. Mi sarebbe stato sufficiente, ma godevano tutti, o quasi, di ottima salute. Non avrei mai creduto che quella ricerca quasi automatica che facevo ogni anno covasse dentro di me un disperato bisogno di vendetta.
«Così quel famoso giovedì sera, quando te ne sei andata sbattendo la porta, lasciandomi solo a brindare a me stesso, presi la decisione.
– Ma quale decisione? – domandò Sonia che aveva allungato le gambe e acceso un’altra sigaretta.
– Te lo sto dicendo, se non m’interrompi – rispose sgarbato Massimiliano. – Ho preso la decisione di ucciderli. Uno per uno – lo disse con voce bassa, scandendo ogni sillaba.
– Non ci credo, mi stai prendendo in giro – affermò Sonia più sbalordita che convinta di quello che diceva.
– Non mi sto affatto burlando di te. Se mi dici così è perché vuoi respingere la responsabilità di aver dato il la alla mia composizione, bene, ti voglio subito tranquillizzare.. se non fossi stata tu, sarebbe stato qualcun altro! È evidente che il germe della vendetta si era sviluppato in modo tale che doveva assolutamente prorompere, e la tua défaillance è stata la celeberrima goccia che ha fatto traboccare il vaso.
– Hai detto composizione oppure ho sentito male? – chiese la ragazza con una smorfia.
– No, hai sentito benissimo. Sì, perché questa mia opera di vendetta dovevo intitolarla in qualche modo e ho pensato a una pièce in nove battute, e ogni battuta rappresentava un omicidio. Una pièce che non sarebbe mai stata suonata e che non verrà mai portata a pubblica conoscenza.
– Ma se i tipi di cui volevi vendicarti erano otto, perché l’hai intitolata a nove? – domandò Sonia preoccupata – e la nona sarei forse io? – e rise in maniera nervosa.
Massimiliano rimase muto e la ragazza si allarmò.
– “Nove battute per una pièce” è il titolo che ho dato a questa opera, quindi ho stilato un ordine preferenziale che è stato più casuale che studiato. Avessi considerato meglio alcuni dettagli non avrei corso il rischio di trovarne uno già morto per malattia.
– Ma stai dicendo sul serio? – urlò inorridita la ragazza alzandosi.
– Finalmente l’hai capito, ma t’invito a risederti, e a non alzare assolutamente la voce. Non vorrai che ti leghi e ti imbavagli, spero.
Sonia lo fissò terrorizzata negli occhi e sentì piegarsi le gambe. Cadde rimbalzando sulla poltrona.
– Stai buona e non interferire più. Ascolta e taci! – la minacciò brandendo il pugno chiuso. – Il primo che avevo messo in lista era un attore fallito. Lo conobbi una quindicina di anni fa. Mangiavamo nella stessa latteria. Minestra e formaggio. Qualche volta una sottile bistecchina. Erano tempi duri quelli. Si chiamava Marco Vinci. Recitava con una compagnia di sbandati che voleva fare del teatro d’avanguardia, quello che adesso è popolare. Diventammo amici, incominciammo a frequentarci, andavamo al cinema assieme, e anche a donne. Almeno andavamo a tampinarle perché allora non è come adesso. La purezza e tutte quelle storie, non c’era ancora stata la liberazione sessuale, almeno a mezzo stampa. Degli amici dicevano che era un finocchio, ovvero un omosessuale, e lui lo ammise. Affermava che gli piacevano sia le donne che gli uomini, che non poteva farci niente. Chiarito che io invece ero di gusti tradizionali tutto filò via liscio per un po’, sino a quando non incontrammo Barbara. Era un’impiegata che veniva anche lei in latteria a mangiare. Io m’innamorai subito di lei, come fanno i ragazzini, di un amore assoluto, puro e impetuoso. Uscii un paio di volte con lei, senza nemmeno avere il coraggio di stringerle la mano. Poi ci provò Marco e se la portò subito a letto. Il giorno seguente mi raccontò tutto nei minimi particolari, parlando di lei come di una prostituta. Lo ingiuriai, sapeva che le morivo dietro, glielo avevo detto. Quella sera, quando lui uscì con lei, avrebbe dovuto parlarle di me, dirle del mio amore, fare in modo che anche lei si comportasse in maniera tale da aiutarmi a vincere la mia timidezza e invece andò come ti ho detto. Giurai di vendicarmi e cambiai latteria per non vederlo più. Un anno fa circa, mi capitò sott’occhio un fotoromanzo. L’ho riconosciuto subito. Così quando decisi di comporre la mia particolare pièce, incominciai a cercarlo. Aveva completamente abbandonato le donne per dedicarsi solo agli uomini. Mi misi a fare il palo davanti alla sua abitazione. Scoprii che abitava da solo. Si portava sempre a casa dei tipi disgustosi, a volte giovani, ma a volte anche vecchi, dei tipi laidi da fare ribrezzo. Non ero ancora convinto malgrado avessi preso la decisione di iniziare la mia opera vendicativa, quando una sera lo vidi uscire da una macchinetta ed entrare da solo. Non mi feci scappare l’occasione. Feci finta di essere uno della banda e quello ci cascò come una pera. Avevo con me un coltello a serramanico, ma quando fui nel suo appartamento, decisi di servirmi del collo di una bottiglia che avevo lasciato cadere apposta. Glielo conficcai nella gola, e ti giuro che quello è stato l’istante più bello della mia vita. La vista del sangue mi inebriò, mi parve per un istante di solcare il cielo dentro una biga trainata da cavalli alati. È una sensazione impensabile, altro che l’amore fisico!
Sonia lo occhieggiava con espressione incredula. – E scusa un po’, come mai ti ha fatto entrare? Tu hai riconosciuto subito una sua fotografia e lui non ha riconosciuto te?
– A quel tempo avevo dei capelli folti, portavo i baffi ed ero un po’ obeso. D’altronde anche tu hai detto che dalle fotografie di dieci anni fa non avresti mai detto che quello ero io.
La ragazza annuì cupamente.
– Il secondo fu Luigi. Era un venditore, molto abile, dalla parlantina frenetica, ostentava una sicurezza e una competenza fuori dal comune. Io ero il suo secondo. Il suo facchino aiutante, un galoppino insomma. Portavo la sua borsa che doveva contenere catalogo, listino prezzi, e altri ammennicoli. Mi appassionava quel lavoro e, anche se ero timido, pensavo o almeno speravo di fare qualcosa. Parlai nella ditta in cui lavoravo e riuscii dopo un po’ ad avere una zona tutta mia. Non me la cavavo male, anche se non c’era da fare paragoni con l’abilità di Luigi. Questi se ne ebbe a male. Interpretò il mio desiderio di indipendenza come un tradimento e me la fece pagare. Era un astioso ed egoista e lo dimostrò facendomi quella vigliaccata. Io mangiavo le briciole del suo pasto, che fastidio gli davo? Non poteva nemmeno pensare che gli potessi fare concorrenza, tanta era la capacità che lui aveva e che io non avevo. Mancarono degli incassi dell’ultimo periodo in cui lavorai con lui. Fu Luigi a rubarli, ma la colpa venne data a me. Ma fin qui avrei anche potuto chiarire la questione, ma mi giocò bene. M’implorò di accollarmi la colpa, che tanto ero giovane, mentre lui sarebbe stato rovinato. Aveva preso quei soldi per aiutare una parente malata, disse, ma li avrebbe restituiti e m’avrebbe trovato un posto migliore, promettendo anche una regalia a cose finite. Venni licenziato e quando andai da lui a chiedergli di mantenere la promessa mi diffidò dal disturbarlo minacciandomi di ricorrere ai carabinieri. Quando andai da lui per saldargli il conto, mi divertii un poco con lui. Giocai con la sua vanità, poi quando decisi che lo scherzo doveva finire gli piantai una forbice nella schiena. Morì poco dopo. Del delitto venne accusata l’amante, ma lo sai anche tu che hai seguito la faccenda sui giornali.
– E hai lasciato arrestare un’innocente? – chiese Sonia sbigottita.
– Innocente di che cosa? Non esistono innocenti al mondo, siamo tutti rei di qualcosa. Anche se non ha commesso quel delitto paga una colpa di quelle che le sono andate lisce.
– Ma è mostruoso! – mormorò la ragazza rattrappendosi sempre più nella poltrona.
Massimiliano si portò l’indice sulle labbra e puntò gli occhi che erano molto espressivi sulla ragazza.
– La terza fu Mariuccia, quella che avevo perso, e che trovai sai come? Una sera fermo a un semaforo, la vidi su una macchina di piccola cilindrata. La seguii tenendomi però a debita distanza. Rimorchiava un altro automobilista e scoprii il suo indirizzo. Si era messa a fare la puttana. Beh, quella tizia è stato un altro dei miei amori non corrisposti. Con questa andavo già meglio, ci baciavamo e si lasciava toccare, ma non voleva assolutamente concludere prima del matrimonio. Capirai cosa ho provato scoprendo che faceva del meretricio. L’ho legata al letto e l’ho strozzata col nylon del suo collant. Ma non provai gioia, solo del disappunto. Doveva aver significato veramente qualcosa per me e in quel momento me ne resi conto. Il quarto doveva essere il commendator Sforzi, dico doveva perché quando stavo per iniziare a studiare i suoi movimenti, lessi sul giornale che era morto. Sputai sulla sua tomba e pagai degli zingari perché andassero a ballarci sopra. Hai letto anche questo sui giornali, no?
– E cosa ti aveva fatto? – domandò Sonia con un filo di voce.
– Lui? Era un mio lontano parente. Avevo deciso di mettermi per conto mio. Volevo aprire un negozio di oreficeria. Conoscevo uno che se ne intendeva abbastanza ma mi mancavano i capitali. Glieli andai a chiedere “centomila lire, con cambiale a quattro mesi” mi disse. Era una miseria, ma meglio che niente li presi. Alla scadenza, non potevo far fronte e lo pregai di darmi del respiro. Lo scongiurai anche ma quello, duro, mandò la cambiale in protesto. Ed era ricco da far paura.
Massimiliano tacque. Rimase un momento perplesso, poi andò in bagno a bere un bicchiere d’acqua. Si ricordò della ragazza e balzò fuori d’un balzo. Sonia era sempre sulla poltrona, rannicchiata. Le offrì una sigaretta che lei rifiutò con un cenno del capo. Se ne accese una, tirò alcune boccate e riprese.
– La signora Adelchi era la quinta della nota. Una strozzina. Una vecchia avida e cattiva e beghina. Insensibile alle necessità del prossimo, sul quale speculava. Ho dato diverse cose a lei, prendendo una miseria. Una volta un orologino di una ragazza che non volle prendere. Non valeva un gran che, ma le chiedevo solo cinquemila lire. Mi ha letteralmente gettato fuori di casa. Sì, lo so che la cosa può sembrare minima, ma quell’orologino l’avevo rubato. Ero disperato. I miei erano morti e avevo fatto i salti mortali per non finire male. Erano altri momenti, forse tu non puoi capire, ma ho veramente sofferto la fame e per quelle cinquemila lire non avute rimasi due giorni senza mangiare e venni sfrattato dalla pensione. L’affogai con piacere lei e il suo bastardaccio che si portava sempre dietro. Le presi anche la pistola che usai più tardi. Ieri, per essere esatti.
– Ieri? E contro chi? – Sonia era esterrefatta.
– Al tempo. Sto facendo una rilettura cronologica. Adesso ci arriviamo. Quando i miei morirono, andai ad abitare presso dei miei parenti piuttosto facoltosi. Il vecchio Lanzi, che io chiamavo nonno, anche se era uno zio di mia madre, mi tenne un po’ con sé, negandomi ogni forma d’affetto, facendomi sentire come quello che mangia pane ad ufo, poi mi spedì da sua nuora, una donna cattiva, avida e gretta. Allora non avevano figli, e speravo di trovare una nuova famiglia, invece mi umiliavano. Io mangiavo gli avanzi e non potevo mai toccare la frutta, mentre lei se ne mangiava a chili, per quello si era anche sformata. Suo marito era più buono, ma completamente succubo. Mi mandarono a lavorare come garzone di panettiere e prendevano loro tutto il mio guadagno, non solo, lei mi faceva anche pulire i pavimenti quando tornavo a casa la sera.
«Un giorno mi ribellai, arrivammo a male parole. Mi diede una sberla che mi rintrona ancora adesso nella testa, fece un fagotto della mia roba e mi gettò per le scale. Fu da lì che incominciai ad arrangiarmi per conto mio. Il vecchio Lanzi era in clinica, sotto una tenda a ossigeno. Quando arrivai io aveva ripreso conoscenza. Anche se non lo avessi ucciso sarebbe morto da solo, ma fui contento di dargli un colpetto. Gli misi davanti alla bocca e al naso il fazzoletto, impedendogli di respirare. Trovai poi sul tavolino una boccettina di Valium, andai dalla vecchia megera, entrai con una scusa e glielo versai nel caffè. Poi aprii il gas e me ne andai quando fui sicuro che non avrebbe potuto chiuderlo. È stato bello quando ho letto sui giornali che si era uccisa per il dolore della morte del suocero. Quella!
Sonia alzò il mento di qualche centimetro e disse: – Sei un mostro!
– Dici? – rispose ironico Massimiliano. – È questione di punti di vista. Sotto il profilo etico-borghese senz’altro. Se penso alla nemesi invece è più che naturale. Io faccio parte della natura e come tale sono una forza equilibratrice. Sì, sono convinto che una tesi del genere non reggerebbe mai in un tribunale, credo che mi prenderebbero per insano.
– Ma lo sei insano – disse la ragazza con rabbia. – Più pazzo di te chi c’è al mondo?
– Perché ho ucciso otto persone? Ma mia cara e stupida fanciulla, capi di stato mandano al massacro migliaia di uomini e se vincono la guerra diventano dei grandi statisti. Vedi come cambiano le cose a seconda dell’ottica? Solo che loro perseguono dei fini egemonici, io invece rendo giustizia a me stesso. È la cosa più giusta, più onesta, visto che rischio del mio. La settima nota è rappresentata da quel vanesio di Rocky, il cantante di moda. Hai sentito la televisione, la radio, la stampa che unanime cordoglio per una vittima così illustre. Sociologhi hanno scritto fiumi di parole insulse e sciocche sul suo suicidio. L’ho ucciso io gettandogli nell’acqua il rasoio elettrico. Lo conoscevo sin dalle commerciali. All’esame di terza questo maiale mi chiese di fargli il tema di italiano in cambio del problema di matematica dove lui era forte. Non è che fossimo tanto amici ma ci si frequentava. Lui aveva già le mire di successo, ma era strisciante, ipocrita e opportunista come pochi. Una dote senz’altro necessaria per fare strada nella vita, ma non ce l’avevo con lui per questo. Gli passai il tema e lui la soluzione del problema. Era sbagliata, ma l’aveva fatto apposta perché la sua era giusta, io fui rimandato. Andai a chiedergli spiegazioni e quel vigliacco mi picchiò quasi a sangue assieme a due sue teppe di amici. Era un istintivo, un violento. Picchiava per il gusto di picchiare. Poi, entrato nel mondo della canzone, si era un po’ ripulito e si dava le arie di portatore del nuovo verbo. Pensa che si è definito il nuovo Messia. Non c’è proprio limite all’imbecillità umana.
Massimiliano si mise a ridere mentre Sonia lo guardava spaventata.
– A chi hai sparato ieri sera? Dimmelo! – implorò.
– Ma certo che te lo dico. L’ottava nota. Ce n’è una stonata che è quella di Sforzi, quella dei Lanzi la calcolo una, anche se in doppia trascrizione. E l’ottava dicevo…
– Ma come puoi, come puoi parlare così di gente che hai ucciso, con questo cinismo. Come se parlassi di un film che hai visto, quasi assente, da spettatore, mentre sei un tragico interprete – urlò la ragazza portandosi le mani alle orecchie.
– Sonia, se urli un’altra volta ti fracasso la mascella! – le ringhiò tra i denti l’uomo che aveva alzato la mano. – Siamo intesi? Non urli più?
La ragazza scosse freneticamente la testa.
– Bene, ora ti racconto l’impresa di ieri sera. La vittima? Quella più appariscente ovvio, mio cugino. Sì, lui, il mio benefattore. Mi ha raccolto che me la passavo male, è vero, mi ha dato un posto nella sua azienda, posto che credo di avere occupato sempre con senso di responsabilità e passione. Lui mi trattava come il suo parente povero, rinfacciandomi sempre di avermi preso con le pezze sul sedere. Non mancava mai occasione di umiliarmi e lo odiavo e lo invidiavo. La mia invidia era per quella sua estrema sicurezza che ha tenuto sin quasi all’ultimo, gliene devo dare atto. Non lo avrei però mai ucciso, se non ci fossero state quelle tre giornate nere della mia vita, quei terribili tre giorni, lunedì, mercoledì e giovedì.
La ragazza teneva il viso coperto. Singhiozzava.
– Il tuo è un capitolo a parte che voglio trattare con più calma. Ma visto che tutto mi è franato addosso, decisi di eliminare pure lui. Ora che è passata una notte devo ammettere di avere provato disgusto nel vedere parte del suo cervello schizzare sul muro. Ho sparato con la pistola della vecchia Adelchi, l’ho usata con riluttanza perché non amo le armi da fuoco e a ragione.
«Mentre correvo per arrivare in tempo alla stazione, ho provato dentro di me un disgusto per tutto quello che avevo fatto. Gli insegnamenti borghesi sono riemersi ed è in cominciata l’autocritica. Mi sono chiesto se avevo veramente il diritto di compiere le mie vendette. Sì, mi sono detto, ma era un sì stonato. Ora ti dico la verità, sono in uno stato di confusione. Dovevo parlartene, anche perché tu sei l’ultima nota della mia composizione, ma l’avevi capito anche tu, vero?
La ragazza tolse le mani e mostrò il suo volto rigato di lacrime. Fece un cenno affermativo con la testa.
– Sonia, sia pure involontariamente, sei tu la causa di tutto. Forse se tu mi avessi veramente capito, se mi avessi dato di più, se ti fossi dedicata completamente a me, sottomettendoti senza riserve, con abnegazione e amore, non sarei giunto a questo punto.
La ragazza scoppiò in singhiozzi mentre bussarono alla porta. Erano le due pomeridiane e il cameriere portava la colazione ordinata.
Il completamento della pièce
Fu un pasto consumato in silenzio. Venne stappata la bottiglia di champagne Krieg in un mutismo assoluto. Entrambi mangiarono abbondantemente senza scambiarsi la minima parola. Bevuta l’ultima goccia, Massimiliano suonò per fare ritirare il tavolo. Poi rimasero guardarsi con occhi disperati. Entrambi.
– Non ci credo, non ci credo, non ci credo – proruppe Sonia agitando le braccia – mi hai mentito. Ti sei inventato tutta questa storia per farmi paura, per agghiacciarmi, per vendicarti di quei maledetti tre giorni, il lunedì, mercoledì e giovedì.
– No, Sonia – rispose mestamente Massimiliano – ho detto la verità.
– Ma non è possibile. A sentirti raccontare certe cose, sembrerebbe che la cosa più semplice del mondo sia quella di andare in giro ad ammazzare la gente. Non ti sei preoccupato, che so, delle impronte, delle tracce che potevi lasciare? Eri trasparente? Qualcuno ti avrà ben veduto, no? Magari senza che tu te ne accorgessi!
– Non me ne sono curato molto infatti, ma c’è una precisa ragione. Chi può andare a rivangare un passato così distante? Nessuno. Nemmeno le mie vittime si ricordavano più di me. Quando dicevo chi ero rimanevano sbigottite. Vedevo che facevano una rapida ricerca nella memoria per trovare il cartellino con scritto il mio nome. Impronte? E non sono un pregiudicato. Una traccia l’ho lasciata, la rivoltella vicino al corpo di mio cugino. Da lì la polizia risalirà alla vecchia Adelchi, ma giunto a questo punto la cosa non ha molta importanza.
«Quando andai alla clinica dove c’era il vecchio Lanzi mi feci vedere dalla suora di guardia all’ingresso, ma poiché per tutti morì naturalmente, nessuno ci fece caso. Anche uscendo dall’Adelchi m’imbattei in una vecchia, forse la portinaia, ma mi guardò appena di sfuggita e per quanto ne so, non ha detto assolutamente nulla alla polizia.
– Ma allora è proprio vero! – esclamò sconfortata Sonia.
– È da parecchio che te lo sto dicendo – affermò l’uomo.
– No, non è possibile. Sei anni che ti frequento e no, non posso crederci.
– Vediamo, come avresti pensato di uccidermi? Strozzandomi? –domandò con un tono di sfida.
– No, non mi voglio mai ripetere. La prima volta partii con un coltello per optare per il collo della bottiglia. Ho quasi sempre improvvisato, perché la cosa mi piaceva di più. Solo con il Serra mi sono portato le forbici che poi ho usato. Mariuccia l’ho strangolata con le sue calze. Sapevo che le avrei trovate. No, non ti strangolerò. Non ho ancora deciso come, ma ho deciso quando: deve essere oggi.
Ma sì, dacci oggi il nostro delitto quotidiano – proruppe la giovane in un riso isterico.
Immagino che la prospettiva di venire uccisa non sia entusiasmante – proseguì freddamente l’uomo, – ma d’altro canto è una forma di elaborazione del destino che ci vuole morti, con la differenza che abbiamo una data precisa contro un momento ignoto che però si sa che deve
avvenire. Quando si è giovani si pensa sempre alla morte come a un qualcosa di distante da noi, più vicina ai vecchi. Andando avanti in età, diciamo superando la barriera della trentina, ci si rende conto che la vita ci sta sfuggendo dalle dita, e allora si fa un riepilogo delle occasioni mancate. Si vuole riguadagnare subito il tempo perduto, arraffare quanto più si può sotto forma di godimento, qualsiasi esso sia. Anch’io ho fatto questo pensiero retroattivo. Ho visto quanto mi è venuto a mancare, quanto non sono stato capace di realizzare. Ho sbagliato tutto o quasi e forse prendermela con quegli otto è stato un alibi. Con questo non voglio essere frainteso, non mi sono affatto pentito di averli uccisi, ma è che alla fine capisco che non ho ottenuto nulla. Tutto è rimasto inalterato. Io, con la mia disperazione, senza speranza.
Si avvicinò alla ragazza e le accarezzò i capelli. Lei non si mosse.
– Quando sono andato nella casa di Marco, a un certo punto volevo prendere e andarmene. Mi sembrava una cosa inutile quella che stavo per fare. Poi arrivò imbellettato e truccato. Mi fece ribrezzo, provai un senso di disgusto e allora pensai a Barbara e sentii dentro di me un furore che doveva assolutamente essere placato. Poi venni preso dalla spirale. Ormai avevo iniziato e tanto valeva che continuassi. Ci presi anche gusto, certo, mi sentivo un dio, un angelo vendicatore che arrivava brandendo la sua spada infuocata e colpiva i rei. C’è un sentimento di possesso e di potenza quando sai di avere nelle tue mani la vita di un tuo simile, che è inarrivabile.
Sonia non sentiva più le parole di Massimiliano. Diventavano dei suoni senza significato che si perdevano in lontananza, mentre la sua mente correva a quel lunedì, il primo dei giorni neri.
– Ciao Sonia, allora ti vengo a prendere alle sette?
– No, mi spiace Max, ma ho un impegno che non posso rimandare. Devo parlare con un agente che vorrebbe un lavoro di controllo di un’enciclopedia fatto in poco tempo. Mi spiace, ma sai questi lavori sono pagati molto bene.
– Ma… allora non ci vediamo. Sono stato via quindici giorni e la prima sera tu preferisci andare a parlare con chissà chi!
– Non te la prendere, cucciolotto. Oggi a mezzogiorno potevo rimanere fuori sino alle tre e starcene insieme, invece hai preferito invitare a pranzo quel tale, che tra l’altro mi è anche antipatico. Sarà per martedì.
– Capisco, buona sera!
Martedì la ragazza dovette andare dal dentista, un appuntamento preso già da oltre un mese e non ci furono problemi. Mercoledì uscì alle sette dall’ufficio e venti minuti dopo era a casa del suo uomo.
– Ha telefonato cinque minuti fa una tua collega. Ha lasciato un numero. Ha pregato di telefonare. Dice che quel lavoro va iniziato stasera invece di domani.
Sonia si ricordò il volto cupo, controllato a fatica, di Massimiliano quando le riferì della chiamata. Si era seduto sul bracciolo della poltrona e aveva appoggiato le mani sulle ginocchia fissandola intensamente. Lei aveva composto il numero.
– Stasera? Alle otto? Sì, parto subito e sono senz’altro puntuale. Ciao.
– Così nemmeno stasera si esce!
– Hai sentito anche tu, no? Ho preso un impegno e devo mantenerlo.
– Già hai fatto una scelta rapida. Senza riflettere hai scelto per l’impegno. Senza considerare che ne hai uno con me, evidentemente io vengo in sott’ordine.
– Ma non è questo. Pagano molto bene, entro sabato è finito e poi sono libera.
– Entro sabato? Bene, sono solo tre giorni, dopo diciassette che non ci si vede. Sei diventata così controllata nei tuoi appetiti sessuali o hai trovato un’altra tavola dove sfamarti?
– Non raccolgo l’insinuazione. Ora scusami ma non posso fare tardi.
– Ma prego, prego, chi ti trattiene? Buon lavoro.
Giovedì la donna ricevette una telefonata alle sette meno cinque.
– Sonia, ti prego, fammi una cortesia, vieni da me.
– Lo sai però che non posso trattenermi? Non farai storie vero?
– Ma no, voglio solo vederti un attimo. Non posso muovermi di casa perché aspetto una chiamata. Ti prego, vieni qui almeno dieci minuti.
Quando entrò nella stanza vide Massimiliano con in mano una bottiglia di champagne, i capelli scarmigliati e gli occhi allucinati.
– Volevo invitarti a un brindisi. Prendi i flutti, sono nel frigorifero. Un brindisi alla fine della nostra avventura.
– Perché parli così, cosa ti succede?
– Perché? Mi sembra chiaro. L’impegno che avevi preso cominciava da oggi, non da ieri. Non ti sei nemmeno consultata con me. Potevi anche non richiamare, oppure dirle che non potevi assolutamente. Gli altri hanno preso un impegno per te, quindi potevi disdirlo. Non l’hai voluto fare, e per che cosa? Per punirmi di lunedì a mezzogiorno? Mi hai snobbato cara ragazza e non posso digerirla questa faccenda, proprio no.
– Ma quante volte mi hai rimandato appuntamenti, quante volte mi hai tenuto sulla corda sino all’ultimo per poi dirmi che non te la sentivi di uscire?
– Allora l’hai fatto per compensare? Sì, posso riconoscere la validità di questo. Se è una rivalsa riconosco di essere ancora in dare.
– No, non è stato così, ma è inutile che ti spieghi. Non vuoi sentire ragioni. Quando ti fissi un’idea in testa non te la cava nessuno.
– Brindiamo quindi alla fine del nostro amore, sempre ammesso che sia mai esistito.
Sonia corse fuori piangendo mentre sentiva un vetro fracassarsi a terra e l’uomo urlare: – Mi hai lasciato solo, solo, solo. – alzò gli occhi. Massimiliano le era appresso e la rimirava pensoso.
– Ti eri addormentata? Avevi chiuso gli occhi.
– No, pensavo a quei famosi tre giorni – rispose alzandosi. – Massimiliano, so che non servirà a farti cambiare idea, ma se è vero che mi vuoi uccidere, so che lo farai – proseguì infilandosi un vestito, – ma ascoltami un momento. Ti dico la verità che non credo ancora che tu abbia veramente ucciso quelle persone, ma ad ogni modo anche se queste ti hanno fatto dei torti ritengo assurdo che si debba sopprimere che ce ne fa. Se tutta l’umanità si comportasse così, sarebbe un massacro solo.
– Infatti di tanto in tanto scoppiano le guerre – rispose freddo l’uomo che non perdeva ogni suo movimento.
– Già, le guerre, e tu hai pensato di farne una tua privata. Una guerra vile, perché non è dichiarata. Ti sei sentito un vendicatore. Ma ti sei mai guardato dentro di te? Cosa pretendi tu dagli altri? Abnegazione, sottomissione, tutti in adorazione del dio Max primo. Io l’ho fatto per un certo tempo perché ero follemente innamorata di te. Poi col tempo mi hai smontata. Ma solo una persona che ti vuole veramente bene può esserti devota come dici tu, ma anche questa ha bisogno di un po’ di calore, non credere che possa eternamente esserti vicino a essere trattata secondo i tuoi capricci.
Si era infilata anche le scarpe e aveva preso la borsetta.
– Dove vuoi andare? – domandò l’uomo minaccioso.
– Non voglio scappare, stanne certo. Non ce la farei. Mi prenderesti. Vorrei uscire , questa stanza mi opprime. Devi ammazzarmi in albergo oppure può andare bene anche fuori?
Il suo compagno si vestì rapidamente senza toglierle gli occhi di dosso e pochi minuti dopo prendevano un battello che li stava portando verso la stazione.
– Torniamo a Milano? Ho lasciato là tutto, già ma che stupida, se devo morire a che mi serve? – esclamò quasi divertita la ragazza. Massimiliano non rispose continuando a fissarla con le sopracciglia inarcate.
Era calato un sottile strato di nebbia che non nascondeva completamente la vecchia città marinara, ma la velava con un drappo funereo. L’acqua era cupa e anche le onde tagliate dallo scafo si rivoltavano dentro per mischiarsi in una tranquillità senza luce.
– Guida tu! – ordinò imperiosamente l’uomo. La donna obbedì senza fiatare.
– Dove devo andare?
– Prendi l’autostrada.
Per diversi chilometri sotto la cappa di un cielo ramato che sembrava volerli soffocare, poi l’auto si fermò in una piazzola di parcheggio.
– Perché mi hai fatto fermare, Max? Mi uccidi qui? – domandò rassegnata Sonia.
L’interrogato annuì. La ragazza tentò di sorridere senza riuscirci. Passò una mano sulla fronte del suo uomo, gli scompigliò i capelli e gli diede un bacio sulle labbra senza essere ricambiata.
– Va bene, Max, fai pure, io sono pronta – e chiuse gli occhi. Sentì il collo afferrato da due mani robuste. Gli indici puntati alla gola. Ma non ci fu pressione per diverso tempo. Riaprì gli occhi. – Cosa c’è Max? Non ne hai il coraggio? Fallo ti prego, io non ho più voglia di vivere e sono troppo codarda per ammazzarmi.
Rimasero a rimirarsi per alcuni minuti in un muto colloquio. L’uomo l’accarezzò lievemente, lentamente.
– Ti ricordi la prima volta che siamo stati a Venezia?
– Come potrei dimenticarlo? È stato cinque anni fa? Tre giorni meravigliosi.
– Allora era tutto diverso. Siamo cambiati entrambi quasi senza che ce ne accorgessimo. Un vero peccato.
– Sì – rispose Sonia socchiudendo stancamente gli occhi. – Max io ti ho tanto amato, e forse ti amo ancora. Non ne sono sicura, ma sono anche molto frastornata, con tutto quello che mi hai detto. Mi sono abituata a non avere domani. Tu sei un tipo su cui non si può mai fare conto – una pausa – le hai uccise per davvero quelle persone?
– Sì.
– Oh povero Max, sono tanto dispiaciuta per te.
– È troppo tardi per dispiacersi – mormorò quasi a se stesso. Rimase un attimo fisso a osservarla poi uscì di scatto dalla macchina sfilando le chiavi d’avviamento. Chiuse il suo sportello e fece altrettanto con quello dalla parte della guida. Sonia cercò di abbassare il vetro, ma dopo averlo aperto di poche dita vide che si era bloccato.
– Non funziona, e nemmeno quell’altro. Questa è la tua bara, Sonia.
– Cosa vuoi fare? – domandò disperata.
Senza rispondere Massimiliano svitò il tappo del serbatoio per infilarci la cravatta. La ritirò poco dopo madida di benzina. Ne lasciò dentro un capo e con l’accendino diede fuoco all’altro.
– Addio Sonia – urlò sovraeccitato, – anch’io ti amo!
La fiamma raggiunse rapidamente il serbatoio che s’incendiò. L’uomo si allontanò a passi rapidi osservando la ragazza che urlava in preda al panico, mentre batteva violentemente i pugni sui vetri. Saltò il guard-rail e si fermò ad aspettare lo scoppio che avvenne poco dopo. Rimase ritto impalato a osservare la carcassa carbonizzata dell’utilitaria, poi si mise a correre contro il traffico.
«È finita, la mia pièce è compiuta. Non credevo che ce l’avrei fatta, temevo proprio il coraggio con Sonia. Ora tutto è finito sul serio. Ho compiuto dei delitti perfetti! Potranno collegare quello di Ettore con quello della vecchia Adelchi per via della pistola, ma gli altri mai! Che vuole quell’idiota di Porsche? Mi butta i fari in faccia e mi urla dietro qualcosa. Lo so benissimo che sto correndo contro traffico. Mi piace sentire lo scalpiccio delle suole sull’asfalto! Corro spedito come il vento. Ansimo un po’ ma le mie gambe sono belle sciolte, non riuscirei a fermarmi neanche se volessi! Quel camion mi ha visto mentre sta eseguendo il sorpasso. Segnala con le luci, suona il clacson, tenta di rientrare per evitarmi.
Il cuore mi batte quasi in gola, ho il fiatone e mi duole anche la milza, ma resisto a correre. Chiudo gli occhi e getto il capo all’indietro. L’aria mi taglia la faccia, è inebriante. Sono appresso al camion di pochi metri, mi metto in mezzo alla corsia e sento uno stridere di freni».
fine